- Libri preferiti
Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti
Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Le Tesi su Feuerbach (Thesen über Feuerbach) sono un breve scritto di Karl Marx, elaborato nell'aprile del 1845, e riportato alla luce da Friedrich Engels dopo la morte dell'autore. Le Tesi furono pubblicate come appendice da Engels nel suo scritto del 1888 dedicato al Feuerbach e intitolato Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie. Mit Anhang: Karl Marx über Feuerbach v. J. 1845. (Ludwig Feuerbach e il punto di approdo della filosofia classica tedesca. In appendice: Karl Marx su Feuerbach). Questo scritto, oltre a essere un completo superamento delle concezioni feuerbachiane, mostra la fondazione di una filosofia storicamente del tutto originale, la filosofia della prassi, una gnoseologia che può ricevere conferma soltanto dall'attività rivoluzionaria volta alla liberazione dell'uomo dall'alienazione sociale.

Karl Marx eredita, rielaborandola, la teoria del valore dei classici, secondo cui la fonte ultima del valore è il lavoro, e nello stesso tempo opera una rottura nei loro confronti. Quello che mutua è l'idea, già rintracciabile in Adam Smith e fatta propria da David Ricardo, che il lavoro sia la fonte della ricchezza e che il valore sia determinato dalla quantità di lavoro contenuto nelle merci (lavoro incorporato). Marx tuttavia si distacca dai classici perché rifiuta una rappresentazione del modo di produzione capitalistico come qualcosa di a-storico, naturale ed eterno, sostenendo invece l'idea secondo cui la società capitalistica non è che una tappa dello sviluppo storico dell'umanità. Respinge inoltre la definizione del capitale come insieme dei mezzi di produzione, ma lo considera come un qualcosa di storicamente determinato, avente un carattere sociale specifico e non dato in natura una volta per tutte. Il capitalismo è dunque per Marx un modo di produzione transitorio, caratterizzato dalla separazione dei mezzi di produzione dai lavoratori e dalla massima diffusione della produzione mercantile. In tale ottica il valore non è più una proprietà "naturale", ma risulta connesso alle determinazioni specifiche, storiche di tale modo di produzione.
Nelle scienze sociali, la struttura sociale è l'organizzazione sociale modellata nella società che è sia emergente che determinante delle azioni degli individui. Sulla scala macro, la struttura sociale è il sistema di stratificazione socioeconomica (ad es. La struttura di classe), le istituzioni sociali o altre relazioni modellate tra grandi gruppi sociali. Sulle meso scale di un pesce, è la struttura dei legami dei social network tra individui o organizzazioni. Sulla micro scala, può essere il modo in cui le norme modellano il comportamento degli individui all'interno del sistema sociale. Le norme sociali influenzano la struttura sociale attraverso i rapporti tra la maggioranza e la minoranza. Perché quelli che si allineano con la maggioranza sono considerati normali mentre quelli che si allineano con la minoranza sono considerati anormali, le relazioni della maggioranza-minoranza creano una stratificazione gerarchica all'interno delle strutture sociali che favorisce la maggioranza in tutti gli aspetti della società. Queste scale non sono sempre tenute separate. Ad esempio, la recente studiosa di John Levi Martin ha teorizzato che certe strutture macro-scala sono le proprietà emergenti delle istituzioni culturali micro-scala (questo significato di "struttura" assomiglia a quello usato dall'antropologo Claude Lévi-Strauss). Allo stesso modo, un altro studio recente, in etnografia, descrive come la struttura sociale indigena nella Repubblica di Panama abbia cambiato le macro strutture sociali e impedito l'espansione pianificata del Canale di Panama. [1] La sociologia marxista ha anche una storia di mescolanza di significati diversi della struttura sociale, sebbene lo abbia fatto semplicemente trattando gli aspetti culturali della struttura sociale come epifenomeni di quelli economici. Dagli anni '20, il termine è stato in generale utilizzato nelle scienze sociali [2], in particolare come una variabile le cui sottocomponenti dovevano essere distinte in relazione ad altre variabili sociologiche. Panoramica: La nozione di struttura sociale come relazione tra diverse entità o gruppi o come modelli di relazione duraturi e relativamente stabili sottolinea l'idea che la società è raggruppata in gruppi strutturalmente correlati o insiemi di ruoli, con funzioni, significati o scopi diversi. Un esempio di struttura sociale è l'idea di "stratificazione sociale", che fa riferimento all'idea che la maggior parte delle società sono separate in diversi strati (livelli), guidati (anche se solo parzialmente) dalle strutture sottostanti nel sistema sociale. Questo approccio è stato importante nella letteratura accademica con l'affermarsi di varie forme di strutturalismo. È importante nello studio moderno delle organizzazioni, perché la struttura di un'organizzazione può determinare la sua flessibilità, la capacità di cambiare e molti altri fattori. Pertanto, la struttura è un problema importante per la gestione. Si può vedere che la struttura sociale influenza importanti sistemi sociali tra cui il sistema economico, il sistema legale, il sistema politico, il sistema culturale e altri. Famiglia, religione, legge, economia e classe sono tutte strutture sociali. Il "sistema sociale" è il sistema genitore di quei vari sistemi che sono incorporati in esso.
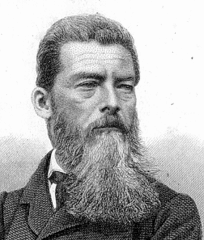
Ludwig Andreas Feuerbach (Landshut, 28 luglio 1804 – Rechenberg, 13 settembre 1872) è stato un filosofo tedesco tra i più influenti critici della religione ed esponente della sinistra hegeliana.

Gaetano Filangieri (San Sebastiano al Vesuvio, 22 agosto 1753 – Vico Equense, 21 luglio 1788) è stato un giurista e filosofo italiano del Regno di Napoli. È ritenuto uno dei massimi giuristi e pensatori italiani del XVIII secolo.
Le critiche al comunismo sono state dirette sia ai principi stessi del comunismo sia alla loro attuazione negli stati socialisti del XX secolo. Il dibattito è acceso in quanto per alcuni intellettuali tra cui Ludwig von Mises il comunismo in tutte le sue forme conduce necessariamente al totalitarismo, per altri tra cui Luigi Berlinguer il vero comunismo non si è mai realizzato, tutti i regimi autodefinitisi comunisti o socialisti erano in realtà in regime di capitalismo di Stato, e gli stati a socialismo reale non abbiano rispettato i principi marxisti a cui si erano ispirati.Nel corso del novecento vari esponenti del mondo ideologico e culturale comunista hanno mosso critiche verso le politiche concretamente adottate dai governi dei paesi comunisti. ad esempio nel caso dei trotskisti. Un eventuale "reverso" che veda pensatori non comunisti d'accordo con politiche concrete adottate dai summenzionati governi risulta almeno a una prima analisi non specifica, più raro.

Henri-Benjamin Constant de Rebecque (Losanna, 25 ottobre 1767 – Parigi, 8 dicembre 1830) è stato uno scrittore, politico, scienziato politico, nobile ed intellettuale francese di origine svizzera.

Carl Gustav Jung (AFI: [ karl staf j ]; Kesswil, 26 luglio 1875 K snacht, 6 giugno 1961) stato uno psichiatra, psicoanalista, antropologo, filosofo e accademico svizzero, una delle principali figure intellettuali del pensiero psicologico e psicoanalitico. La sua tecnica e teoria, di derivazione psicoanalitica, chiamata "psicologia analitica" o "psicologia del profondo", pi raramente "psicologia complessa".Inizialmente vicino alle concezioni di Sigmund Freud, se ne allontan nel 1913, dopo un percorso di differenziazione concettuale culminato con la pubblicazione, nel 1912, di La libido: simboli e trasformazioni. In questo libro egli esponeva il suo orientamento, ampliando la ricerca analitica dalla storia del singolo alla storia della collettivit umana. C' un inconscio collettivo che si esprime negli archetipi, oltre a un inconscio individuale (o personale). La vita dell'individuo vista come un percorso, chiamato processo di individuazione, di realizzazione del s personale a confronto con l'inconscio individuale e collettivo. In Italia, l'orientamento junghiano della psicoanalisi stato introdotto da Ernst Bernhard.
In senso giuridico, con il termine capitalismo ci si riferisce a quegli ordinamenti statuali che pongono il capitale (il reddito, la proprietà, ecc.) al centro della tutela costituzionale.In economia, il capitalismo è un sistema economico in cui imprese e/o privati cittadini possiedono mezzi di produzione, ricorrendo spesso al lavoro subordinato per la produzione di beni e servizi a partire dalle materie prime lavorate, al fine di generare un profitto attraverso la vendita diretta o indiretta ad acquirenti degli stessi. Tale produzione, basata sulla domanda e sull'offerta nel mercato generale di tali prodotti, è nota come economia di mercato, contrapposta all'economia pianificata, caratterizzata invece da una pianificazione centrale da parte dello Stato. Anziché pianificare le decisioni economiche attraverso metodi politici centralizzati, come nel caso del feudalesimo e del socialismo, sotto il capitalismo tali decisioni sono del tutto decentralizzate ovvero nate sulla base di libere e volontarie iniziative dei singoli imprenditori.