- Libri preferiti
Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti
Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

I trattati Roma-Cartagine ebbero fondamentale importanza per le relazioni non solo diplomatiche tra le due potenze, ma anche nei confronti dei Greci di Sicilia e d'Italia, che in Siracusa videro l'ultimo baluardo della grecità nell'area del Mediterraneo centro-meridionale.Roma e Cartagine: due città-stato che riuscirono a diventare imperi, a un certo punto della loro esistenza ebbero la necessità di regolare le reciproche convenienze, le rispettive zone di influenza. Per secoli le due città operarono fianco a fianco e perfino da alleate. Gli interessi economici e le metodologie di espansione erano infatti simmetrici. Roma non guardava al mare, poiché ancora impegnata a difendersi dai vicini Sabelli, Etruschi, Galli e Greci, per conquistare l'egemonia in Italia; Cartagine, senza un vero esercito cittadino e costretta a combattere contro i Greci di Cirene, di Massilia e di Siracusa in Sicilia, nelle più lunghe guerre dell'antichità classica (cfr. le guerre greco-puniche), appariva pronta a sostenere le sue conquiste, solo dopo un'attenta valutazione dei costi e relativi benefici che ne sarebbero derivati; e se il partito aristocratico tendeva a estendere il potere della città nelle terre circonvicine, il partito commerciale era più portato allo sfruttamento di rotte ed empori nel Mediterraneo occidentale, grazie anche alla qualità della sua flotta.Tutti questi trattati non sarebbero bastati a fermare le ostilità tra le due potenze del Mediterraneo occidentale, ma con la loro stipula e osservanza, le relazioni fra Roma e Cartagine seguirono per secoli una rotta di reciproca tolleranza.

La terza guerra punica fu combattuta fra Cartagine e la Repubblica di Roma fra il 149 a.C. e il 146 a.C. Fu l'ultima delle tre guerre fra le antiche civiltà del Mar Mediterraneo.
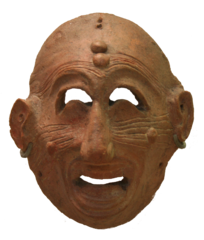
La storia di Cartagine non è facile da studiare almeno nella sua componente fenicio - punica a causa della sua sottomissione da parte dei romani alla fine della terza guerra punica nel 146 a.C. Restano in effetti che poche fonti primarie cartaginesi e quelli disponibili sollevano più domande piuttosto che aiutare nella comprensione della storia della città. Alcuni testi punici sono stati tradotti in greco o latino, come iscrizioni su monumenti del Nord Africa. Tuttavia, la maggior parte delle fonti rimane disponibile attraverso autori greci e romani: Tito Livio, Polibio, Appiano, Cornelio Nepote, Silio Italico, Plutarco, Dione Cassio ed Erodoto. Questi autori provengono da culture spesso in rivalità con Cartagine: i Greci contestarono il primato in Sicilia e i Romani entrarono in guerra contro la città. Queste fonti scritte da stranieri non sono sempre prive di pregiudizi. Tuttavia, recenti scavi hanno scoperto fonti primarie più affidabili, sebbene rimangano insufficienti; il prodotto di alcuni scavi conferma gli aspetti della vita a Cartagine come descritti da autori antichi, ma altri no, molte scoperte rimangono ancora poco probanti. Come tutte le stazioni commerciali fenicie, Cartagine deve, in segno di fedeltà e pietà, rendere omaggio a Tiro. Tuttavia, il declino di quest'ultima contro l'avanzata dei Greci avrebbe incoraggiato la città punica a diventare indipendente durante la seconda metà del VII secolo a.C. Un secolo e mezzo dopo la fondazione della città, i Cartaginesi si stabilirono nelle Isole Baleari, secondo un'interpretazione di un testo di Diodoro Siculo, quindi dominarono la parte occidentale della Sicilia, la Sardegna meridionale e, alleati degli Etruschi, respinsero i Greci fuori dalla Corsica durante la battaglia di Alalia dal 540 al 535 a.C. Hanno poi controllato tutto il commercio e la navigazione nel Mediterraneo occidentale, e hanno conquistato molti territori all'interno e al di fuori dell'Africa: Mauretania, Numidia, Iberia, Ibiza, Sicilia, Sardegna e Corsica. Come nel caso di Roma, sua nemica mortale, il nome della città comprende tutti i territori sotto la sua giurisdizione. La terra di Sicilia è un luogo di confronto dei punici e dei Greci nel lungo ciclo delle guerre siciliane V-IV sec. a.C. L'isola è la fonte del primo ciclo delle guerre puniche tra la Repubblica Romana e la potenza cartaginese e si conclude con la sconfitta di quest'ultima. La città riesce a riprendersi, soprattutto a causa delle conquiste nella penisola iberica, ma la seconda guerra punica con l'epopea di Annibale Barca termina anche con la sconfitta e la fine dell'imperialismo cartaginese. L'ultimo conflitto è irregolare, anche se la città resiste tre anni prima di essere annientata. Dopo la distruzione del 146 a.C., la città viene ricostruita dai vincitori e ribattezzata Colonia Iulia Karthago, anche se non riacquista mai l'importanza che era sua: trova, tuttavia, una certa aura attraverso il suo ruolo di capitale proconsolare e il suo ruolo importante nella diffusione del cristianesimo. Dalla conquista vandalica, tuttavia, la città occupa un ruolo sempre più secondario, il Medioevo vede, se non il suo abbandono, almeno una bassa occupazione del sito.

La prima guerra punica (264 - 241 a.C.) fu la prima di tre guerre combattute tra l'Antica Cartagine e la Repubblica romana. Vero e proprio esempio di guerra di logoramento, durò oltre 20 anni e vide le due potenze scontrarsi per acquisire la supremazia nel Mar Mediterraneo occidentale, principalmente combattendo in Sicilia, allora ricchissimo centro dei commerci marittimi del Mediterraneo e politicamente suddivisa tra più potenze. La Repubblica romana risultò vincitrice al termine della guerra e impose a Cartagine pesanti sanzioni economiche.La serie di guerre tra Roma e Cartagine furono chiamate dai romani "guerre puniche", dal nome in latino con il quale venivano chiamati i cartaginesi: Punici, derivato da Phoenici, in riferimento alle origini fenicie del popolo.

Le guerre puniche furono tre guerre combattute fra Roma e Cartagine tra il III e II secolo a.C., che si risolsero con la totale supremazia di Roma sul mar Mediterraneo; supremazia diretta nella parte occidentale e controllo per mezzo di regni a sovranit limitata nell'Egeo e nel mar Nero. Sono conosciute come puniche in quanto i romani chiamavano punici i Cartaginesi. A sua volta il termine punico una corruzione di fenicio, come Cartagine una corruzione del fenicio Qart Hadash (citt nuova).
L'inizio dell'espansione cartaginese in Italia - sotto l'ottica non puramente commerciale ma territoriale e quindi militare - si può far risalire alla spedizione di Malco in Sicilia, attorno al 550 a.C. Fino ad allora infatti, Cartagine aveva tratto le sue ricchezze dal commercio nel mondo mediterraneo e dalla presenza della flotta a protezione delle rotte commerciali.

Annibale Barca (in latino: Hannibal; in greco antico: Ἁννίβας, Hanníbas; Cartagine, 247 a.C. – Lybissa, 183 a.C.) è stato un condottiero e politico cartaginese, famoso per le sue vittorie durante la seconda guerra punica e definito da Theodor Mommsen "il più grande generale dell'antichità". Figlio del comandante Amilcare Barca e fratello maggiore di Asdrubale, Annibale, sin da piccolo profondamente nemico di Roma e deciso a combatterla, concepì ed eseguì un audace piano di guerra per invadere l'Italia. Marciando dalla Spagna, attraverso i Pirenei e le Alpi, scese nella penisola, dove sconfisse le legioni romane in quattro battaglie principali: battaglia del Ticino (218 a.C.), battaglia della Trebbia (218 a.C.), battaglia del lago Trasimeno (217 a.C.), battaglia di Canne (216 a.C.) – e in altri scontri minori. Dopo la battaglia di Canne i Romani evitarono altri scontri diretti e gradualmente riconquistarono i territori del sud Italia di cui avevano perso il controllo. La seconda guerra punica terminò con l'attacco romano a Cartagine, che costrinse Annibale al ritorno in Africa nel 203 a.C., dove fu definitivamente sconfitto nella battaglia di Zama, nel 202 a.C.. Dopo la fine della guerra Annibale guidò Cartagine per alcuni anni, ma fu costretto all'esilio dai Romani e nel 195 a.C. si rifugiò dal re seleucide Antioco III in Siria, dove continuò a propugnare la guerra contro Roma. Dopo la sconfitta di Antioco III si trasferì presso il re Prusia I, in Bitinia. Quando i Romani chiesero a Prusia la sua consegna, Annibale preferì suicidarsi; era il 183 a.C. Dotato di grandi capacità tattiche e strategiche, avveduto e sagace, Annibale, dopo le impressionanti vittorie iniziali, continuò a battersi tenacemente in Italia per oltre quindici anni con il suo piccolo esercito di veterani isolato in territorio nemico, cercando fino all'ultimo di contrastare il predominio di Roma. Per le straordinarie qualità dimostrate durante la sua carriera militare, Annibale è considerato uno dei più grandi generali e strateghi della storia. Polibio, suo contemporaneo, lo paragonava al suo grande rivale Publio Cornelio Scipione Africano; altri lo hanno accostato ad Alessandro Magno, Giulio Cesare e Napoleone.

Andrea Carandini (Roma, 3 novembre 1937) è un archeologo e accademico italiano.
La provincia romana d'Africa, in seguito anche Africa Proconsolare, corrispose inizialmente al territorio adiacente a Cartagine e si estese successivamente, a spese del regno di Numidia, lungo le coste del Maghreb, comprendendo i territori occupati oggi dalla Tunisia (ad esclusione della sua parte desertica), la costa orientale dell'Algeria e quella occidentale della Libia. Il nome proviene con tutta probabilità da quello della tribù berbera indigena degli Afri, tramandato fino al giorno d'oggi come Africa a indicare l'intero continente nelle lingue europee e come Ifrīqiya a indicare l'attuale Tunisia in lingua araba.