- Libri preferiti
Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti
Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti
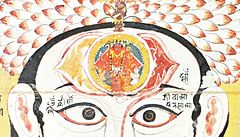
Il termine appercezione sta a indicare una forma particolare di percezione mentale, che si distingue per chiarezza e consapevolezza di sé. Fu introdotto dal filosofo Leibniz per definire la "percezione della percezione", ossia la percezione massima perché situata al più alto livello di autocoscienza. In Kant è nota altrimenti come "io penso".
Per genio, dal latino genius, sostantivo derivato dal verbo geno ("generare", "creare"), quindi "forza naturale produttrice", si intende quella speciale attitudine naturale atta a produrre opere di importante rilevanza artistica, scientifica, etica o sociale. Tale disposizione naturale può anche essere portata alla luce con l'educazione, ma difficilmente può essere trasmessa ad altri (i figli o i discepoli dei geni molto raramente eguagliano i padri o i maestri). Il termine genio può anche genericamente indicare la persona stessa in possesso di tale eccezionale abilità. . Del genio tratta quella branca della filosofia che si occupa dell'estetica.

Il Sublime (dal latino sublimis, oppure nella variante sublimus, composto da sub-, "sotto", e limen, "soglia"; quindi propriamente: "ciò che è al limite", ovvero di sub-, "sotto", e limen-, "soglia", propriamente "che giunge fin sotto la soglia più alta") è una categoria estetica che risale all'antichità classica e successivamente al Romanticismo.

L'obiettivo principale del pensiero di Immanuel Kant è quello di identificare le condizioni entro le quali una conoscenza possa essere ritenuta valida sia nel campo delle nuove scienze della natura sia in quelle tradizionali della metafisica, dell'etica, della religione e dell'estetica. Nella matematica e nella fisica l'uomo esprime giudizi universali e necessari astraendo dai dati diretti dell'esperienza sensibile. L'illuminismo aveva visto in questo il segno evidente di ciò a cui può giungere la ragione, ma lo scetticismo di Hume aveva contestato i fondamenti teorici della moderna scienza galileiana e newtoniana. Kant sente quindi l'esigenza di ritrovare sicure basi teoriche e di identificare i fondamenti filosofici che rendono possibile all'uomo il trascendere i dati empirici immediati, limitati e contingenti con l'obiettivo di giungere a conoscenze universali e necessarie. La metafisica era giunta alla conclusione di potersi porre come una vera e propria scienza in grado di offrire all'uomo verità certe. Kant si domanda se questo avventurarsi della ragione oltre i limiti dell'esperienza sia un percorso coerente e certo per comprendere e dare fondamento alle idee metafisiche di Dio, dell'immortalità dell'anima, delle leggi morali universali. Kant, seguendo l'impronta illuministica del suo tempo, crede che tutte queste problematiche possano risolversi solo sottoponendole all'esame critico della ragione:

Idealismo assoluto è una concezione idealistica che andando oltre quella semplicemente gnoseologica o trascendentale di Kant, si presenta non solo come sistema della conoscenza, ma anche dottrina esaustiva della totalità del reale, riconducendola alla supremazia del proprio Pensiero Ideale, non lasciando nulla fuori di sé.Kant aveva definito «trascendentale» o formale il suo idealismo conoscitivo, sostenendo che è il soggetto umano a modellare, secondo leggi a priori, gli oggetti della conoscenza, ma non al punto da crearli materialmente da solo. In tal modo, al di là dei fenomeni su cui si esercita l'attività del soggetto, egli aveva posto un impenetrabile noumeno o cosa in sè, dando luogo a un dualismo in grado di togliere stabilità alla sua stessa teoria della conoscenza. Per darle coerenza e organicità, Fichte rimosse pertanto quel suo residuo realistico, trasformandola in idealismo assoluto, fondato sulla capacità intuitiva-intellettuale del soggetto di accedere al noumeno, in cui il conoscere cioè fosse al contempo un creare, seppure in maniera inconscia. Non ammettendo nient'altro oltre l'Io, quest'ultimo diventa assoluto perché il non-io viene reso una sua parte, posta inconsciamente come ostacolo per realizzare se stesso sul piano etico. Schelling, che per primo ricorse al termine idealismo assoluto, obiettò a Fichte che il suo idealismo, pur presentandosi come assoluto e coerente, era ancora parziale, essendo soltanto un ideale trascendentale, da realizzare in una prospettiva etica infinita. E gli oppose il proprio idealismo, assoluto e al contempo trascendentale, perché in esso soggetto e oggetto, forma e contenuto, sono uniti immediatamente nell'Assoluto, quale realtà incondizionata già realizzata a priori nell'autocoscienza dell'intuizione intellettuale, atto conoscitivo e produttivo insieme in cui consiste l'idealismo stesso.Una tale visione dell'Assoluto fu contestata a sua volta da Hegel quale unità indifferenziata in cui gli opposti si smarriscono in un generico anonimato, paragonato ad una «notte in cui tutte le vacche sono nere». Idealismo autenticamente assoluto è per Hegel quello in cui gli opposti, anziché essere uniti immediatamente, realizzano quest'unione in forma mediata, attraverso un processo dialettico caratterizzato dall'interazione tra una tesi e un'antitesi risolta da una sintesi che, superandole, rappresenta la loro confutazione e al contempo conservazione.Idea, Natura, e Spirito sono i tre momenti principali di questo percorso idealistico, assoluto perché la Ragione, attraverso i vari passaggi, giunge infine a diventare consapevole di sè come unica Realtà assoluta, che tutto comprende. La Coscienza si rispecchia nel mondo grazie all'unità di pensiero ed essere, non più espressa come identità astratta A = A {\displaystyle A=A} , ma raggiunta attraverso un processo dinamico e storico che tenga conto della loro ricchezza e differenze. L'idealismo assoluto, in definitiva, è l'intento dello Spirito di dimostrare, e così realizzare, questa stessa unità.Hegel lo definì «assoluto» presentandolo come la sintesi compiuta dell'idealismo di Fichte da un lato, da lui denominato «soggettivo» perché sbilanciato verso l'attività critica e agente del soggetto, e di quello schellinghiano dall'altro, designato viceversa come «oggettivo» perché vedrebbe l'idealismo dalla parte inconscia e dogmatica dell'oggetto.L'idealismo assoluto dei tre filosofi tedeschi e in particolare di Hegel, da cui nasceranno le scuole contrapposte della Destra e della Sinistra hegeliana, esercitò una forte influenza sulla filosofia della religione del mondo anglo-sassone. Ad esso si rifaranno gli esponenti dell'idealismo britannico quali Hill Green, Caird, Bradley, Bosanquet, Wallace, Caird, mentre in America lo sviluppo del pensiero hegeliano si mosse come in Josiah Royce verso il pragmatismo.In Germania si ebbe un ritorno all'hegelismo assoluto (Neuhegelianismus) ai primi del Novecento nell'ambito del neokantismo ad opera di Kroner, mentre in Francia si segnala Kojève. In Italia esso venne riformulato dal neoidealismo storicista di Croce, e da quello attualista di Gentile. Riprendendo l'interpretazione che ne aveva dato Spaventa, Gentile riconciliò l'hegelismo con l'idealismo fichtiano, sostenendo che l'Assoluto non è un fatto, o un concetto definibile in maniera compiuta, bensì un atto, un pensare perennemente in divenire, ossia un agire mai concluso. L'idealismo gentiliano volle essere pertanto sia trascendentale, perché risolveva il mondo nell'autocoscienza dello Spirito pensante inteso come soggettività e come conoscere; ma anche «assoluto» in senso hegeliano, perché una tale autocoscienza è una totalità oggettiva risultante da una mediazione dialettica, raggiunta attraverso l'estraniarsi nell'altro da sé. La dialettica tuttavia, per Gentile, attiene solo al pensiero pensante, non può essere costruita con elementi statici propri del pensiero pensato.Quello di Hegel, secondo Gentile, era quindi un idealismo ancora parziale, essendo approdato a un risultato ritenuto definitivo, immutabile, situato al culmine dello sviluppo dello Spirito, e pertanto estraneo alla totalità del suo eterno fluire. Il processo con cui il Pensiero giunge a prodursi, invece, articolandosi nei tre momenti dell'arte, della religione e della filosofia, non può essere anteriore all'atto con cui il pensiero si pensa, ma coincide con questo medesimo atto, perché non si possono formulare pensieri privi della coscienza di formularli. Solo identificandosi nella consapevolezza di questo atto vivo del pensare, l'idealismo può dirsi assoluto:

La filosofia (in greco antico: , philosoph a, composto di (phile n), "amare", e (soph a), "sapienza", ossia "amore per la sapienza") un campo di studi che si pone domande e riflette sul mondo e sull'essere umano, indaga sul senso dell'essere e dell'esistenza umana, tenta di definire la natura e analizza le possibilit e i limiti della conoscenza. Prima ancora che indagine speculativa, la filosofia fu una disciplina che assunse anche i caratteri della conduzione del "modo di vita", ad esempio nell'applicazione concreta dei principi desunti attraverso la riflessione o pensiero. In questa forma, essa sorse nell'antica Grecia. A rendere complessa una definizione univoca della filosofia concorre il dissenso tra i filosofi sull'oggetto stesso della filosofia: alcuni orientano l'analisi della filosofia verso l'uomo e i suoi interessi cos come viene esposto nell'Eutidemo di Platone, per cui essa sarebbe l'uso del sapere a vantaggio dell'uomo .Nel prosieguo della storia della filosofia altri autori che seguono questa opinione sono per esempio Cartesio ( Tutta la filosofia come un albero, di cui le radici sono la metafisica, il tronco la fisica, e i rami che sorgono da questo tronco sono le altre scienze, che si riducono a tre principali: la medicina, la meccanica e la morale, intendo la pi alta e la pi perfetta morale, che presupponendo una conoscenza completa delle altre scienze, l'ultimo grado della saggezza ), Thomas Hobbes, e Immanuel Kant, il quale, definisce la filosofia come scienza della relazione di ogni conoscenza al fine essenziale della ragione umana .Altri pensatori ritengono che la filosofia debba puntare alla conoscenza dell'essere in quanto tale secondo un percorso che, fatte le debite differenze, va dagli eleati sino a Husserl e Heidegger.

L'idealismo in filosofia è una visione del mondo che riconduce totalmente l'essere al pensiero, negando esistenza autonoma alla realtà, ritenuta il riflesso di un'attività interna al soggetto. Nell'idealismo è generalmente implicita una concezione etica fortemente rigorosa, come ad esempio nel pensiero di Fichte che è incentrato sul dovere morale dell'uomo di conformare il mondo al principio ideale da cui esso ha origine. In un senso più ampio, il termine è stato utilizzato in riferimento anche a diversi altri sistemi filosofici (come il platonismo), che privilegiano la dimensione ideale rispetto a quella materiale, affermando così che l'unico vero carattere della realtà sia di ordine spirituale.
Giovanni Gentile (Castelvetrano, 29 maggio 1875 – Firenze, 15 aprile 1944) è stato un filosofo, pedagogista, politico e accademico italiano. Fu insieme a Benedetto Croce uno dei maggiori esponenti del neoidealismo filosofico e dell'idealismo italiano, nonché un importante protagonista della cultura italiana nella prima metà del XX secolo, cofondatore dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana e, da ministro, artefice, nel 1923, della riforma della pubblica istruzione nota come Riforma Gentile. La sua filosofia è detta attualismo. Inoltre fu figura di spicco del fascismo italiano, considerato persino egli stesso l'inventore dell'ideologia del fascismo. In seguito alla sua adesione alla Repubblica Sociale Italiana, fu assassinato durante la seconda guerra mondiale da alcuni partigiani dei GAP.

Il criticismo è un indirizzo filosofico che si propone di studiare e giudicare i problemi della conoscenza filosofica scomponendoli in problemi elementari, per cercare di risolverli. Esso restringe in tal modo il campo di indagine della filosofia, ma ritiene al contempo di acquisire una maggiore sicurezza sulla veridicità delle affermazioni che vengono fatte al suo interno. Il metodo di cui si serve consiste nel criticare o analizzare la ragione tramite la ragione stessa, in modo da scoprirne i limiti e poter così giudicare fondati o infondati alcuni dei principi che essa suole affermare. Il criticismo è stato chiamato anche filosofia del limite, in quanto tende a limitare o a circoscrivere le possibilità della conoscenza umana, per quanto in questo modo essa riesca ad approdare a forme di sapere più sicuro. Il criticismo, in fin dei conti, è un'analisi della ragione umana, che diventa insieme giudice e imputato nel tentativo di scoprire cosa può realmente conoscere e affermare con certezza.Il maggior esponente di questa corrente filosofica è il pensatore tedesco Immanuel Kant, che ricorse alla metafora della colomba per illustrare come, a suo modo di vedere, i limiti imposti all'intelletto siano in realtà costitutivi della sua stessa possibilità di muoversi e di conoscere: