- Libri preferiti
Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti
Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti
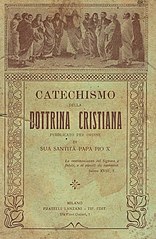
Il Catechismo di Pio X è una sintesi di un catechismo unico del Congresso Catechistico Nazionale svolto a Piacenza nel 1889 e quando divenne papa Pio X, nella Cattedra di San Pietro dopo due anni, venne esposto come disciplina con l'enciclica Acerbo Nimis e richiesto per la diocesi di Roma; è strutturato in domande brevi con relativa risposta. Il testo fu successivamente adottato in tutta Italia.

Il catechismo, κατηχισμός dal greco katechéo "istruisco oralmente" (kata, “con” ed echos, nell'accezione di ”voce”), è un sommario o esposizione didattica di una dottrina, esteso linguisticamente a ideologia, e religione. Il termine viene utilizzato tradizionalmente nell'insegnamento religioso cristiano a partire dal Nuovo Testamento.

Il purgatorio è la condizione, il processo o il luogo di purificazione o di pena temporanea in cui, secondo la credenza cattolica, le anime di coloro che muoiono in uno stato di grazia sono preparate per il paradiso. Nella teologia cattolica è "la condizione di coloro che, morti nella grazia di Dio, non sono ancora perfettamente purificati e devono quindi purificarsi al fine di ottenere la santità necessaria per essere ammessi alla visione di Dio".Il termine Purgatorio (dal latino: purgatorium, da purgare, "epurare") ha assunto anche una vasta gamma di significati storici e moderni relativi a sofferenze postmortem minori in comparazioni alla dannazione eterna. L'"uso comune cristiano" gli attribuisce il senso di "uno dei tre regni dell'oltretomba, insieme all'inferno e al paradiso".Altre confessioni cristiane, oltre al cattolicesimo, riconoscono l'esistenza di un processo di santificazione ossia purificazione dopo la morte che presenta tratti in comune con il concetto cattolico del purgatorio e viene spesso denominato con lo stesso termine, come nell'ortodossia bizantina e nell'ortodossia orientale copta (come attesta la Vita di San Ciro monaco). In ambito protestante, lo stesso Lutero affermò di credere nel purgatorio e perfino nel fuoco purgatoriale di cui nella Tradizione della Chiesa cattolica ma che non fa parte della sua dottrina definita. Anche in tempi più recenti alcuni teologi protestanti sostengono dottrine simili a quella cattolica del purgatorio. Fra questi troviamo, in ambito metodista, Jerry L. Walls; in ambito anglicano, il teologo e romanziere C. S. Lewis, il teologo e fisico John Polkinghorne, il teologo e biblista John Bertram Phillips, e molti altri anglicani; in ambito presbiteriano George MacDonald e William Barclay.Il concetto del purgatorio come regno dell'oltretomba distinto dall'inferno e dal paradiso, dove i peccatori vengono puniti temporaneamente con il fuoco (immagine comune in Occidente) è escluso non solo da altri gruppi sia orientali che occidentali ma non è affermato neanche dalla Chiesa cattolica: infatti non fanno parte della sua fede definita sul purgatorio due dei più prominenti elementi dell'immaginario popolare: quello di una località a parte e quello della purificazione per mezzo del fuoco materiale. Il Catechismo della Chiesa Cattolica distingue fra, da una parte, "la dottrina della fede relativa al purgatorio formulata dalla Chiesa soprattutto nei Concili di Firenze e di Trento" e, dall'altra parte, "la Tradizione della Chiesa [che], rifacendosi a certi passi della Scrittura, parla di un fuoco purificatore". Il concetto del purgatorio come luogo dell'anima, dimensione di pena e purificazione mediante il "fuoco" è affermato da vari santi e beati che hanno riferito di avere avuto visioni del purgatorio, come santa Caterina da Genova, o santa Coletta di Corbie.

L'apostasìa (dal greco ἀπό apò «[lontano] da» e στάσις stàsis da ἵστημι ìstemi «stare, collocarsi») è l'abbandono formale e volontario della propria religione (in tale contesto si parlerà più propriamente di apostata della religione). All'apostasia può seguire sia l'adesione a un'altra religione (conversione), sia una scelta areligiosa (ateismo o agnosticismo). In senso stretto, il termine è riferito alla rinuncia e alla critica della propria precedente religione. Una vecchia e più ristretta definizione di questo termine si riferiva ai cristiani battezzati che abbandonavano la loro fede. Molte religioni considerano l'apostasia un vizio, una degenerazione della virtù della pietà, nel senso che, quando viene a mancare la pietà, l'apostasia ne è la conseguenza; spesso, l'apostata viene fatto bersaglio di condanne spirituali (ad esempio la scomunica) o materiali ed è rifuggito dai membri del suo precedente gruppo religioso. In alcuni Paesi del mondo, l'apostasia è un reato punibile con la pena di morte.

La condizione femminile, i diritti delle donne e il loro status in Russia sono stati influenzati dalla cultura, dalla religione e dai discorsi sociali.

L'evoluzione della condizione femminile e dei diritti delle donne in Africa sono legati alla cultura e alla storia dell'Africa. Numerosi studi brevi sono comparsi nel corso del tempo che hanno affrontato la storia delle donne nel continente e nelle nazioni africane; sono inoltre emerse numerose indagini che hanno inserito l'Africa subsahariana nell'ambito della storia delle donne. Vi sono studi e ricerche per paesi e regioni specifiche come l'Egitto, l'Etiopia, il Marocco, la Nigeria e il Lesotho. Gli studiosi hanno rivolto espressamente la loro attenzione agli eventi innovativi per la storia delle donne africane, come la musica del Malawi, le tecniche di tessitura di Sokoto e la linguistica storica.

I diritti delle donne in Afghanistan sono cambiati in maniera significativa nel corso degli ultimi anni, in particolare dopo il 2001, con la caduta del regime islamico, il quale aveva imposto terribili limitazioni ai loro danni. Le donne afgane, de jure, hanno gli stessi diritti dell'uomo dal 26 gennaio 2004, rifacendosi alla Costituzione del 1964. Dopo la caduta del regime i diritti delle donne sono tornati a fiorire e al giorno d'oggi godono di certo un migliore status rispetto al periodo precedente. Nonostante sia stato ripristinato il codice civile del 1976 e quello della famiglia del 1971, dove la donna afgana gode di buoni diritti, la mentalità da sempre estremamente conservatrice da parte degli afgani non è comunque d'aiuto all'emancipazione femminile, in quanto, de facto, la donna ha molte limitazioni lavorative e sociali nelle zone rurali dove i talebani o i capi villaggio contano più della legislazione nazionale stessa, ripristinata nel 2001. Ancora oggi la violenza contro le donne in tutto il paese è molto alta, anche se la situazione sta poco per volta progredendo grazie anche all'aiuto della comunità internazionale. Il Global Gender Gap Report non ha mai analizzato l'Afghanistan come paese per quanto riguarda i diritti delle donne, ma di certo non è uno dei paesi più femministi al mondo. Nelle zone rurali infatti, dove i capi tribù decidono tutto della vita delle persone, l'adulterio può essere anche punibile con la lapidazione; mentre in altre le adultere possono essere punite con una piccola reclusione presso le case aiutando e servendo i loro capo tribù. Il codice civile afghano del 1976 restaurato nel 2001, prevede invece che la donna adultera venga punita con la reclusione. Sempre nelle zone rurali è spesso imposto l'utilizzo del burqa, che secolarmente imprigiona le donne afghane rurali; mentre nelle zone più sviluppate, come nella capitale Kabul, è abbastanza comune vedere anche donne che indossano l'hijab o che utilizzano anche abiti considerati un po' occidentali, come anche pantaloni o camicie. Infatti, negli ultimi anni, l'utilizzo del burqa nelle zone più urbanizzate e ricche sembra diminuito significativamente. Nonostante i progressi fatti al giorno d'oggi, l'Afghanistan è considerato ancora uno dei Paesi peggiori in cui essere donna, proprio a causa del fortissimo dislivello sociale nelle zone rurali e in quelle urbanizzate.

Il Concilio di Basilea, Ferrara e Firenze fu convocato da papa Martino V (1417-1431) nel 1431, in applicazione di una disposizione conciliare (il Decreto Frequens) del Concilio di Costanza, che prevedeva, con il decreto Frequens, la tenuta periodica di un concilio della Chiesa cattolica. Iniziato nel 1431, esso si svolse in più sedi, prima a Basilea, poi a Ferrara, poi a Firenze ed infine a Roma. Gli scopi del concilio erano i seguenti: 1) trattare l'unione con la Chiesa ortodossa; 2) estirpare l'eresia hussita e 3) riformare la Chiesa.
Con conciliarismo si intende, nella storia della Chiesa, l'orientamento secondo il quale il concilio ecumenico ha un'autorità superiore al papa. Il periodo storico nel quale appare il conciliarismo abbraccia i secoli XIV e XV.