- Libri preferiti
Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti
Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti
Per storia della psicologia si intende la storia della psicologia come scienza a sé stante.

Jean Piaget (Neuchâtel, 9 agosto 1896 – Ginevra, 16 settembre 1980) è stato uno psicologo, biologo, pedagogista e filosofo svizzero. È considerato il fondatore dell'epistemologia genetica, ovvero dello studio sperimentale delle strutture e dei processi cognitivi legati alla costruzione della conoscenza nel corso dello sviluppo, e si dedicò molto anche alla psicologia dello sviluppo.
La psicologia individuale, o psicologia individuale comparata, di Alfred Adler prende in esame l'individuo nella sua unica e irripetibile dinamica di processi consci e inconsci: l'uomo è una unità mente/corpo indivisibile, originale e coerente nelle sue manifestazioni. La psicologia individuale comparata di Alfred Adler è un metodo per la conoscenza concreta, pratica dell'uomo (Menschenkenntnis) ed uno strumento per comprendere il comportamento nelle sue molteplici espressioni; insieme alla psicoanalisi di Sigmund Freud ed alla psicologia analitica di Carl Gustav Jung, costituisce la triade fondamentale delle teorie della personalità. Nel 1911, dopo un lungo periodo di intensa collaborazione con Freud, divenute ormai troppo evidenti le divergenze teoriche, Alfred Adler fonda, con un gruppo di seguaci, la Società di Psicologia Individuale Comparata. "Il nome, Psicologia Individuale, intende esprimere la convinzione che i processi psicologici e le loro manifestazioni si possono comprendere soltanto dal contesto individuale ed ogni intuizione psicologica inizia con l'individuo". L'attributo "individuale", che oggi contraddistingue la Scuola, affiancato dalla meno consueta qualifica di "comparata", esprime l'idea di una individualità psichica che, per la sua natura “sociale”, è parte di una struttura comunitaria formata da altre unità psichiche, perciò, "non è possibile studiare un essere umano in condizioni di isolamento, ma solo all'interno del suo contesto sociale". Si può, quindi, considerare la Psicologia Individuale Comparata come matrice del filone socio-culturale della psicologia dinamica.
La psicologia la scienza che studia gli stati mentali e i suoi processi emotivi, cognitivi, sociali e comportamentali nelle loro componenti consce e inconsce, mediante l'uso del metodo scientifico e/o appoggiandosi ad una prospettiva soggettiva intrapersonale. Si occupa anche dello studio e del trattamento delle funzioni psichiche sia in condizioni di benessere che di sofferenza o disagio mentale, dovute a dinamiche soggetive (intrapsichiche), ambientali o relazionali (interpsichiche).
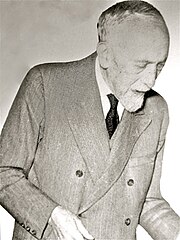
Giuseppe Ferruccio Maria Montesano (Potenza, 4 ottobre 1868 – Roma, 9 agosto 1961) è stato uno psicologo, psichiatra e accademico italiano; può essere considerato uno dei fondatori della psicologia e della neuropsichiatria infantile italiana.
La psicologia cognitiva, anche detta cognitivismo, è una branca della psicologia applicata allo studio dei processi cognitivi, teorizzata intorno al 1967 dallo psicologo statunitense Ulric Neisser, che ha come obiettivo lo studio dei processi mentali mediante i quali le informazioni vengono acquisite dal sistema cognitivo, elaborate, memorizzate e recuperate.

La psicoanalisi o psicanalisi (da psico-, psiche, anima, più comunemente "mente", e -analisi: analisi della mente) è la teoria dell'inconscio della psiche umana su cui si fondano una disciplina, nota come psicodinamica, e una relativa prassi psicoterapeutica, che hanno preso l'avvio dal lavoro di Sigmund Freud, il quale si inserì nel solco dei lavori di Jean-Martin Charcot e Pierre Janet.In primis la teoria psicoanalitica è una teoria dell'inconscio: nell'indagine dell'attività umana essa si rivolge soprattutto a quei fenomeni psichici che risiedono al di fuori della sfera della coscienza. Viene perciò attivato il concetto di inconscio, introdotto nella riflessione teoretica già da Leibniz, e che Freud fece suo da un punto di vista descrittivo e topico sulla base delle sue esperienze con Jean-Martin Charcot a Parigi. In secondo luogo dalla psicoanalisi nasce una disciplina ed una prassi psicoterapeutica nota come psicoterapia psicodinamica: nello specifico, come cura dei disturbi e, all'origine, come cura dell'isteria e successivamente dei fenomeni psicopatologici chiamati nevrosi, neurosi o psiconevrosi. In seguito, il suo uso è stato esteso allo studio e trattamento di altri tipi di psicopatologie. In seguito, a livello culturale più generale, la psicoanalisi ha influenzato in parte anche la filosofia e le scienze sociali. Lo statuto epistemologico della psicoanalisi è stato variamente criticato e lungamente dibattuto, anche in parallelo alle sue diverse evoluzioni teoriche e metodologiche. Mentre in un primo tempo le osservazioni popperiane sulla sua scarsa falsificabilità avevano portato a una visione piuttosto critica del suo status epistemico, a partire dagli anni '80 e '90 del XX secolo la maggiore attenzione che ha cominciato a essere rivolta alla verifica empirica dei suoi risultati clinici, all'integrazione della modellistica teorica psicoanalitica con altre linee di ricerca psicologica e psichiatrica, e agli spunti integrativi con le neuroscienze hanno portato a una visione più articolata e in forte evoluzione del suo statuto scientifico, nel contesto dei più ampi studi psicodinamici.

Maria Rita Parsi (Roma, 5 agosto 1947) è una psicologa, psicoterapeuta, docente, saggista e scrittrice italiana. Attuale componente dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, già membro del Comitato ONU sui diritti del fanciullo, ha al suo attivo la pubblicazione di oltre 100 libri di tipo scientifico, letterario e divulgativo. È presidente della Fondazione Movimento Bambino Onlus, erede delle esperienze di animazione socioculturali già attive dal 1975. Nel 1986 è stata insignita del titolo di Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana. Nel 2007 ha ricevuto la medaglia d’oro della Camera dei Deputati a nome del Comitato Scientifico Internazionale del Centro Pio Manzù, presieduto da Mikhail Gorbaciov e, nel 2009, il Premio nazionale Paolo Borsellino.

L'interpretazione dei sogni, edito in tedesco nel 1899, con il titolo Die Traumdeutung, è una delle opere di Sigmund Freud che sta alla base degli ulteriori sviluppi del pensiero del fondatore della psicoanalisi. Essa segna il passaggio del metodo psicoanalitico, per accedere ai contenuti inconsci della psiche, dalla semplice tecnica della libera associazione di idee al nuovo metodo che privilegia direttamente l'attività onirica, che di per sé nullifica o almeno limita considerevolmente l'attività censoria della ragione. All'uscita di quest'opera il sogno era relegato ai margini degli interessi psicologici e gli veniva negata addirittura una qualsiasi validità psichica; ciò aiuta a comprendere quanto il volume freudiano fosse rivoluzionario, accolto parimenti con interesse e con sprezzanti critiche dal panorama culturale e scientifico dell'epoca. Freud dunque preparò un volume ponderoso, quasi a voler anticipatamente rispondere alle critiche che inevitabilmente sarebbero venute. In uno degli ultimi capitoli, il settimo, il medico viennese ipotizzò inoltre un modello psichico che riuscisse a spiegare il meccanismo della "formazione onirica", come via regressiva del pensiero verso la percezione.