- Libri preferiti
Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti
Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti
L'intelligenza emotiva è un aspetto dell'intelligenza legato alla capacità di riconoscere, utilizzare, comprendere e gestire in modo consapevole le proprie ed altrui emozioni. L'intelligenza emotiva è stata trattata la prima volta nel 1990 dai professori Peter Salovey e John D. Mayer nel loro articolo “Emotional Intelligence”. Definiscono l'intelligenza emotiva come “La capacità di controllare i sentimenti ed emozioni proprie ed altrui, distinguere tra di esse e di utilizzare queste informazioni per guidare i propri pensieri e le proprie azioni”. Nell'articolo alla figura 1, viene presentato un diagramma che concettualizza l'intelligenza emotiva, dimostrando che è composta da tre rami principali: Valutazione ed espressione delle emozioni Regolazione delle emozioni Utilizzo delle emozioniTale definizione iniziale è stata poi successivamente aggiornata in quanto appariva imprecisa e priva di un ragionamento sui sentimenti, trattando solo la percezione e la regolazione delle emozioni. È quindi stata definita come segue: "L'intelligenza emotiva coinvolge l'abilità di percepire, valutare ed esprimere un'emozione; l'abilità di accedere ai sentimenti e/o crearli quando facilitano i pensieri; l'abilità di capire l'emozione e la conoscenza emotiva; l'abilità di regolare le emozioni per promuovere la crescita emotiva e intellettuale”. Il tema dell'intelligenza emotiva è stato successivamente trattato nel 1995 da Daniel Goleman nel libro "Emotional Intelligence" tradotto in italiano nel 1997 "Intelligenza emotiva: che cos'è e perché può renderci felici". Grazie a questo libro quindi anche in Italia il tema dell'intelligenza emotiva ha iniziato ad essere utilizzato e studiato sia in ambito psicologico, sia in ambito organizzativo/aziendale.

L'intelligenza collettiva è un concetto diffuso dallo studioso francese Pierre Lévy. Ad esso ha dedicato il libro L'intelligenza collettiva. Per un'antropologia del cyberspazio (1994). Nel saggio, Levy ripercorre le riflessioni e le indagini che ha condotto a partire dai primi anni novanta presso il centro di ricerca sull'intelligenza collettiva dell'Università di Ottawa. Sebbene il termine sia stato definito per la prima volta da Douglas C. Engelbart nel 1962, in un articolo dal titolo Augmenting Human Intellect. A Conceptual Framework, Pierre Levy è colui che maggiormente ha approfondito e studiato le potenzialità di questa capacità umana, contribuendo alla sua divulgazione in ambito sociologico.
Definizioni specifiche possono essere date focalizzandosi o sui processi interni di ragionamento o sul comportamento esterno del sistema intelligente e utilizzando come misura di efficacia o la somiglianza con il comportamento umano o con un comportamento ideale, detto razionale: Agire umanamente: il risultato dell’operazione compiuta dal sistema intelligente non è distinguibile da quella svolta da un umano. Pensare umanamente: il processo che porta il sistema intelligente a risolvere un problema ricalca quello umano. Questo approccio è associato alle scienze cognitive. Pensare razionalmente: il processo che porta il sistema intelligente a risolvere un problema è un procedimento formale che si rifà alla logica. Agire razionalmente: il processo che porta il sistema intelligente a risolvere il problema è quello che gli permette di ottenere il miglior risultato atteso date le informazioni a disposizione.L'intelligenza artificiale è una disciplina dibattuta tra scienziati e filosofi poiché manifesta aspetti etici oltre che teorici e pratici. Stephen Hawking nel 2014 ha messo in guardia riguardo ai pericoli dell'intelligenza artificiale, considerandola una minaccia per la sopravvivenza dell'umanità. Il 2 agosto dello stesso anno anche Elon Musk ha twittato: «Dobbiamo essere super attenti all'intelligenza artificiale. Potenzialmente più pericolosa del nucleare.»

Benché i ricercatori nel campo non ne abbiano ancora dato una definizione ufficiale (considerabile come universalmente condivisa dalla comunità scientifica), alcuni identificano l'intelligenza (in questo caso l'intelligenza pratica) come la capacità di un agente di affrontare e risolvere con successo situazioni e problemi nuovi o sconosciuti; nel caso dell'uomo e degli animali, l'intelligenza pare inoltre identificabile anche come il complesso di tutte quelle facoltà di tipo cognitivo o emotivo che concorrono o concorrerebbero a tale capacità. Per alcune scuole di pensiero, soprattutto antiche, la sede dell'intelligenza non è il cervello e la si identifica come la qualità, esclusivamente umana, di capire un fenomeno e le sue relazioni con tutti gli aspetti non apparenti che interagiscono con tale fenomeno, la capacità quindi di leggervi dentro. Tradizionalmente attribuita alle sole specie animali, oggi l'intelligenza viene da alcuni attribuita, in misura minore, anche alle piante, mentre il campo di ricerca dell'intelligenza artificiale tenta di creare delle macchine che siano in grado di riprodurre o di simulare l'intelligenza umana.

Jean Piaget (Neuchâtel, 9 agosto 1896 – Ginevra, 16 settembre 1980) è stato uno psicologo, biologo, pedagogista e filosofo svizzero. È considerato il fondatore dell'epistemologia genetica, ovvero dello studio sperimentale delle strutture e dei processi cognitivi legati alla costruzione della conoscenza nel corso dello sviluppo, e si dedicò molto anche alla psicologia dello sviluppo.
In psicologia, l'intelligenza fluida e cristallizzata (abbreviate in Gf e Gc, rispettivamente) sono due fattori dell'intelligenza generale, originariamente identificati da Raymond Cattell. L'intelligenza fluida (Gf), o ragionamento fluido, è la capacità di pensare logicamente e risolvere i problemi in situazioni nuove, indipendentemente dalle conoscenze acquisite. È la capacità di analizzare problemi nuovi, identificare gli schemi e le relazioni sottostanti per estrapolarne una soluzione usando il ragionamento logico. È necessario che tutti i problemi logici, scientifici, matematici e tecnici, siano affrontati con il procedimento del problem solving, adottando il pensiero fluido che comprende sia il ragionamento induttivo che quello deduttivo. L'intelligenza cristallizzata (Gc) è la capacità di utilizzare competenze, conoscenze ed esperienze. Non dovrebbe essere equiparata alla memoria o alla conoscenza, anche se il suo operato le permette di accedere alle informazioni dalla memoria a lungo termine. L'intelligenza generale è stata denominata “g” dal suo divulgatore Charles Spearman nel 1904.L'intelligenza cristallizzata è rappresentata dalla profondità e vastità di conoscenze generali che una persona possiede, come pure dal suo vocabolario e dalla capacità di ragionare, usando parole e numeri: è sostanzialmente il prodotto di esperienze educative e culturali, in costante interazione con l'intelligenza fluida. L'intelligenza fluida e quella cristallizzata sono quindi correlate fra loro, e molti test d'intelligenza tentano di misurarle entrambe. Ad esempio, la scala WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale) misura l'intelligenza fluida sulla scala delle prestazioni e l'intelligenza cristallizzata sulla scala verbale. Il punteggio globale del quoziente d'intelligenza si basa quindi sulla combinazione di queste due scale.

L'intelligenza dei cani è la capacità degli stessi di percepire informazioni e di ricordarle sotto forma di conoscenze da applicare alla risoluzione di problemi.
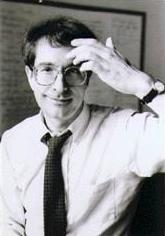
Howard Gardner (Scranton, 11 luglio 1943) è uno psicologo e docente statunitense.
Il Culture Fair Intelligence Test (CFIT) è stato messo a punto da Raymond Cattell nel 1949, con l'intento di sviluppare un test di intelligenza che fosse libero da fattori culturali, ovvero un test culture-fair (cultura equa) per misurare il quoziente intellettivo. Cattell sosteneva l'esistenza di un fattore di intelligenza generale (g) e che questo fosse composto da due tipi di intelligenza: fluida e cristallizzata.