- Libri preferiti
Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti
Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

La storia della controversia su razza e intelligenza concerne lo sviluppo storico di un dibattito riguardante le possibili spiegazioni inerenti alle "differenze di gruppo" incontrate nello studio della razza e dell'intelligenza. Dall'inizio della messa a punto dei test psico-sociali sul quoziente d'intelligenza nel periodo della prima guerra mondiale sono state riscontrate (e fatte debitamente notare) differenze - anche rilevanti - tra i punteggi medi di diversi gruppi di popolazione; ma non vi è stato fin dal principio alcun accordo sul fatto che ciò fosse dovuto essenzialmente a fattori ambientali e culturali o, viceversa, a causa di alcuni predeterminati fattori genetici. Non vi è d'altra parte neppure alcun accordo sulla questione se la dicotomia radicale tra fattori ambientali e/o genetici sia nella realtà dei risultati ottenuti l'approccio più efficace al dibattito. Tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo si presumette che le differenze d'intelligenza riscontrate nei diversi gruppi presi in esame fossero dovute in maniera preponderante alla "razza" di appartenenza e, a parte i test del QI, la susseguente ricerca scientifica si basò su misurazioni come la dimensione del cervello umano o i tempi di reazione. Verso la metà degli anni 1930 la maggior parte degli studiosi di psicologia aveva oramai adottato l'opinione che i fattori culturali e ambientali fossero quelli predominanti. Alla metà degli anni 1960 il premio Nobel per la fisica William Bradford Shockley suscitò ampie polemiche sostenendo di fatto che potrebbero esserci motivi genetici alla base della constatazione che gli afroamericani tendessero per lo più ad ottenere punteggi più bassi nei test intellettivi rispetto ai bianchi americani. Nel 1969 l'esperto di psicologia dell'educazione Arthur Jensen pubblicò un lungo articolo (How Much Can We Boost IQ and Scholastic Achievement?) contenente il suggerimento che l'"educazione compensatoria" fosse fino ad allora irrimediabilmente fallita a causa delle differenze genetiche (quindi innate, quindi soggette a ereditarietà) di gruppo. Un dibattito del tutto simile tra accademici seguì la pubblicazione nel 1994 di The Bell Curve, opera di Richard Herrnstein e Charles Murray; il loro libro rinnovò ancora una volta il dibattito sulla questione, oltre ad un certo numero di altre notizie interdisciplinari sullo stesso tema. Una delle risposte contemporanee è stata rappresentata dalla relazione dell'American Psychological Association la quale dichiara con chiarezza di non essere stata capace di rinvenire alcuna spiegazione conclusiva per i dati sulle differenze osservate tra i punteggi medi del QI nei diversi gruppi etnici.
La psicologia sociale è una branca della psicologia che studia l'interazione tra l'individuo e i gruppi sociali. Il primo studio di psicologia sociale può essere considerato La psicologia dei popoli (Völkerpsychologie) di Wilhelm Wundt, del 1900 e 1920. Essa però si afferma come disciplina a sé stante negli USA, dagli inizi del XX secolo, con Norman Triplett e William McDougall. Gli psicologi sociali tipicamente spiegano il comportamento umano in termini di interazione tra stati mentali e situazioni sociali immediate. Nella famosa formula euristica di Kurt Lewin (1951), il comportamento (C) viene visto come una funzione (f) dell'interazione tra la persona (P) e l'ambiente (A), concetto sintetizzato da Lewin con C = f ( P , A ) {\displaystyle C=f(P,A)} . L'aggettivo "sociale" rappresenta un dominio interdisciplinare che fa da ponte tra la psicologia e la sociologia. Durante gli anni immediatamente successivi alla seconda Guerra mondiale, ci fu collaborazione frequente tra psicologi e sociologi (Sewell, 1989). Negli anni recenti le due discipline si sono specializzate in modo crescente ed isolate l'una dall'altra, con i sociologi che si concentrano su "macro variabili" (struttura sociale), con estensione molto più ampia. Ciononostante, gli approcci sociologici alla psicologia sociale rimangono un'importante controparte alla ricerca psicologica in questa area.

Un discorso di incitamento all'odio o discorso d'odio (traduzione della dizione inglese hate speech) è una comunicazione con elementi verbali e non verbali mirati a esprimere e diffondere odio e intolleranza, o a incitare al pregiudizio e alla paura verso un individuo o un gruppo di individui accomunati da etnia, orientamento sessuale o religioso, disabilità, altra appartenenza sociale o culturale. Il fenomeno ha acquisito particolare visibilità ed estensione con la diffusione delle reti sociali, alimentando il dibattito giuridico e spingendo i governi e l'associazionismo ad attuare azioni di contenimento o repressione.
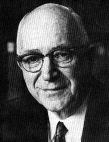
Gordon Willard Allport (Montezuma, 11 novembre 1897 – 9 ottobre 1967) è stato uno psicologo statunitense. È stato uno dei più noti psicologi della psicologia sociale, appartenente al movimento della cosiddetta "psicologia dei tratti".