- Libri preferiti
Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti
Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Virginio Puecher, all'anagrafe Virginio Puecher Passavalli (Lambrugo, 16 dicembre 1926 – Milano, 29 dicembre 1990), è stato un regista italiano.

Va, pensiero (Va, pensiero, sull'ali dorate) è uno dei cori più noti della storia dell'opera, collocato nella parte terza del Nabucco di Giuseppe Verdi (1842), dove viene cantato dagli Ebrei prigionieri in Babilonia. Il poeta Temistocle Solera scrisse i versi ispirandosi al salmo 137, Super flumina Babylonis (Sui fiumi di Babilonia).
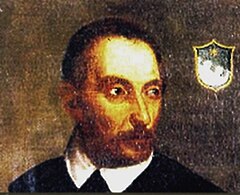
Orazio Vecchi (Modena, 6 dicembre 1550 – Modena, 19 febbraio 1605) è stato un compositore e musicista italiano del tardo periodo rinascimentale, noto soprattutto per i suoi madrigali.
La locuzione latina Illic stetimus et flevimus, quum recordaremur Sion, tradotta letteralmente, significa là ci sedemmo e piangemmo ricordando Sion. È tratta dal Salmo 137 nella versione latina della Vulgata rivista da Paolo VI (la versione originale ha "Illic sedimus et flevimus dum recordaremur tui Sion"). È il lamento dell'esule che ricorda la patria lontana.Il versetto tratto dal salmo che inizia "Super flumina Babylonis ... " rappresenta un momento di intenso lirismo della poesia ebraica tale da ispirare musicisti quali Pierluigi da Palestrina. In periodi successivi, sulle note di "Va' pensiero", che segnano un momento epico di intensa commozione, Giuseppe Verdi presenterà il dramma di questo popolo come tragedia corale di scontro tra popoli e classi sociali.

Fernando Previtali (Adria, 16 febbraio 1907 – Roma, 1º agosto 1985) è stato un direttore d'orchestra e compositore italiano.
Il Cantique de Jean Racine (Cantico di Jean Racine), Op. 11, è una composizione per coro a voci miste e pianoforte o organo di Gabriel Fauré. Il testo, Verbe égal au Très-Haut (Verbo pari all'Altissimo), è tratto dalla traduzione francese dovuta a Jean Racine dell'inno latino Consors paterni luminis, attribuito a sant'Ambrogio e utilizzato nella liturgia del mattutino del martedì. Fauré compose il brano nel 1864-65 per una concorso interno all'École Niedermeyer di Parigi, in cui vinse il primo premio e fu eseguito per la prima volta il 4 agosto 1866 in una versione con accompagnamento di organo e archi. Stilisticamente, vi si possono riscontrare analogie con il successivo Requiem, assieme al quale è oggi spesso eseguito.