- Libri preferiti
Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti
Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

La storia della scienza riguarda le vicende, i personaggi e le scoperte che hanno contribuito al progresso scientifico. Essa ha prodotto quella che oggi è considerata la scienza moderna, ossia un corpo di conoscenze empiricamente controllabile, una comunità di studiosi e una serie di tecniche per investigare l'universo note come metodo scientifico, che si è evoluto a partire dai loro precursori, risalendo fino alla preistoria. La rivoluzione scientifica vide l'introduzione del moderno metodo scientifico a guidare il processo di valutazione della conoscenza. Questo cambiamento è considerato così fondamentale che le indagini ad esso precedenti sono per lo più considerate prescientifiche. Molti, tuttavia, ritengono che la filosofia naturale antica possa rientrare all'interno del campo di competenza della storia della scienza.
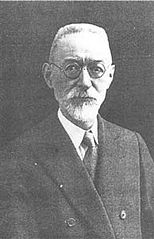
Michele Barbi (Taviano di Sambuca Pistoiese, 19 febbraio 1867 – Firenze, 23 settembre 1941) è stato un filologo e letterato italiano.

Luigi Carlo Farini (Russi, 22 ottobre 1812 – Quarto, 1º agosto 1866) è stato un medico, storico, politico e patriota italiano, per breve tempo Presidente del Consiglio dei ministri del Regno d'Italia tra il 1862 e il 1863.
Il Liber quadratorum di Leonardo Fibonacci è un importante trattato di argomento algebrico in lingua latina. L'opera, che fu pubblicata intorno al 1225, si apre con un'epistola di dedica a Federico II di Hohenstaufen, in cui si afferma che fu il maestro Domenico, già destinatario della Practica geometriae, a presentare il matematico all'imperatore: Nel Liber quadratorum Fibonacci discute la risoluzione di due quesiti: il primo, che gli fu posto dal maestro Giovanni da Palermo, consiste nel calcolare un numero quadrato tale che, aumentato o diminuito di cinque, dia come risultato un numero quadrato; il secondo, che invece gli fu posto dal maestro Teodoro di Antiochia, consiste nel rinvenire tre numeri «tali che la loro somma, aggiunta al quadrato del primo, sia un numero quadrato; che questo numero quadrato, aumentato del quadrato del secondo, sia un numero quadrato e che anche quest’ultimo, sommato al quadrato del terzo, dia un quadrato (equazioni pitagoriche)»

Leonardo Pisano detto il Fibonacci (Pisa, settembre 1170 circa – Pisa, 1242 circa) è stato un matematico italiano. È considerato uno dei più grandi matematici di tutti i tempi. Con altri dell'epoca contribuì alla rinascita delle scienze esatte dopo la decadenza dell'età tardo-antica e dell'Alto Medioevo. Con lui, in Europa, ci fu l'unione fra i procedimenti della geometria greca euclidea (gli Elementi) e gli strumenti matematici di calcolo elaborati dalla scienza araba (in particolare egli studiò per la parte algebrica il Liber embadorum dello studioso ebreo spagnolo Abraham ibn ‛Ezra).
Il Flos Leonardi Bigolli Pisani super solutionibus quarundam questionibus ad numerum et ad geometriam, vel ad utrumque pertinentium, (il Fiore di Leonardo Bigollo Pisano sulle soluzioni di certe questioni concernenti l'aritmetica e la geometrica, ovvero entrambe le discipline) è un trattato privo dell'anno di composizione e contenuto all'interno del ms. E 75 Sup. della Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano. Il codice presenta due epistole di dedica, la prima delle quali è indirizzata a Raniero Capocci di Viterbo, cardinale diacono del titolo di Santa Maria in Cosmedin a partire dal 1212 o dal 1213, mentre la seconda è destinata all'imperatore Federico II di Hohenstaufen. Nel 1240 l'imperatore Federico II di Hohenstaufen si impadronì della città di Viterbo e vi pose un presidio, ma appena tre anni dopo, nel 1243, la città insorse avendo a capo anche il cardinale Raniero Capocci. In seguito, concluso sotto Innocenzo IV il concilio di Lione, Raniero Capocci promulgò contro Federico la sentenza di privazione del potere temporale. Sorprende, perciò, che dopo la lettera di dedica al cardinale Capocci segua nel Flos anche una seconda epistola, rivolta stavolta all’imperatore Federico, acerrimo nemico del Capocci: «Il problema proposto da Maestro Giovanni chiedeva di trovare un numero quadrato tale che, aggiungendogli e sottraendogli il numero cinque, si ottenesse ancora un numero quadrato. Leonardo trovò che il numero 11+2/3+1/144, quadrato di 3+1/4+1/6, è una soluzione del problema e la comunicò al suo interlocutore. Egli tuttavia continuò a meditare sul problema e più in generale sulle proprietà dei numeri quadrati, pervenendo a una serie di importanti risultati raccolti nel Liber quadratorum che dedicò all’imperatore».

Ferdinando Meucci (Firenze, 23 dicembre 1823 – Firenze, 5 dicembre 1893) è stato un archivista e storico della scienza italiano.

L'Accademia degli Intronati è nata tra il 1525 e il 1527 nella Repubblica di Siena come luogo di ritrovo dell'aristocrazia, la cui prima manifestazione pubblica risale al 1531 con la rappresentazione della commedia Gl'ingannati, anonima, ma secondo vari studiosi da attribuirsi principalmente al filologo modenese Lodovico Castelvetro, che fu membro dell'Accademia. Dopo aver avuto sede per gran parte del Settecento nel palazzo della Sapienza (oggi Biblioteca comunale degli Intronati), l'Accademia è ora ospitata in palazzo Patrizi-Piccolomini, in via di Città 75.