- Libri preferiti
Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti
Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Marco Tullio Cicerone (in latino: Marcus Tullius Cicero, pronuncia ecclesiastica: /ˈmarkus ˈtulljus ˈʧiʧero/, pronuncia restituta o classica: /ˈmaːr.kʊs ˈtʊl.lɪ.ʊs ˈkɪ.kɛ.roː/; in greco antico: Κικέρων, Kikérōn; Arpino, 3 gennaio 106 a.C. – Formia, 7 dicembre 43 a.C.) è stato un avvocato, politico, scrittore, oratore e filosofo romano. Esponente di un'agiata famiglia dell'ordine equestre, fu una delle figure più rilevanti di tutta l'antichità romana. La sua vastissima produzione letteraria, che va dalle orazioni politiche agli scritti di filosofia e retorica, oltre a offrire un prezioso ritratto della società romana negli ultimi travagliati anni della repubblica, rimase come esempio per tutti gli autori del I secolo a.C., tanto da poter essere considerata il modello della letteratura latina classica. Grande ammiratore della cultura greca, attraverso la sua opera, i Romani poterono anche acquisire una migliore conoscenza della filosofia. Tra i suoi maggiori contributi alla cultura latina ci fu, senza dubbio, la creazione di un lessico filosofico latino: Cicerone si impegnò, infatti, a trovare il corrispondente vocabolo in latino per tutti i termini specifici del linguaggio filosofico greco. Tra le opere fondamentali per la comprensione del mondo latino si collocano, invece, le Lettere (Epistulae, in particolar modo quelle all'amico Tito Pomponio Attico) che offrono numerosissime riflessioni su ogni avvenimento, permettendo di comprendere quali fossero le reali linee politiche dell'aristocrazia romana. Cicerone occupò per molti anni anche un ruolo di primaria importanza nel mondo della politica romana: dopo aver salvato la repubblica dal tentativo eversivo di Lucio Sergio Catilina ed aver così ottenuto l'appellativo di pater patriae (padre della patria), ricoprì un ruolo di primissima importanza all'interno della fazione degli Optimates. Fu, infatti, Cicerone che, negli anni delle guerre civili, difese strenuamente, fino alla morte, una repubblica giunta ormai all'ultimo respiro e destinata a trasformarsi nel principatus augusteo.

Le Filippiche sono orazioni che Marco Tullio Cicerone pronunci contro Marco Antonio dal 2 settembre del 44 a.C. al 21 aprile del 43 a.C., ad eccezione della II Filippica, immaginata come pronunciata in senato, in risposta agli sprezzanti attacchi di Antonio nei suoi riguardi durante l'assemblea del 19 settembre (a cui Cicerone non partecip ). Questa orazione di Cicerone, accuratamente preparata nella sua villa a Pozzuoli, poi inviata all'amico Attico - che ne apprezz molto la vis retorica e mai pronunciata, venne presumibilmente fatta circolare negli ambienti politici romani prima del 20 dicembre 44, giorno in cui la III e la IV Filippica vennero presentate rispettivamente in senato e davanti al popolo.

Lucio Sergio Catilina (in latino: Lucius Sergius Catilina; Roma, 108 a.C. – Pistoia, 62 a.C.) è stato un militare e senatore romano, per lo più noto per la congiura che porta il suo nome, un tentativo di sovvertire la Repubblica romana, e in particolare il potere oligarchico del Senato.

Il De Catilinae coniuratione (in italiano La congiura di Catilina) è una monografia storica, la seconda in assoluto della letteratura latina, scritta dallo storico latino Gaio Sallustio Crispo (86 - 34 a.C.). Seguendo una scansione narrativa suddivisa in 61 capitoli, l'opera narra la congiura ordita da Lucio Sergio Catilina nel 63 a.C., nel tentativo, rivelatosi poi fallimentare e costatogli la vita, di sovvertire l’ordinamento repubblicano di Roma. La congiura catilinaria viene vista dallo storico di Amiternum come uno degli argomenti più significativi della decadenza morale e sociale della classe dirigente romana (specie dei senatori) durante il I secolo a.C., una corruzione che egli denuncia e critica severamente lungo tutta la narrazione. Dopo La congiura di Catilina, Sallustio scrisse un'altra monografia storica, il Bellum Iugurthinum, ovvero la Guerra di Giugurta, sull'omonimo conflitto.

La locuzione latina Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?, tradotta letteralmente, significa «Fino a quando dunque, Catilina, abuserai della nostra pazienza?».L'invettiva prosegue con le parole: «Quamdiu etiam furor iste tuus nos eludet? Quem ad finem sese effrenata iactabit audacia?»: «Quanto a lungo ancora codesta tua follia si prenderà gioco di noi? Fino a che punto si spingerà [la tua] sfrenata audacia?».

Il Cicerone denuncia Catilina, noto anche come Cicerone accusa Catilina in Senato, è un affresco del 1880 del pittore e scultore italiano Cesare Maccari. Quest'opera viene considerata la più famosa di Maccari, il quale è stato annoverato per il modo in cui i suoi dipinti descrivono così realisticamente gli eventi che rappresentano. L'opera è conservata, insieme ad altre di Maccari, nella "Sala Cagliari" del Salone d'Onore, situato all'interno di Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica Italiana, a Roma.
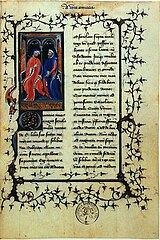
Il Laelius de amicitia (titolo completo Laelius seu De amicitia - pi noto come De amicitia: "Sull'amicizia"), opera dell'ultimo periodo ciceroniano, un dialogo di carattere filosofico (immaginato svolgersi nel 129 a.C.) scritto da Cicerone tra l'estate e l'autunno del 44 a.C. e dedicato a Tito Pomponio Attico. Delinea, in un dialogo tenuto da Mucio Scevola, Gaio Fannio e Lelio, tutte le sfumature dell'amicizia, unendo la visione epicurea (tipicamente attichiana) e quella stoica (ciceroniana). Nell'antichit soltanto l'epicureismo aveva cercato di svincolare il valore di amicizia da quello di utilitas. In questo trattato, che a prima vista potrebbe sembrare un dialogo tra amici, in realt Cicerone utilizza autorevoli fonti per sostenere l'amicizia libera dal vincolo politico.

In Verrem è il nome che si dà ad una serie di orazioni scritte da Cicerone, note anche come Verrine. Furono elaborate nel 70 a.C., in occasione di una causa di diritto penale discussa a Roma, che vedeva come accusatori il popolo della ricca provincia di Sicilia e l'ex propretore dell'isola Gaio Licinio Verre come imputato. L'accusa mossa nei suoi confronti era de pecuniis repetundis, cioè di concussione, reato consumato durante il triennio di governo dal 73 al 71 a.C.. I siciliani, che avevano conosciuto poco tempo prima Cicerone come questore di Lilibeo, gli affidarono l'accusa.

Il De re publica (in italiano La Repubblica o Sulla cosa pubblica o Sullo Stato) di Cicerone è un trattato di filosofia politica diviso in sei libri.