- Libri preferiti
Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti
Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Pietro Bembo (Venezia, 20 maggio 1470 – Roma, 18 gennaio 1547) è stato un cardinale, scrittore, grammatico, poeta e umanista italiano. Appartenente a una nobile famiglia veneziana, fin dalla gioventù Pietro Bembo ebbe modo di costruirsi una solida formazione e reputazione letteraria grazie ai contatti con l'ambiente paterno e, in seguito, all'amicizia con Ludovico Ariosto e alla consulenza per Aldo Manuzio. Il suo merito principale fu quello di contribuire potentemente alla «codificazione dell'italiano scritto», uniformato al modello boccacciano, nell'opera che più di tutte lo ha reso famoso, «la grammatica più importante dell'intera storia dell'italiano», ossia le Prose nelle quali si ragiona della volgar lingua (1525). Parimenti decisivo fu il suo ruolo nella diffusione in tutta Europa del modello poetico petrarchista. Nominato cardinale nel 1539 da papa Paolo III, morì a Roma nel 1547.
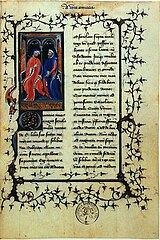
Il Laelius de amicitia (titolo completo Laelius seu De amicitia - pi noto come De amicitia: "Sull'amicizia"), opera dell'ultimo periodo ciceroniano, un dialogo di carattere filosofico (immaginato svolgersi nel 129 a.C.) scritto da Cicerone tra l'estate e l'autunno del 44 a.C. e dedicato a Tito Pomponio Attico. Delinea, in un dialogo tenuto da Mucio Scevola, Gaio Fannio e Lelio, tutte le sfumature dell'amicizia, unendo la visione epicurea (tipicamente attichiana) e quella stoica (ciceroniana). Nell'antichit soltanto l'epicureismo aveva cercato di svincolare il valore di amicizia da quello di utilitas. In questo trattato, che a prima vista potrebbe sembrare un dialogo tra amici, in realt Cicerone utilizza autorevoli fonti per sostenere l'amicizia libera dal vincolo politico.

Francesco Petrarca (Arezzo, 20 luglio 1304 – Arquà, 19 luglio 1374) è stato uno scrittore, poeta, filosofo e filologo italiano, considerato il precursore dell'umanesimo e uno dei fondamenti della letteratura italiana, soprattutto grazie alla sua opera più celebre, il Canzoniere, patrocinato quale modello di eccellenza stilistica da Pietro Bembo nei primi del Cinquecento. Uomo moderno, slegato ormai dalla concezione della patria come mater e divenuto cittadino del mondo, Petrarca rilanciò, in ambito filosofico, l'agostinismo in contrapposizione alla scolastica e operò una rivalutazione storico-filologica dei classici latini. Fautore dunque di una ripresa degli studia humanitatis in senso antropocentrico (e non più in chiave assolutamente teocentrica), Petrarca (che ottenne la laurea poetica a Roma nel 1341) spese l'intera sua vita nella riproposta culturale della poetica e filosofia antica e patristica attraverso l'imitazione dei classici, offrendo un'immagine di sé quale campione di virtù e della lotta contro i vizi. La storia medesima del Canzoniere, infatti, è più un percorso di riscatto dall'amore travolgente per Laura che una storia d'amore, e in quest'ottica si deve valutare anche l'opera latina del Secretum. Le tematiche e la proposta culturale petrarchesca, oltre ad aver fondato il movimento culturale umanistico, diedero avvio al fenomeno del petrarchismo, teso ad imitare stilemi, lessico e generi poetici propri della produzione lirica volgare dell'aretino.

Il Satyricon è un romanzo in prosimetro della letteratura latina, attribuito a Petronio Arbitro (I secolo d.C.). La frammentarietà e la lacunosità del testo pervenuto in età moderna hanno compromesso una comprensione più precisa dell'opera. I manoscritti che tramandano l'opera sono discordanti riguardo al titolo, riportandone diversi: Satiricon, Satyricon, Satirici o Satyrici (libri), Satyri fragmenta, Satirarum libri. È consuetudine, però, riferirsi all'opera di Petronio con il titolo di Satyricon, da intendersi probabilmente come genitivo plurale di forma greca (dov'è sottinteso libri), analogamente ad altre opere del periodo classico (come le Georgiche di Virgilio). Si tratterebbe dunque di "libri di cose da satiri", cioè "racconti satireschi", perché connessi alla figura del satiro. I codici, tuttavia, come si è detto, tramandano come titolo dell'opera anche Satirarum libri, termine che invece farebbe riferimento al genere letterario della satura latina, una forma di poesia legata alla vita quotidiana, con le sue difficoltà e le sue miserie. Entrambe le accezioni del titolo, ad ogni modo, convergono nel definire il genere dell'opera come comico-satirico di contenuto licenzioso.
Eugenio Giovannetti (Ancona, 25 febbraio 1883 – Roma, 1º maggio 1951) è stato un giornalista, scrittore e traduttore italiano.

Edoardo Sanguineti (Genova, 9 dicembre 1930 – Genova, 18 maggio 2010) è stato un poeta, scrittore, drammaturgo, critico letterario, traduttore, accademico, saggista e politico italiano, che fece parte del Gruppo 63.

Barbanera è un celebre almanacco stampato per la prima volta a Foligno intorno alla metà del Settecento, ancora oggi pubblicato annualmente e diffuso su tutto il territorio nazionale. Fin dalle prime edizioni, esce parallelamente nella forma di calendario da parete e almanacco tascabile e propone tradizionalmente, oltre al calendario, alle previsioni meteorologiche e all'indicazione delle fasi lunari, effemeridi, consigli per l'agricoltura e la vita in casa, curiosità, proverbi, "aneddoti, ricette empiriche e previsioni stravaganti ma sempre possibili e talvolta avveratesi, donde la sua celebrità". Grazie a una fitta rete di distribuzione e all'originalità e utilità dei suoi contenuti, diviene già nell'Ottocento tanto popolare da essere oggetto di molteplici imitazioni in tutta Italia. Il nome che lo contraddistingue deriva forse dall'immagine riportata sui frontespizi delle edizioni più antiche, che ritraevano un uomo dalla folta barba nera, definito astronomo, astrologo e filosofo. Raffigurato con i suoi strumenti di lavoro (così come compare ancora oggi nel francobollo a lui dedicato dalle Poste italiane), presentava in rima la propria vocazione: La grande diffusione dell'almanacco e il fascino misterioso del personaggio fanno sì che il termine "barbanera" entri nel gergo comune fino a divenire nel tempo sinonimo stesso di "almanacco" e "lunario", come attestano diversi dizionari. La natura popolare e la diffusione nei tempi passati soprattutto nelle campagne di lunari provvisti di previsioni e predizioni sul futuro, porta a un utilizzo estensivo del termine Barbanera anche come "trattato scadente di astrologia" o di "astrologo sprovveduto". Questo uso contraddice però l'utilizzo di una locuzione quale “perdere il lunario” proprio nel senso opposto di perdere il buon senso.