- Libri preferiti
Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti
Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

La gnoseologia (AFI: /ɲozeoloˈʤia/; dal greco gnòsis, «conoscenza», + lògos, «discorso»), chiamata anche teoria della conoscenza, è quella branca della filosofia che studia la natura della conoscenza. In particolare, così come si è consolidata nell'età moderna ad opera della speculazione filosofica di Kant, la gnoseologia si occupa dell'analisi dei fondamenti, dei limiti e della validità della conoscenza umana, intesa essenzialmente come relazione tra soggetto conoscente e oggetto conosciuto.Occorre precisare che nell'ambito della cultura anglosassone la teoria della conoscenza è chiamata anche e soprattutto epistemology, laddove in Italia con il termine epistemologia si designa essenzialmente quella branca della gnoseologia che si occupa della conoscenza scientifica o, in un senso ancora più specifico, la filosofia della scienza.
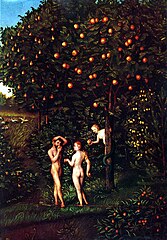
La conoscenza è la consapevolezza e la comprensione di fatti, verità o informazioni ottenute attraverso l'esperienza o l'apprendimento (a posteriori), ovvero tramite l'introspezione (a priori). La conoscenza è l'autocoscienza del possesso di informazioni connesse tra di loro, le quali, prese singolarmente, hanno un valore e un'utilità inferiori.

La lista seguente fornisce un elenco non esaustivo delle diverse branche della conoscenza umana con le relative definizioni, basato principalmente sulla gerarchia del Nuovo soggettario, che è il tesauro della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
La sociologia della conoscenza studia le modalità di accesso alla conoscenza degli oggetti o del sapere cosiddetto scolastico, ovvero le modalità di produzione di tale sapere. Essa assume dunque posizione biunivoca, concentrandosi sia sugli aspetti di possibilità del conoscere (la cui riflessione metodologica non si distanzia molto dalla riflessione gnoseologica della filosofia della conoscenza), sia su quelli legati all'introduzione di un particolare sapere nella realtà sociale. Propriamente l'origine non è "gnoseologica" ma si rifà al concetto di Wissen: è la "sociologia del sapere" fondata e sviluppata da Max Scheler, poi ripresa nel senso di "sociologia della conoscenza" da Karl Mannheim. La sociologia del sapere in Scheler fa riferimento alle forme della Bildung, cioè alla sedimentazione delle tecniche con cui l'uomo dà forma alla propria esistenza. Karl Mannheim propone di considerare i rapporti tra l'essere situato nel mondo e il pensiero, che sarebbe relato appunto alla struttura sociale nella quale l'essere è gettato. Egli propone per la sociologia della conoscenza una "sfera libera" e indipendente dalla quale poter analizzare e ricostruire le diverse contingenze storiche delle produzioni del sapere e per favorire una ricerca gnoseologica sul problema della validità delle teorie. In questo modo però si esponeva alle abbondanti e inevitabili critiche dovute all'assenza di riflessività: questa rimane la spina nel fianco di qualsiasi teoria "sociologica" (ma già Baruch Spinoza ne abbozzò la legittimità) sulla conoscenza, in quanto basantesi sul principio opposto alla teoria filosofica della conoscenza, che attribuisce all'uomo facoltà conoscitive immutabili e universali (vedi Kant), e cioè sul radicamento delle possibilità del sapere nell'esserci. Grande influenza nella diffusione Sociologia della Conoscenza ebbe il sociologo Kurt Heinrich Wolff, per aver tradotto dal tedesco all'inglese, pubblicato e fatto conoscere negli Stati Uniti molti degli scritti di Karl Mannheim e di Georg Simmel. Nella contemporaneità il tema della conoscenza è ampiamente dibattuto in ottica transdisciplinare da autori quali Elinor Ostrom e Charlotte Hess. In riferimento alla definizione della sociologia della conoscenza essa va rapportata senz'altro alla ricerca di nessi che intercorrono tra le condizioni sociali, la situazione storica, i soggetti e gli elementi culturali a contenuto cognitivo che vengono elaborati dai soggetti stessi, laddove è evidente la ricerca della genesi sociale del sapere (Cfr. Guglielmo Rinzivillo, Natura e origine della sociologia della conoscenza in AAVV, Rassegna Storiografica Decennale, Limina Mentis, Villasanta (MB), 2018, p. 53 e sg, ISBN 978-88-99433-96-3).

La copia conoscenza o copia carbone (cc o c.c.) è una modalità di creazione simultanea di più copie di un documento che prevede l'aggiunta al documento dell'abbreviazione "cc" seguita da un elenco di destinatari, detti appunto destinatari in copia conoscenza. Essa è utilizzata sia con documenti cartacei che per invii di posta elettronica; poiché il processo di copia cartacea avveniva generalmente mediante carta carbone, essa è anche detta copia carbone (in inglese carbon copy). La copia conoscenza è anche l'intestazione "Cc:" dei messaggi di posta elettronica che rappresenta appunto l'acronimo dell'espressione inglese carbon copy. L'invio in copia conoscenza, invece, è una modalità di comunicazione molto diffusa in ambito aziendale, che prevede l'invio di copie conoscenza ai destinatari in copia conoscenza, questi ultimi nelle e-mail possono essere indicati nel campo "Cc:".