- Libri preferiti
Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti
Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti
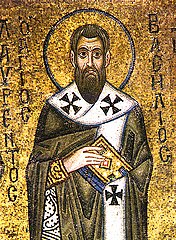
Basilio Magno, il Grande; in greco: Βασίλειος ὁ Μέγας, Basíleios ho Mégas; in latino Basilius Magnus (Cesarea in Cappadocia, 329 – Cesarea in Cappadocia, 1º gennaio 379), è stato un vescovo e teologo greco antico, venerato dalle Chiese cristiane; porta anche i titoli di confessore e Dottore della Chiesa. È considerato il primo dei Padri cappadoci. Era figlio di un ricco retore e avvocato, mentre suo nonno, che fu discepolo di Gregorio Taumaturgo del Ponto, morì martire nella persecuzione di Diocleziano. Sua nonna Macrina, la madre Emmelia, i fratelli Gregorio (vescovo di Nissa) e Pietro (vescovo di Sebaste) e la sorella primogenita, Macrina, sono pure venerati dalla Chiesa cattolica come santi. Fu molto amico di Gregorio Nazianzeno, venerato come santo e commemorato nello stesso giorno, il 2 gennaio. Ha scritto la regola che ancora oggi ispira la vita dei Monaci basiliani.

Pietro Crisologo (Imola, fine IV secolo – Imola, 2 dicembre 450) è stato vescovo di Ravenna; è venerato come santo dalla Chiesa cattolica che nel 1729 (regnante papa Benedetto XIII), l'ha proclamato dottore della Chiesa. È festeggiato il 30 luglio o il 4 dicembre.

Papa Paolo VI (in latino: Paulus PP. VI, nato Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini; Concesio, 26 settembre 1897 – Castel Gandolfo, 6 agosto 1978) è stato il 262º vescovo di Roma e papa della Chiesa cattolica, primate d'Italia e 4º sovrano dello Stato della Città del Vaticano a partire dal 21 giugno 1963 fino alla morte. Venerabile dal 20 dicembre 2012, dopo che papa Benedetto XVI ne aveva riconosciuto le virtù eroiche, è stato beatificato il 19 ottobre 2014 e proclamato santo il 14 ottobre 2018 da papa Francesco.
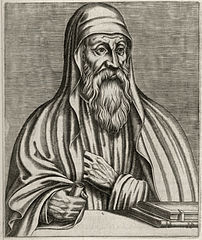
Orìgene, noto anche come Origene di Alessandria (in greco antico: Ὠριγένης, Ōrigénēs, detto Adamanzio; in latino: Origenes Adamantius, «resistente come il diamante»; Alessandria d'Egitto, 185 – Tiro, 254), è stato un teologo e filosofo greco antico. È considerato uno tra i principali scrittori e teologi cristiani dei primi tre secoli. Di famiglia greca, fu direttore della Scuola catechetica di Alessandria. Interpretò la transizione dalla filosofia pagana al cristianesimo e fu l'ideatore del primo grande sistema di filosofia cristiana. Scrisse molti testi di natura teologica, anche se, per umiltà, non alluse quasi mai a se stesso nelle sue opere. Tuttavia, Eusebio di Cesarea gli dedicò quasi l'intero sesto libro della Storia ecclesiastica; inoltre, in collaborazione con Panfilo di Cesarea compose l'Apologia per Origene; tale opera, che pure ai suoi tempi poteva essere considerata di parte, dimostra tuttavia che Eusebio era ben informato sui dettagli della vita e del pensiero di Origene. Delle sue opere si trovano tracce anche nelle opere di Gregorio Taumaturgo, nelle controversie tra Sofronio, Eusebio di Cesarea, Girolamo e Tirannio Rufino, in Epifanio di Salamina e in Fozio I di Costantinopoli. Origene Adamanzio non deve essere confuso con l'omonimo filosofo pagano.

La nascita e lo sviluppo dell'iconografia cristiana nei primi secoli può essere compresa solo alla luce della concezione che ebrei, greci e romani avevano delle immagini.

Il Grande Scisma, conosciuto dalla storiografia occidentale come Scisma d'Oriente e definito dagli Ortodossi Scisma dei Latini, fu l'evento che, rompendo l'unità di quella che fu la Chiesa di Stato dell'Impero romano basata sulla Pentarchia, divise la Cristianità Calcedonese fra la Chiesa cattolica occidentale, che aveva sviluppato il concetto del primato (anche giurisdizionale) del Vescovo di Roma (in quanto considerato successore dell'Apostolo Pietro), e la Chiesa ortodossa orientale, che invece riteneva di rappresentare la continuità della chiesa indivisa del primo millennio, senza cedimenti a quelle che riteneva innovazioni dei Latini. Sebbene normalmente si indichi il 1054 come anno dello scisma, ossia quando papa Leone IX, attraverso i suoi legati, lanciò la scomunica al patriarca Michele I Cerulario e quest'ultimo, a sua volta, rispose con un proprio anatema scomunicando i legati, lo Scisma fu in realtà il risultato di un lungo periodo di progressivo distanziamento fra le due Chiese. Le dispute alla base dello scisma erano sostanzialmente due. La prima riguardava l'autorità papale: il papa (ossia il vescovo di Roma), ritenendosi investito del primato petrino su tutta la Chiesa per mandato di Cristo, da cui avrebbe ricevuto le "chiavi del Regno dei Cieli" e l'autorità di "pascerne gli agnelli" (cfr. i Vangeli di Matteo e Giovanni) e quindi di un vero potere giurisdizionale (secondo il linguaggio rabbinico conferire le chiavi a qualcuno significa investirlo di un'autorità), iniziò a reclamare la propria "naturale" autorità anche sui quattro patriarcati orientali (Costantinopoli, Alessandria, Antiochia e Gerusalemme, che, con Roma, formavano la cosiddetta pentarchia). Questi erano disposti a concedere al Patriarca d'Occidente un primato solo onorario e a lasciare che la sua autorità effettiva si estendesse solo sui cristiani d'Occidente, ritenendo il primato romano privo di fondamento scritturistico. L'altra disputa, di ambito trinitario e apparentemente meno "politica" concerneva l'aggiunta del Filioque nel Credo niceno, avvenuta in ambito latino. Esistevano inoltre altre cause, meno significative, fra le quali talune variazioni di certi riti liturgici (questione dell'uso del pane azzimo durante l'eucaristia, il matrimonio dei preti, la confermazione dei battezzati riservata soltanto al vescovo, ecc.). Ma anche e soprattutto ragioni politiche (alleanza papale con Franchi e Normanni) e rivendicazioni conflittuali di giurisdizione (nel sud Italia, nei Balcani e nell'area slava). La Chiesa si divise lungo linee dottrinali, teologiche, linguistiche, politiche e geografiche, e la frattura fondamentale non si è, finora, più rinsaldata. Si ebbero, in effetti, due formali riunioni dell'Oriente con Roma, nel 1274 (nel Secondo Concilio di Lione) e nel 1439 (nel Concilio di Firenze), ma in entrambi i casi le riconciliazioni tra Roma e l'Oriente furono poi disconosciute dai fedeli e dal basso clero delle Chiese orientali, in quanto i capi spirituali che vi presero parte, nel consentire queste cosiddette "unioni", avrebbero oltrepassato la propria autorità, non ottenendo alcuna ritrattazione da parte latina delle "prassi" controverse affermatesi in Occidente. Gli ulteriori tentativi di riconciliare le chiese d'oriente e quella di Roma fallirono, tuttavia alcune comunità ecclesiastiche, inizialmente Ortodosse, nel corso dei secoli cambiarono giurisdizione, riconoscendo l'autorità del papa e diventando Cattoliche. Tali comunità sono ora dette Chiese cattoliche di rito orientale ovvero Uniati (termine spregiativo con cui gli ortodossi indicano coloro i quali si sono sottomessi a Roma, accettandone il contestato primato giurisdizionale). Seppure la maggioranza delle fonti pongano come anno decisivo il 1054, altri fanno risalire lo Scisma ad anni (ed eventi) diversi: il 1204, anno del Sacco di Costantinopoli per opera dei Veneziani tramite i Crociati latini, trasportati dalla loro flotta; il 1484, anno in cui la Chiesa ortodossa rigettò il Concilio di Firenze con il sinodo indetto da Simeone I, patriarca di Costantinopoli (su insistenza del Sultano).Il dato di fatto è che tuttora la Chiesa cattolica occidentale e quella Ortodossa orientale rimangono separate, anche se entrambe continuano a definirsi una, santa, cattolica ed apostolica (in ossequio al Credo niceno-costantinopolitano) e a rivendicare la propria "ortodossia", dando a intendere che, con lo scisma, sia stata l'altra parte ad aver lasciato la chiesa d'origine.

Giuseppe Dossetti (Genova, 13 febbraio 1913 – Oliveto di Monteveglio, 15 dicembre 1996) è stato un presbitero, giurista, politico, teologo e accademico italiano.

Angelo Comastri (Sorano, 17 settembre 1943) è un cardinale e arcivescovo cattolico italiano, arciprete della basilica di San Pietro in Vaticano, presidente della Fabbrica di San Pietro e vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano e per le Ville pontificie di Castel Gandolfo.
L'accolito (dal greco ἁκόλουθος, akòluthos, reso in latino tardo acolythus, corrispondente nel significato al latino sequens o comes: seguace, attendente) è un ministro della liturgia a servizio dell'altare e delle processioni, in aiuto del diacono e del sacerdote in alcune Chiese cristiane: nella Chiesa cattolica, nelle Chiese della Comunione anglicana, nelle Chiese luterane e in alcune Chiese metodiste. Il termine indica propriamente colui che ha ricevuto l'accolitato, ed anche i ministranti che svolgono alcune delle funzioni dell'accolito istituito od ordinato.