- Libri preferiti
Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti
Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti
Raffaello Consortini (Volterra, 18 maggio 1908 – Volterra, 22 ottobre 2000) è stato uno scultore italiano.

La Pinacoteca civica di Follonica è un museo d'arte contemporanea situato a Follonica (GR).

Livorno (pronuncia: [liˈvorno], ) è un comune italiano di 156 299 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Toscana. Terza città della regione per popolazione (dopo Firenze e Prato), ospita da sola quasi la metà degli abitanti della propria provincia; con i comuni limitrofi di Pisa e Collesalvetti costituisce inoltre un vertice di un "triangolo industriale", la cui popolazione complessiva ammonta a oltre 260 000 abitanti. È situata lungo la costa del Mar Ligure ed è uno dei più importanti porti italiani, sia come scalo commerciale sia come scalo turistico, centro industriale di rilevanza nazionale, da tempo in declino, tanto da essere riconosciuta nel 2015 come "area di crisi industriale complessa". Tra tutte le città toscane è solitamente ritenuta la più moderna, sebbene nel suo territorio siano presenti diverse testimonianze storiche, artistiche e architettoniche sopravvissute ai massicci bombardamenti della seconda guerra mondiale e alla successiva ricostruzione. La città, notevolmente sviluppatasi dalla seconda metà del XVI secolo per volontà dei Medici prima e dei Lorena in seguito, fu importante porto franco frequentato da numerosi mercanti stranieri, sede di consolati e compagnie di navigazione. Ciò contribuì ad affermare, sin dalla fine del Cinquecento, i caratteri di città multietnica e multiculturale per eccellenza, dei quali sopravvivono importanti vestigia, quali chiese e cimiteri nazionali, palazzi, ville e opere di pubblica utilità indissolubilmente legate ai nomi delle importanti comunità straniere che frequentarono il porto franco fino alla seconda metà dell'Ottocento. Questa vocazione internazionale portò a identificare la città come Leghorn nel Regno Unito e negli Stati Uniti d'America, Livourne in Francia, Liorna in Spagna, ecc., analogamente alle più importanti capitali di stato dell'epoca. Tra il XIX secolo e i primi anni del Novecento, parallelamente all'avvio del processo di industrializzazione, Livorno fu anche una meta turistica di rilevanza internazionale per la presenza di rinomati stabilimenti balneari e termali, che conferirono alla città l'appellativo di Montecatini al mare. Livorno è sede dell'Accademia navale della Marina Militare, del comando e di due reggimenti della Brigata paracadutisti "Folgore" dell'Esercito Italiano, del 1º Reggimento carabinieri paracadutisti "Tuscania", del 9º Reggimento d'assalto paracadutisti "Col Moschin" inquadrato nelle forze speciali dell'Esercito Italiano e del Gruppo di intervento speciale dei Carabinieri; inoltre è sede di Direzione Marittima del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.
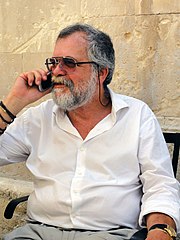
Gregorio Rossi (Massa Marittima, 25 maggio 1951) è uno storico dell'arte italiano.

Marcello Marchesi (Milano, 4 aprile 1912 – Cabras, 19 luglio 1978) è stato uno scrittore, sceneggiatore, regista cinematografico e teatrale, paroliere, cantante e attore italiano. Fu anche autore di programmi televisivi e radiofonici, giornalista, pubblicitario e talent scout (lanciò fra gli altri Sandra Mondaini, Gino Bramieri, Walter Chiari, Gianni Morandi, Cochi e Renato, Paolo Villaggio). A lui si devono gli slogan pubblicitari più famosi della televisione italiana del XX secolo: «Con quel sorriso può dire ciò che vuole», «Non è vero che tutto fa brodo», «Il brandy che crea un'atmosfera», «Il signore sì che se ne intende».

Marcello Fois (Nuoro, 20 gennaio 1960) è uno scrittore, commediografo e sceneggiatore italiano.

Marcella Bella, all'anagrafe Giuseppa Marcella Bella (Catania, 18 giugno 1952), è una cantante italiana.

Eaismo (da Era Atomica -ismo), fu un'avanguardia artistica il cui manifesto venne stilato e firmato il 3 settembre 1948 a Livorno da Voltolino Fontani (pittore ed ideatore del movimento), Angelo Sirio Pellegrini (pittore), Marcello Landi (poeta e pittore), Guido Favati (poeta) e Aldo Neri (pittore). Quest'ultimo, in un articolo del 20 dicembre 1948 pubblicato sul quotidiano Il Tirreno di Livorno, si autodefinì primo firmatario più che concreto estensore concettuale del manifesto dell'Eaismo. Secondo l'Eaismo l'umanità stava entrando in un periodo nel quale improvvisamente risultava evidente l'inadeguatezza della dimensione morale dell'umanità nel suo complesso, rispetto alle magnifiche possibilità tecnico-scientifiche che di colpo in senso tragicamente negativo, con i devastanti bombardamenti nucleari sul Giappone, tutti si rendevano conto di possedere e di dovere con grandissima saggezza contribuire a gestire in maniera non drammatica ed apocalittica.Si legge infatti nel Manifesto dell'Eaismo: In senso estetico visivo stretto, la pittura e la poesia eaiste avevano il compito di rappresentare la frammentazione della materia con esplicito riferimento alla sua traumatica scomposizione fisico molecolare, ma dovevano anche suggerire la simultanea, costante, indispensabile presenza dell'umanità e dell'uomo nel suo contemporaneo, problematico divenire. Quindi l'Eaismo si proponeva di inserire in ogni singolo dipinto ed in ogni singola poesia la scomposizione della materia ed altresì la contemporanea presenza dell'uomo (anche soltanto nella sua intuibilità visiva). Soprattutto premeva agli eaisti evidenziare la necessità di un'arte "progressiva" e quindi "aderente all'epoca", che non si identificasse tuttavia in un realismo troppo crudo ma che suggerisse la profonda inquietudine determinata dal progresso.L'Eaismo ebbe una sua coerente dimensione tra il 1948 ed il 1959 e precedette temporalmente parte delle sintesi visive e delle istanze propugnate successivamente nell'arte nucleare italiana ed europea degli anni cinquanta.I protagonisti dell'Eaismo furono: Voltolino Fontani, pittore, ideatore del movimento; Angelo Sirio Pellegrini, pittore figurativo/colorista; Marcello Landi, poeta livornese del dopoguerra nonché pittore; Guido Favati, poeta e filologo, docente all'Università di Pisa, ed infine Aldo Neri, pittore ed insegnante d'arte. Inoltre parteciparono negli anni cinquanta alle esposizioni eaiste: Giulio Guiggi, scultore, i pittori Danilo Gedè, Corrado Carmassi, Giuseppe Roffi e il poeta Germano Fontani. La scarsa coesione degli Eaisti, che non andarono al di là dell'elaborazione di un singolo manifesto, e la mancata diffusione in ambito nazionale e internazionale di mostre e conferenze decretarono la fine del movimento, che rimase confinato alla Toscana, nonostante una discreta divulgazione sulla stampa nazionale della notizia della pubblicazione del manifesto stesso e alcuni approfondimenti ad opera anche di personalità di spicco del mondo della cultura.Il movimento si esaurì in un decennio, ma si sviluppò in modo originale ed autonomo. Una sua rivalutazione è in corso da alcuni anni. Nel dicembre del 1996 a Livorno si svolse un incontro pubblico sull'Eaismo con Giuseppe Argentieri come moderatore, Luciano Bonetti, Riccardo Rossi Menicagli e, tra molti altri artisti, la presenza di uno degli ideatori dell'Eaismo Angelo Sirio Pellegrini; nel 2004, presso la Galleria Giraldi a Livorno, si tenne una mostra, focalizzata sulla produzione eaista e nucleare dell'assertore più tenace dell'Eaismo, Voltolino Fontani, curata da Francesca Cagianelli e promossa dal "Comitato per la divulgazione della figura pittorica di Voltolino Fontani" (trasformatosi nel 2011 in "Archivio Voltolino Fontani"). Nell'ottobre del 2014 si è concretizzato un nuovo contributo scientifico sull'Eaismo a firma di Martina Corgnati. Il 4 dicembre 2018, in occasione del settantesimo anniversario della fondazione del movimento Eaista, hanno avuto luogo, presso il Museo Civico Giovanni Fattori, il convegno organizzato dal Comune di Livorno dal titolo EAISMO - Livorno 1948 - Nasce l'arte dell'Era Atomica con relatori in ordine d'intervento Gianni Schiavon, Riccardo Rossi Menicagli, Michele Pierleoni e Giacomo Romano e la concomitante mostra esemplificativa che ha visto riuniti tutti i pittori firmatari del manifesto. Gli atti del convegno sono stati presentati pubblicamente, nello stesso Museo Fattori, il 15 maggio del 2019 dall'Archivio Voltolino Fontani, che ne ha curato la pubblicazione in collaborazione con il Comune di Livorno.

Amedeo Clemente Modigliani, noto anche con i soprannomi di Modì e Dedo (Livorno, 12 luglio 1884 – Parigi, 24 gennaio 1920), è stato un pittore e scultore italiano, celebre per i suoi sensuali nudi femminili e per i ritratti caratterizzati da volti stilizzati, colli affusolati e sguardo spesso assente. Si formò in Italia, andando dalla Toscana a Venezia e passando per il Mezzogiorno, fino a quando non giunse a Parigi nel 1906. La città francese era all'epoca la capitale europea delle avanguardie artistiche e in Francia entrò in contatto con personaggi come Pablo Picasso, Maurice Utrillo, Max Jacob, Jacques Lipchitz, Chaïm Soutine e altri. A Parigi frequentò anche importanti scrittori e poeti, come - ad esempio - Giuseppe Ungaretti. In Francia conobbe anche la pittrice Jeanne Hébuterne, destinata a divenire sua compagna di vita oltre che musa per i suoi dipinti. Nel 1909 iniziò ad avvicinarsi alla scultura ma, sebbene fosse il suo ideale artistico, dovette abbandonarla ben presto nel 1914 a causa delle precarie condizioni fisiche; da allora si dedicò solamente alla pittura, andando così a produrre una notevole quantità di dipinti, dai quali tuttavia non ricavò alcuna ricchezza. Artista bohémien, Modigliani non disdegnò certo il bere e l'uso di sostanze nocive, andando così a compromettere la sua instabile salute fisica già minata dalla tubercolosi, che infatti lo portò alla morte all'età di soli trentacinque anni, proprio all'apice del suo successo. È sepolto nel cimitero parigino di Père-Lachaise, insieme alla sua compagna Jeanne che, incinta del loro secondo figlio, si suicidò solo due giorni dopo la sua morte.