- Libri preferiti
Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti
Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti
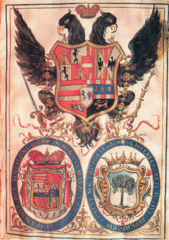
Le universitates (dal latino universitas, -tis), definite anche università del Regno (o semplicemente "università"), è il termine che generalmente indicava i comuni dell'Italia meridionale, sorti già sotto la dominazione longobarda e successivamente infeudati con le conquiste dei Normanni. La loro evoluzione storica è differente rispetto ai liberi comuni sorti nell'Italia centro-settentrionale nel Medioevo. Più in generale sono "uno specifico ente collettivo, la universitas civium o universitas loci, che si autogoverna entro certi ambiti e con determinati poteri tradizionali, in dipendenza da un’autorità superiore di varia natura (regia, feudale, cittadina) con la quale contratta in occasioni ordinarie o straordinarie (dedizioni, rese, passaggi di signoria o di dinastia) sia la propria costituzione (e la riforma della stessa), sia le modalità, talvolta anche la consistenza, delle proprie contribuzioni in denaro e in servizi". Durante il dominio di Federico II si usava il termine "comune", mentre Carlo I d'Angiò lo mutò in universitas (da universi cives, "unione di tutti i cittadini"), ordinando la distruzione dei sigilli comunali. Esse sopravvissero sino all'abolizione del feudalesimo avvenuta con decreto del 2 agosto 1806, ad opera di Giuseppe Bonaparte.
La storia di Cerreto Sannita comprende una serie di eventi che hanno interessato il territorio cittadino sin dall'età neolitica. Tre sono gli insediamenti urbani che hanno unito la popolazione locale in epoche differenti: Cominium Ocritum (nome successivamente volgarizzato in Cominium Cerritum), villaggio sannita citato da Tito Livio durante le vicende della seconda guerra punica; la vecchia Cerreto, costruita a seguito delle invasioni saracene e distrutta dal terremoto del 5 giugno 1688, ed infine l'attuale Cerreto Sannita, edificata fra il 1688 ed il 1696 su progetto del regio ingegnere Giovanni Battista Manni e per volontà del conte Marzio Carafa, di suo fratello Marino Carafa e del vescovo Giovanni Battista de Bellis. Sede vescovile dal XVI secolo, fu dal 1151 al 1460 feudo dei Sanframondo, per divenire poi possedimento dei Carafa che la eressero «CIVITAS TOTIUS SUPERIORIS STATE METROPOLIS» (città capoluogo della contea superiore). Le floride ricchezze provenienti dalle industrie e dal commercio dei panni lana contribuirono a creare un forte ceto mercantile che resistette per secoli ai continui soprusi dei feudatari.

Cerreto Sannita (IPA: [ʧerˈretosanˈnita], Cerrìte, in dialetto cerretese, IPA:[tʃə'rːitə]) è un comune italiano di 3 789 abitanti della provincia di Benevento in Campania. Feudo della famiglia Sanframondo dal 1151 al 1460, nel 1483 passò ai Carafa che eressero Cerreto Sannita "Civitas totius superioris state metropolis" (città capoluogo della contea superiore). Nel XVII secolo divenne sede dei vescovi della diocesi telesina che nel 1986 è diventata diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant'Agata de' Goti. Nel 1737 la cittadina si ribellò ai conti Carafa a causa del regime di polizia imposto ai cerretesi e delle esose imposte che stavano mettendo in ginocchio l'industria della lavorazione dei panni lana. I Carafa inviarono centoventi mercenari per sedare la rivolta ed eseguirono numerose violenze e carcerazioni arbitrarie. Solo grazie all'intervento del re Carlo III fu ripristinata la legalità ei cerretesi riuscirono ad ottenere i primi risultati a livello giudiziario anche se l'industria armentizia, che per secoli aveva creato ricchezza per i cerretesi, era ormai in declino.Il comune, conosciuto per la secolare arte della ceramica, possiede un centro storico strutturato su un impianto regolare essendo stato interamente ricostruito su progetto di Giovanni Battista Manni e dietro volontà del conte Marzio Carafa e di suo fratello Marino dopo che il terremoto del 5 giugno 1688 aveva raso al suolo l'abitato precedente (Cerreto antica).

Biagio Gambaro (Napoli, 2 febbraio 1650 – Cerreto Sannita, 16 ottobre 1721) è stato un vescovo cattolico italiano.