- Libri preferiti
Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti
Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti
Le religioni abramitiche sono quelle che rivendicano Abramo (in ebraico "Abraham" אַבְרָהָם,; in Arabo "Ibrahim" ابراهيم) come parte della loro storia sacra. Il concetto di religioni abramitiche è recente ed è divenuto di uso comune solo negli ultimi due o tre decenni, spesso usato in alternativa ad altre denominazioni, come "religioni monoteiste", o "religioni del Libro" per indicare l'Ebraismo, il Cristianesimo e l'Islam. Sulla terra vi sono anche le religioni dharmiche e le religioni taoiche. Il concetto di "religione abramitica" è un concetto controverso. È nota presso gli storici delle religioni la teoria e prassi teologica della "tolleranza all'indietro", per cui un Bahaista riconoscerà sia l'Ebraismo sia il Cristianesimo che l'Islam come "religione abramitica" e aggiungerà la propria religione al novero delle religioni abramitiche, un musulmano (il concetto di religioni abramitiche è di origine islamica) riconoscerà come abramitiche Ebraismo, Cristianesimo e la propria religione, ma escluderà i Bahai, un cristiano teologicamente coerente parlerà di "tradizione giudaico-cristiana", mentre un giudaico osservante non riconoscerà, almeno dal punto di vista teologico, nessuno dei "fratelli minori".

La pace una condizione sociale, relazionale, politica (per estensione anche personale ovvero intraindividuale, o eventualmente legata ad altri contesti), caratterizzata dalla presenza di condivisa armonia e contemporanea assenza di tensioni e conflitti. La pace che si instaura tra due nazioni in seguito a una guerra pu trarre origine dalla cessazione del conflitto per comune accordo fra le nazioni coinvolte oppure essere imposta quando il suo mantenimento possibile sotto il rispetto di condizioni dettate dalla nazione che ha vinto il conflitto o quando la superiorit di una delle parti tale da scongiurare qualsiasi azione di rivolta da parte della nazione in condizione di inferiorit .Il termine deriva dal latino pax (il quale a sua volta si fa derivare dalla radice indoeuropea pak-, pag- fissare, pattuire, legare, unire, saldare; alla quale sono legate anche pagare e pacare) ed il contrapposto di bellum (guerra) in senso politico e sociologico, ovvero dello stato dei rapporti tra individui o gruppi di individui. Trattandosi di uno dei concetti pi antichi e profondi in senso antropologico, il termine ha assunto significati pi estensivi e generali, compresi verbi come "appacificare" e "rappacificare", con i relativi riflessivi: "appacificarsi" e "rappacificarsi". Per ulteriore estensione semantica, il concetto di pace come "non-turbamento" poi passato dai campi sociologico e politico a quello individuale in senso spiccatamente psicologico, assumendo il significato di pace dell'anima o pace interiore, ovvero uno stato di quiete o tranquillit dell'animo umano percepita come assenza di turbamenti e agitazione. Tale pace interiore (o dell'animo) ben risponde agli antichi concetti di eutim a (in Democrito), di apon a (in Epicuro), di atarassia (negli stoici), di eireneusi in etiche recenti. Pi specificatamente, la pace viene considerata (o dovrebbe essere considerata, secondo l'opinione corrente) un valore universalmente riconosciuto che sia in grado di superare qualsiasi barriera sociale e/o religiosa ed ogni pregiudizio ideologico, in modo da evitare situazioni di conflitto fra due o pi persone, due o pi gruppi, due o pi nazioni, due o pi religioni.
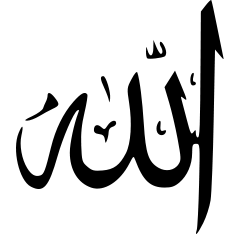
L'Islam (pronunciato in italiano AFI: /iˈzlam/ (tradizionale) o /ˈizlam/ (comune); in arabo: إسلام, Islām [ʔɪˈslæːm]) è una religione monoteista abramitica manifestatasi per la prima volta nella penisola araba, nella cittadina higiazena della Mecca, nel VII secolo dell'era cristiana ad opera di Maometto, considerato dai musulmani l'ultimo profeta portatore di legge, «sigillo dei profeti» (Khātam al-Nabiyyīn), inviato da Allah al mondo per ribadire definitivamente la rivelazione, annunciata per la prima volta ad Adamo, il primo uomo e il primo profeta. Con circa 1,8 miliardi di fedeli, ossia il 23% della popolazione mondiale, l'islam è la seconda religione del mondo per consistenza numerica (dopo il cristianesimo) e vanta un tasso di crescita particolarmente significativo.Il 13% dei musulmani vive in Indonesia, che è anche il paese musulmano più popolato, il 25% nell'Asia meridionale, il 20% in Vicino Oriente, Maghreb e Medio Oriente e il 15% nell'Africa subsahariana. Minoranze considerevoli si trovano anche in Europa, Cina, Russia e America. Il simbolo della mezzaluna islamica è stato introdotto dagli Ottomani con la presa di Costantinopoli nel 1453. Il verde sarebbe per molti il colore dell'Islam (si vedano il mantello verde di Maometto e oggi le bandiere dell'Arabia Saudita, dell'Algeria, del Pakistan e della Lega araba), mentre per altri sarebbe il colore del solo sciismo (vedi una volta la bandiera dei fatimidi), ma in realtà Maometto e i suoi generali usavano indifferentemente anche vessilli di color bianco (vedi l'uso fattone cerimonialmente dagli Omayyadi), nero (dal califfato dei Rashidun e dagli Abbasidi) e rosso (si vedano oggigiorno gli sciiti kizilbash e le bandiere della Tunisia e della Turchia).
Nella teologia cristiana la questione riguardante la giustificazione parte dal presupposto biblico che la creatura umana non è, nella sua attuale condizione, "a posto", "in linea", "giusta", rispetto ai criteri di giustizia stabiliti e rivelati da Dio stesso, perché essa è caratterizzata dal peccato. La creatura umana, così come essa si trova, non è "accettabile" agli occhi di Dio. Ci si pone quindi il problema di come essa possa tornare a diventare giusta di fronte a Dio, come essa possa essere "riabilitata". La risposta a questa domanda nasce dalla Bibbia e va cercata e trovata nella Bibbia stessa, considerata dai cristiani regola ultima della fede e della condotta, in quanto Parola di Dio. San Paolo ne parla nella prima lettera ai Corinzi in cui afferma che i peccatori non erediteranno il regno dei cieli se non per mezzo della giustificazione accettando Cristo. Nel corso della storia della Chiesa, questo tema è stato ampiamente dibattuto, specialmente nella Chiesa occidentale (in oriente non ha mai avuto particolare rilievo), a partire soprattutto da Agostino di Ippona e il suo antagonista Pelagio, forse come effetto della mentalità latina più portata ad una visione giuridica della fede. In particolare nella controversia protestante la dottrina della giustificazione è vista come fondamentale per il carattere della fede cristiana come religione di grazia e di fede, al cuore dell'Evangelo. Martin Lutero, ex monaco agostiniano, definisce questa dottrina articulus stantis vel cadentis ecclesiae tanto che una Chiesa che la rinneghi nella forma o nella sostanza potrebbe a malapena definirsi cristiana. Questa dottrina: Definisce il significato salvifico della vita e della morte di Cristo collegandole alla Legge di Dio (Romani 3:24ss; 5:16ss.). Manifesta la giustizia di Dio nel condannare e punire il peccato, la Sua misericordia nel perdonare ed accogliere i peccatori, e la Sua sapienza nell'esercizio armonioso di entrambi gli attributi (giustizia e misericordia) attraverso Cristo (Romani 3:23ss.). Rende chiaro che cosa sia la fede, cioè l'affidarsi fiduciosi alla morte espiatrice e alla risurrezione giustificante di Cristo (Romani 4:23ss; 10:8ss.), e fiducia in Lui solo per la giustizia (Filippesi 3:8,9). Rende chiaro che cosa sia la morale cristiana - l'osservanza della Legge di Dio per gratitudine verso il Salvatore rendendo superflua l'osservanza meritoria della legge da parte nostra per essere accolti da Dio (Romani 7:1-6; 12:1,2). Spiega ogni accenno, profezia e caso di salvezza nell'Antico Testamento (Romani 1:17; 3:21; 4:1ss). Sovverte l'esclusivismo israelita (Galati 2:15) e fornisce la base su cui la fede cristiana diventa una religione per il mondo (Romani 1:16; 3:29,30).Gran parte dei problemi che lo concernono sono di carattere etimologico. Il verbo latino justificare da cui deriva questo termine ha indubbiamente un carattere "forense", connota cioè un tribunale che dichiara un imputato "innocente", vale a dire "che non ha commesso il fatto". Se il carattere del termine è "forense", ci si pone quindi il problema su che base questo "tribunale" lo dichiari giusto, in particolare: Lo è di fatto? È stato reso, fatto, giusto? Oppure viene dichiarato giusto come se lo fosse veramente, ma di fatto non lo è? Il termine "giustificazione" va preso, però, solo nel suo significato etimologico, cioè "rendere giusto"?
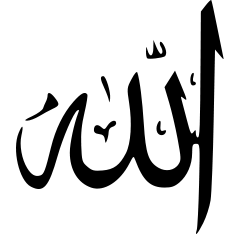
Nell'Islam, la divinità unica e creatrice di ogni cosa viene chiamata Allāh, come più volte specificato nel Corano. Nel Corano, che i musulmani credono sia opera creata ab aeterno, lettera per lettera, dallo stesso Allāh, si ricorda che un altro nome proprio è Raḥmān, parola già presente nel pantheon sud-arabico, cui si dava il significato di "Compassionevole", conservatosi anche in lingua araba. In età preislamica designava, in alcune culture religiose nord-arabiche (Palmirena) e sud-arabiche (Himyar), una divinità vera e propria.
Il cristianesimo e l'islam sono le due religioni con il maggiore numero di fedeli e condividono una comune tradizione storica, con alcune maggiori differenze teologiche. Le due fedi condividono lo stesso luogo d'origine, il Medio Oriente, e i rispettivi fedeli considerano la propria fede monoteistica. Esse presentano sia elementi comuni, come ad esempio il monoteismo e la tradizione biblica, che differenze tra i quali la concezione della Trinità e il ruolo di Gesù.

Chiara Lubich, all'anagrafe Silvia Lubich (Trento, 22 gennaio 1920 – Rocca di Papa, 14 marzo 2008), è stata una saggista e docente italiana, fondatrice del Movimento dei focolari che ha come obiettivo l'unità tra i popoli e la fraternità universale.. Donna carismatica, sin dai primi anni Quaranta ha rotto anzitempo stereotipi della figura femminile portando la donna ad una dimensione sociale e ad un ruolo nella Chiesa cattolica allora inediti . È nota per il costante impegno a gettare ponti di pace e di unità tra persone, generazioni, ceti sociali e popoli coinvolgendo persone di ogni età, cultura e credo ed è considerata una figura rappresentativa del dialogo ecumenico, interreligioso e interculturale come riconosciuto dall'Unesco che le ha conferito il Premio per l'Educazione alla pace 1996, dal Consiglio d'Europa col Premio Diritti Umani '98 e da numerosi altri riconoscimenti a livello culturale e sociale. È entrata nella storia della spiritualità contemporanea fra i maestri e mistici per la genuina ispirazione evangelica, la dimensione di universalità e l'incidenza culturale e sociale che caratterizzano il suo carisma, la sua spiritualità, il suo pensiero e la sua opera.

Canosa di Puglia (IPA: [ka no za di'pu a], Quan use in apulo-barese, fino al 1863 chiamata Canosa) un comune italiano di 29 588 abitanti della provincia di Barletta-Andria-Trani in Puglia. collocata sul margine nord-occidentale dell'altopiano delle Murge da cui domina la valle dell'Ofanto e l'estesa pianura del Tavoliere delle Puglie, spaziando dal monte Vulture al Gargano, alla costa adriatica. Canosa considerata uno dei principali centri archeologici della Puglia e rappresenta uno dei casi pi significativi di citt a lunghissima continuit di insediamento. Reperti e vasi canosini sono in tutti i principali musei (come i vasi antropomorfi permanentemente esposti al British Museum) e collezioni private del mondo ma, naturalmente, testimonianze del suo passato sono disseminate nella citt attuale e nel territorio circostante.