- Libri preferiti
Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti
Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti
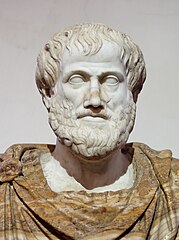
Aristotele (in greco antico: Ἀριστοτέλης Aristotélēs, pronuncia: [aristo'telɛːs]; Stagira, 384 a.C. o 383 a.C. – Calcide, 322 a.C.) è stato un filosofo, scienziato e logico greco antico. Aristotele è ritenuto una delle menti più universali, innovative, prolifiche e influenti di tutti i tempi, sia per la vastità che per la profondità dei suoi campi di conoscenza, compresa quella scientifica. Con Platone, suo maestro, e Socrate è considerato anche uno dei padri del pensiero filosofico occidentale, che soprattutto da Aristotele ha ereditato problemi, termini, concetti e metodi.

La Politica (in greco Τὰ πολιτιϰά) è un'opera di Aristotele dedicata all'amministrazione della polis. È suddivisa in otto libri, nei quali il filosofo analizza le realtà politiche a partire dall'organizzazione della famiglia, intesa come nucleo base della società, per passare ai diversi tipi di costituzione. Centrale è il riferimento alla natura: quest'opera contiene la celeberrima definizione dell'uomo quale «animale politico» (politikòn zôon), e in quanto tale portato per natura a unirsi ai propri simili per formare delle comunità. Nello stesso passo, Aristotele afferma anche che l'uomo è un animale naturalmente provvisto di logos, il che ben si accorda con la sua innata socialità, perché è mediante i logoi che gli uomini possono trovare un terreno di confronto. Diversamente da Antifonte e altri sofisti, secondo i quali la polis limita con le sue leggi la natura dell'uomo, per lo Stagirita lo Stato risponde ai bisogni naturali dell'individuo e, come afferma nelle primissime righe del Libro I, «ogni Stato è una comunità (koinonia) e ogni comunità si costituisce in vista di un bene». Il «bene» perseguito dallo Stato, in quanto comunità più importante che comprende tutte le altre, è da identificare con quello di cui parla l'Etica Nicomachea.È inoltre importante sottolineare che, a differenza di Platone, per Aristotele la politica ha una certa autonomia rispetto alla filosofia: il politico e il legislatore possono svolgere bene il proprio compito grazie alla loro saggezza pratica. La politica è però finalizzata alla filosofia in quanto deve creare le condizioni affinché si possano coltivare la scholè (tempo libero) e le attività teoretiche (tra cui rientrano, oltre alla filosofia, anche la matematica, la fisica, lo studio del cielo).
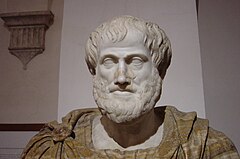
La Retorica (Τέχνη ῥητορική o anche Περὶ ῥητορικῆς) è una delle opere acroamatiche di Aristotele, quelle opere cioè composte dal filosofo per essere studiate dai suoi allievi nel Liceo. L'opera, composta durante l'ultima fase della vita dello Stagirita, e successiva alla Poetica (quindi al 330 a.C.), raccoglie le riflessioni relative alla retorica sviluppate da Aristotele nel corso della propria esistenza.Il testo è composto da tre libri, per ciascuno dei quali, seguendo Roland Barthes, è individuabile un argomento preciso: il Libro I è dedicato alla figura dell'oratore; il Libro II tratta del pubblico; il Libro III, più breve, affronta invece il tema del discorso vero e proprio. Inoltre, nel trattato sono distinguibili due fasi di stesura: ad una prima fase, caratterizzata dallo studio degli elementi entechnoi (propri della retorica in quanto techne), corrisponde a quanto scritto nel Libro I (eccetto il cap. 2 e parte del 15), mentre una seconda fase è riconoscibile nei due libri successivi.

Aristotele Socrate Omero Onassis (in greco: Αριστοτέλης Σωκράτης Όμηρος Ωνάσης Aristotèlis Sokràtis Òmiros Onàsis; Smirne, 15 gennaio 1906 – Neuilly-sur-Seine, 15 marzo 1975) è stato un armatore greco con cittadinanza argentina.
La metafisica è quella parte della filosofia che, andando oltre gli elementi contingenti dell'esperienza sensibile, si occupa degli aspetti più autentici e fondamentali della realtà, secondo la prospettiva più ampia e universale possibile. Essa mira allo studio degli enti «in quanto tali» nella loro interezza, a differenza delle scienze particolari che, generalmente, si occupano delle loro singole determinazioni empiriche, secondo punti di vista e metodologie specifiche. Nel tentativo di superare gli elementi instabili, mutevoli, e accidentali dei fenomeni, la metafisica concentra la propria attenzione su ciò che considera eterno, stabile, necessario, assoluto, per cercare di cogliere le strutture fondamentali dell'essere. In quest'ottica, i rapporti tra metafisica e ontologia sono molto stretti, tanto che sin dall'antichità si è soliti racchiudere il senso della metafisica nell'incessante ricerca di una risposta alla domanda metafisica fondamentale «perché l'essere piuttosto che il nulla?».All'ambito della ricerca metafisica tradizionale appartengono problemi quali la questione dell'esistenza di Dio, dell'immortalità dell'anima, dell'essere "in sé", dell'origine e il senso del cosmo, nonché la questione dell'eventuale relazione fra la trascendenza dell'Essere e l'immanenza degli enti materiali (differenza ontologica).
Per metafisica aristotelica (metafisica, dal greco: Μετά τα φυσικά - metà ta physikà, «dopo i libri di Fisica», ma anche «al di là delle cose fisiche») si intende una serie di trattati scritti da Aristotele (IV secolo a.C.) e raccolti successivamente sotto questo titolo.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (AFI: ˈɡeːɔɐ̯k ˈvɪlhɛlm ˈfʁiːdʁɪç ˈheːɡl̩) (Stoccarda, 27 agosto 1770 – Berlino, 14 novembre 1831) è stato un filosofo, accademico e poeta tedesco, considerato il rappresentante più significativo dell'idealismo tedesco. È ritenuto uno dei massimi filosofi di tutti i tempi. Hegel è autore di una delle linee di pensiero più profonde e complesse della tradizione occidentale: la sua riflessione filosofica, sistematica e onnicomprensiva, influenzerà molta parte del pensiero successivo, dall'ontologia all'estetica alla teoria politica, contribuendo alla nascita delle discipline sociali e storiche nella loro accezione moderna. La filosofia hegeliana è stata definita, tra l’altro, come idealismo assoluto. Oltre che dalla filosofia del suo tempo, la formazione intellettuale di Hegel è profondamente influenzata dallo studio della cultura e filosofia greca antica. Autori fondamentali per Hegel sono Eraclito (''Non c'è proposizione di Eraclito che io non abbia accolto nella mia Logica'') per l'opposizione dei contrari, Platone e Aristotele. Il Parmenide di Platone fornisce per Hegel l'esempio migliore di dialettica; ma è soprattutto Aristotele a fornire i nodi fondamentali dello sviluppo della filosofia hegeliana, con il concetto di energeia (actus, atto), che è il principale modello teorico per la nozione di soggetto, e con quello di νοήσεως νόησις (noéseos nόesis) per l'identità di soggetto e oggetto. Altro autore importante, seppur tipicamente in forma polemica, è Spinoza: per Hegel, infatti, uno dei compiti della filosofia è quello di superare la tesi spinoziana per cui "l'Assoluto è sostanza" (come avviene anche in Schelling) e svilupparla ulteriormente mostrando che "l'Assoluto è propriamente anche soggetto". Un altro autore che ha avuto notevole influenza su Hegel è Proclo da cui il grande filosofo tedesco ha ripreso il suo caratteristico modo di procedere logico triadico (anche la storia della filosofia passa per una serie di figure o forme dello Spirito che, dopo essere entrate in antitesi tra loro, si risolvono in un livello di sintesi superiore). Inoltre un grande debito Hegel lo ha anche nei riguardi di Fichte (da cui riprende appunto i tre momenti dialettici di tesi, antitesi e sintesi) e, in misura inferiore, verso Schelling (per quanto concerne la filosofia della natura). La filosofia di Hegel segna una svolta decisiva all'interno della storia della filosofia: da un lato, molti dei problemi classici della filosofia moderna verranno riformulati e problematizzati diversamente, come il rapporto mente-natura, soggetto-oggetto, epistemologia-ontologia (in ambito teoretico) o i temi relativi al diritto, alla moralità, allo Stato (in ambito pratico e morale); dall'altro, vengono ripensati la dialettica (col suo momento positivo, quello negativo e il momento di superamento/conservazione, Aufhebung in tedesco, della contraddizione), la distinzione fra eticità (a sua volta distinta in Stato, società civile e famiglia) e moralità, fra intelletto e ragione, ecc. Inoltre verrà data maggiore importanza a temi tradizionalmente non facenti parte della filosofia a pieno titolo (arte, religione, storia). Filosofia in primis e, in seconda battuta, religione e, infine l'arte, sono tre momenti dello Spirito assoluto dopo lo Spirito soggettivo e quello oggettivo (con l'eticità che costituisce la sintesi della moralità e del diritto; quest'ultimo è il più astratto). Con la filosofia l'Idea - unità autocosciente di forma e contenuto, il vero in sé e per sé, pensiero razionale assoluto e totalità infinita - si realizza pienamente: il vertice supremo della Logica riprende in ampia misura il “pensiero di pensiero” di Aristotele (il logos che pensa eternamente se stesso) dopo un percorso molto più complesso e articolato che ha nella libertà romantica il suo autentico compimento.

La gnoseologia (AFI: /ɲozeoloˈʤia/; dal greco gnòsis, «conoscenza», + lògos, «discorso»), chiamata anche teoria della conoscenza, è quella branca della filosofia che studia la natura della conoscenza. In particolare, così come si è consolidata nell'età moderna ad opera della speculazione filosofica di Kant, la gnoseologia si occupa dell'analisi dei fondamenti, dei limiti e della validità della conoscenza umana, intesa essenzialmente come relazione tra soggetto conoscente e oggetto conosciuto.Occorre precisare che nell'ambito della cultura anglosassone la teoria della conoscenza è chiamata anche e soprattutto epistemology, laddove in Italia con il termine epistemologia si designa essenzialmente quella branca della gnoseologia che si occupa della conoscenza scientifica o, in un senso ancora più specifico, la filosofia della scienza.

Atto e potenza sono una coppia di termini complementari utilizzati in filosofia da Aristotele per spiegare il perenne divenire dei fenomeni naturali, ed ai quali egli riconduce non solo le leggi dell'ontologia, ma anche dell'etica, della psicologia umana, e della conoscenza stessa.