- Libri preferiti
Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti
Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Colognole è una frazione del comune italiano di Collesalvetti, nella provincia di Livorno, in Toscana. La frazione è ubicata nei pressi del Monte Maggiore, seconda cima delle Colline Livornesi.

L'acquedotto di Colognole, detto anche Acquedotto Lorenese, è stato il principale rifornimento idrico della città di Livorno dal 1816 al 1912. Fu avviato durante il granducato di Ferdinando III di Lorena, e la sua costruzione proseguì sotto la direzione di vari architetti, tra problematiche e ripensamenti, fino all'unificazione d'Italia. Sebbene l'opera sia stata inaugurata sotto il medesimo Ferdinando, un contributo significativo si ebbe durante il successivo granducato di Leopoldo II, a cui l'opera viene talvolta impropriamente associata col nome di Acquedotto Leopoldino; risalgono infatti all'epoca di Leopoldo una serie di interventi per il potenziamento dell'infrastruttura, tra cui i grandi serbatoi per l'accumulo, la depurazione e la distribuzione delle acque ideati da Pasquale Poccianti, che rappresentano alcuni tra i più importanti episodi dell'architettura neoclassica in Toscana. Pur essendo ancora parzialmente in funzione, diverse tratte dell'acquedotto versano oggi in condizioni di grave degrado a causa della scarsa manutenzione dei manufatti.

Anche definito “morbo asiatico” a motivo della sua provenienza, il colera è causato da un bacillo (Vibrio cholerae), che si introduceva nell'organismo moltiplicandosi nell'apparato digerente. Nel corso dell'Ottocento, a causa di movimenti militari e commerciali dell'Inghilterra nel continente indiano, e delle macchine a vapore che resero sempre più numerosi i viaggi, il colera cominciò a diffondersi su quasi tutto il globo. L'Ottocento, infatti, rappresentò per l'Europa il secolo dello sviluppo industriale, che causò anche l'aumento demografico e l'accrescimento delle maggiori città che videro moltiplicare al loro interno rifiuti e germi, condizioni favorevoli per lo sviluppo di tale epidemia. Il colera dilagò in diverse città europee generando sette pandemie nel corso del XIX secolo. Sei di queste giunsero anche in Italia: 1835-1837, 1849, 1854-1855, 1865-1867, 1884-1886 e 1893.La rivoluzione batteriologica di fine Ottocento porterà alla scoperta degli agenti eziologici di quasi tutte le malattie epidemiche, ma alla prima comparsa del colera in Europa erano del tutto sconosciute le cause di questa malattia. Le manifestazioni coleriche iniziavano con forte diarrea accompagnata da dolori addominali, le scariche si presentavano poltacee e miste a bile, per poi diventare liquide e incolori. Contemporaneamente si presentava anche il vomito e cessava l'emissione d'urina. Il corpo si disidratava e per il malato cominciava il tormento della sete. Il volto si presentava pallido e molto sudato, gli occhi incavati nelle orbite. Quando il malato provava un'intensa sensazione di freddo, nota come fase algida, la morte sopraggiungeva nel giro di poche ore.
Salvatore De Renzi (Paternopoli, 19 gennaio 1800 – Napoli, 26 febbraio 1872) è stato un medico e scrittore italiano.
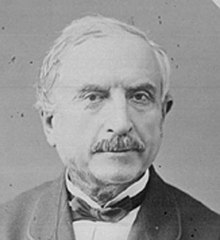
Pietro Cipriani (San Piero a Sieve, 10 dicembre 1810 – Firenze, 4 aprile 1887) è stato un politico e medico italiano.

La bile gialla è il liquido caldo e secco contenuto nella cistifellea che secondo l'antica dottrina umorale appartiene ad uno dei quattro umori fondamentali circolanti all'interno del corpo umano, contribuendo a definirne lo stato di salute. È denominata anche collera.

Arthur Schopenhauer (IPA: [ˈaɐ̯tʊɐ̯ ˈʃoːpm̩ˌhaʊ̯ɐ]) (Danzica, 22 febbraio 1788 – Francoforte sul Meno, 21 settembre 1860) è stato un filosofo tedesco, cittadino espatriato del regno di Prussia, e uno dei maggiori pensatori del XIX secolo e dell'epoca moderna. Il suo pensiero recupera alcuni elementi dell'illuminismo, della filosofia di Platone, del romanticismo e del kantismo, fondendoli con la suggestione esercitata dalle dottrine orientali, specialmente quella buddhista e induista. Schopenhauer crea una sua originale concezione filosofica caratterizzata da un forte pessimismo, la quale ebbe una straordinaria influenza, seppur a volte completamente rielaborata, sui filosofi successivi, come ad esempio Friedrich Nietzsche, e, in generale, sulla cultura europea coeva e successiva, inserendosi nella corrente delle filosofie della vita. Figlio di un ricco mercante e di una scrittrice, si stabilì a Weimar con la madre dopo il suicidio del padre. Qui conobbe Wieland e Goethe. Con buoni studi alle spalle, decise di dedicarsi alla filosofia e frequentò i corsi tenuti da Schulze a Gottinga e quelli di Fichte a Berlino. Nei confronti di questi, ma anche di Schelling ed Hegel, Schopenhauer nutrì sempre, concorde in questo con Kierkegaard, disprezzo e avversione, definendo Hegel il gran ciarlatano.Nel 1809 si iscrisse alla facoltà di medicina a Gottinga e, nel 1811, si trasferì a Berlino per frequentare i corsi di filosofia. Ingegno molteplice, sempre interessato ai più diversi aspetti del sapere umano (frequentò corsi di fisica, matematica, chimica, magnetismo, anatomia, fisiologia, e tanti altri ancora), si laureò nel 1813 a Jena con una tesi Sulla quadruplice radice del principio di ragion sufficiente e, nel 1818, pubblicò la sua opera più importante, Il mondo come volontà e rappresentazione, che ebbe tuttavia scarsissimo successo tra i suoi contemporanei e che cominciò a ricevere qualche attenzione solo vent'anni dopo, nonostante fossero giunti, da più parti, persino riconoscimenti ufficiali. Dal 1833 decise di fermarsi a Francoforte sul Meno, dove visse da solitario borghese, celibe per convinzione e misogino, nonostante le molte relazioni con donne che ebbe durante la sua esistenza. La vera affermazione del pensatore si ebbe solo a partire dal 1851, con la pubblicazione del volume Parerga e paralipomena, inizialmente pensato come un completamento della trattazione più complessa del Mondo, ma che venne accolto come un'opera a sé stante e fece conoscere al grande pubblico anche le opere precedenti del filosofo. Schopenhauer manifestò per gran parte della sua vita un acuto disagio nei confronti dei contatti umani - atteggiamento che gli procurò, in città, la fama di irriducibile misantropo - e uno scarso interesse, almeno in via ufficiale, per le vicende politiche dell'epoca, quali ad esempio i moti rivoluzionari del 1848 - sebbene si sia interessato, sul finire della sua vita, alla questione dell'Unità d'Italia, prendendo posizione favorevole. I tardi riconoscimenti di critica e pubblico attenuarono i tratti più intransigenti del suo carattere, tanto che negli ultimi anni della sua esistenza poté addirittura raccogliersi attorno a lui una ristretta cerchia di apostoli, come egli stesso amava definirli, tra i quali il compositore Richard Wagner, lo scrittore David Asher e la scultrice Elisabet Ney. Morì di pleurite acuta nel settembre del 1860, a settantadue anni.