- Libri preferiti
Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti
Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

La guerra del Peloponneso, o seconda guerra del Peloponneso per distinguerla da un conflitto antecedente, fu combattuta nell'antica Grecia tra il 431 e il 404 a.C., fra Sparta e Atene, ciascuna con la propria coalizione. Gli storici dividono la guerra in tre fasi: nella prima, la fase Archidamica, Sparta effettuò continue incursioni contro l'Attica, mentre Atene utilizzava la propria potente flotta per colpire le coste del Peloponneso. Questo periodo di scontri si concluse nel 421 a.C. con la firma della pace di Nicia. La pace durò poco: al 415 a.C. risale infatti la spedizione ateniese in Sicilia, evento disastroso per le forze della Lega delio-attica (costituita da Atene e da varie città-stato greche nel 478-477 a.C., durante la fase conclusiva delle guerre persiane), tanto da rinnovare il contrasto tra le due coalizioni greche che si contendevano l'egemonia. Nel 413 a.C. ebbe inizio la fase Deceleica, caratterizzata dall'intenzione spartana di fomentare moti di ribellione tra le forze sottoposte ad Atene; questa strategia, unita agli aiuti economici provenienti dalla Persia e a diversi errori strategici da parte di Atene, portò nel 404 a.C. alla vittoria della Lega peloponnesiaca, dopo la battaglia navale di Egospotami. La guerra del Peloponneso cambiò il volto della Grecia antica: Atene, che dalle guerre persiane aveva visto crescere enormemente il proprio potere, dovette sopportare alla fine dello scontro con Sparta un gravissimo crollo e riconoscere l'egemonia del Peloponneso. Tutta la Grecia interessata dalla guerra risentì fortemente del lungo periodo di devastazione, sia dal punto di vista della perdita di vite umane sia da quello economico e, proprio per questo motivo, il conflitto viene considerato come evento finale del secolo d'oro della civiltà ellenica; Atene, in particolare, non avrebbe mai più recuperato la sua antica prosperità. Fonte fondamentale per la ricostruzione storica rimane l'imponente opera di Tucidide, la Guerra del Peloponneso. Lo storico ateniese concluse però la trattazione della guerra con la battaglia di Cinossema (411 a. C.). Della fase finale dello scontro danno conto le Elleniche di Senofonte, il quale continuò l'esposizione del conflitto da dove Tucidide l'aveva interrotta.

L’Alcibiade primo (o Alcibiade I, in greco antico: Ἀλκιβιάδης A) è un dialogo di Platone, nel quale Alcibiade ha una conversazione con Socrate. La sua attribuzione a Platone è controversa tra gli studiosi. La datazione del testo è anch'essa variabile, ma viene collocato con buona probabilità nella prima metà del IV secolo a.C.

Alcibiade (AFI: [alʧiˈbiade]), figlio di Clinia del demo di Scambonide (in greco antico: Ἀλκιβιάδης Alkibiádēs, pronuncia: [alkibiádɛːs]; Atene, 450 a.C. – Frigia, 404 a.C.) è stato un militare e politico ateniese. Oratore e statista di altissimo livello, fu l'ultimo membro di spicco degli Alcmeonidi, il clan aristocratico a cui apparteneva la famiglia di sua madre, poi decaduto con la fine della guerra del Peloponneso. Svolse un ruolo importante nella seconda parte di questo conflitto, come consigliere strategico, comandante militare e politico. Durante la guerra del Peloponneso, Alcibiade cambiò più volte il proprio partito politico: nella natia Atene, dal 420 al 410 a.C. fu fautore di un'aggressiva politica estera impegnandosi nell'organizzazione della spedizione ateniese in Sicilia, ma passò dalla parte di Sparta quando i suoi oppositori politici lo accusarono del sacrilegio delle erme. A Sparta propose e supervisionò importanti campagne militari contro la sua città natale, ebbe un ruolo determinante nella caduta di Atene: l'occupazione permanente della città di Decelea e le rivolte di molti territori sotto il controllo di Atene furono da lui consigliate o supervisionate. Cacciato anche da Sparta, però, fu obbligato a rifugiarsi in Persia, dove divenne consigliere del satrapo Tissaferne finché i suoi sostenitori politici ateniesi non gli chiesero di tornare. Fu poi generale ad Atene per diversi anni, ma i suoi nemici riuscirono a farlo esiliare una seconda volta. A detta di molti storici, se avesse potuto comandare la spedizione in Sicilia da lui progettata (guidata invece da Nicia), l'operazione non sarebbe terminata con la disastrosa disfatta degli Ateniesi. Negli anni passati a Sparta, Alcibiade ebbe un ruolo determinante nella caduta di Atene: l'occupazione permanente della città di Decelea e le rivolte di molti territori sotto il controllo di Atene furono da lui consigliate o supervisionate. Una volta tornato alla sua città natale, comunque, ebbe un ruolo cruciale in una successione di vittorie ateniesi che forse avrebbero costretto Sparta alla pace. Alcibiade favorì tattiche anticonvenzionali, spesso assoggettando città con l'inganno, proponendo negoziati, utilizzando l'arte militare poliorcetica solo in casi estremi. Le qualità politiche e militari di Alcibiade furono spesso utili agli stati che beneficiarono dei suoi servigi, ma la sua propensione a inimicarsi i potenti gli impedì di rimanere a lungo in uno stesso luogo e, alla fine della guerra, i giorni in cui aveva avuto un ruolo politico importante divennero solo un lontano ricordo.
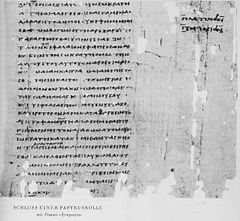
Il Simposio (in greco antico: , Symp sion, noto anche con il titolo di Convito, o a volte anche Convivio) forse il pi conosciuto dei dialoghi di Platone. In particolare, si differenzia dagli altri scritti del filosofo per la sua struttura, che si articola non tanto in un dialogo, quanto nelle varie parti di un agone oratorio, in cui ciascuno degli interlocutori, scelti tra il fiore degli intellettuali ateniesi, espone con un ampio discorso la propria teoria su Eros ("Amore").
Amore platonico è un modo usuale di definire una forma di amore priva della dimensione passionale (romantica). Infatti Platone considera l'attrazione fra i corpi il primo dei vari livelli di amore, benché egli aggiunga che questo livello vada abbandonato per giungere a quelli superiori (amore per l'anima, per le leggi e le istituzioni, per le scienze, assoluto). Questa formula in realtà scaturisce da un contesto filosofico in cui l'amore, inteso come moto dell'animo e non come forma di relazione, viene interpretato come impulso al trascendimento della realtà sensibile, del mondo delle apparenze, capace di muovere la conoscenza verso uno Spirito assoluto, attuando cioè un processo di indiamento (o nella mistica), come illustrato ad esempio nel pensiero di Giordano Bruno. Nel dialogo del Simposio, il brutto e sapiente Socrate rifiuta la proposta sessuale di Alcibiade, giovane bello e potente, e alla fine del dialogo, nella scena di amore (non consumato), spiega : «Caro Alcibiade, se credevi di scambiare la bellezza straordinaria che vedi in me con la tua avvenenza fisica, tu pensavi di trarre vantaggio ai miei danni. In cambio dell'apparenza del bello, tu cerchi di guadagnarti la verità del bello, e veramente pensi di scambiare armi d'oro con armi di bronzo». Le tesi di Pausania sono ben presentate, ma non accolte da Platone. Il filosofo, noto nell'ambiente dell'"Atene-bene" dell'epoca, teorizza la distinzione fra Afrodite terrestre e Afrodite celeste, amore nobile e volgare, amore per gli uomini e per le donne. Formula per esteso il bon ton del corteggiamento (con regole comuni per relazioni omo e eterosessuali), e teorizza l'amore pederastico come un'amicizia, uno scambio fra i favori della bellezza con la sapienza e virtù. L'Eros sessuale è solo il primo gradino della scala d'amore; l'Eros filosofico va molto più in alto fino a congiungersi con il Bello e col Bene (sempre uniti e veri in kalokagathia).

L'Alcibiade secondo o minore (in greco Ἀλκιβιάδης δεύτερος) è un dialogo platonico la cui autenticità viene generalmente negata dagli studiosi moderni e da parte dei grammatici antichi (alcuni dei quali lo attribuivano a Senofonte). In esso vi è una lunga discussione tra Socrate e Alcibiade sul tema della preghiera, e su quali cose è lecito chiedere agli dèi - tema che peraltro è già affrontato nell’Alcibiade primo.