- Libri preferiti
Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti
Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Il programma Apollo fu un programma spaziale statunitense che portò allo sbarco dei primi uomini sulla Luna. Concepito durante la presidenza di Dwight Eisenhower e condotto dalla NASA, Apollo iniziò veramente dopo che il presidente John Kennedy dichiarò, durante una sessione congiunta al Congresso avvenuta il 25 maggio 1961, obiettivo nazionale il far "atterrare un uomo sulla Luna" entro la fine del decennio. Questo obiettivo fu raggiunto durante la missione Apollo 11 quando, il 20 luglio 1969, gli astronauti Neil Armstrong e Buzz Aldrin sbarcarono sulla Luna, mentre Michael Collins rimase in orbita lunare. Apollo 11 fu seguita da ulteriori sei missioni, l'ultima nel dicembre 1972, che portarono un totale di dodici uomini a camminare sul nostro satellite naturale. Questi sono stati gli unici uomini a mettere piede su un altro corpo celeste. Il programma Apollo si svolse tra il 1961 e il 1975 e fu il terzo programma spaziale di voli umani (dopo Mercury e Gemini) sviluppato dall'agenzia spaziale civile degli Stati Uniti. Il programma utilizzò la navicella spaziale Apollo e il razzo vettore Saturn, successivamente utilizzati anche per il programma Skylab e per la missione congiunta americana-sovietica Apollo-Soyuz Test Project. Questi programmi successivi sono spesso considerati facenti parte delle missioni Apollo. Il corso del programma subì due lunghe sospensioni: la prima dopo che nel 1967 un incendio sulla rampa di lancio di Apollo 1, durante una simulazione, causò la morte degli astronauti Gus Grissom, Edward White e Roger Chaffee; la seconda dopo il viaggio verso la Luna di Apollo 13 nel 1970 durante il quale si verificò un'esplosione sul modulo di servizio che impedì agli astronauti la discesa sul nostro satellite e li costrinse ad un rischioso rientro sulla Terra. L'Apollo segnò alcune pietre miliari nella storia del volo spaziale umano che fino ad allora si era limitato a missioni in orbita terrestre bassa. Il programma stimolò progressi in molti settori delle scienze e delle tecnologie, tra cui avionica, informatica e telecomunicazioni. Molti oggetti e manufatti del programma sono esposti in luoghi e musei di tutto il mondo ed in particolare presso il National Air and Space Museum di Washington.

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, in sigla FAO, è un istituto specializzato delle Nazioni Unite con lo scopo di contribuire ad accrescere i livelli di nutrizione, aumentare la produttività agricola, migliorare la vita delle popolazioni rurali e contribuire alla crescita economica mondiale nel territorio. Fondata il 16 ottobre 1945 a Québec, nel Canada, dal 1951 la sua sede è stata trasferita da Washington a Roma presso il Palazzo FAO. Da novembre 2007 ne sono membri 194 Paesi più l'Unione europea.

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile, OSS (in inglese: Sustainable Development Goals, SDG) sono una serie di 17 obiettivi interconnessi, definiti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite come strategia "per ottenere un futuro migliore e più sostenibile per tutti". Sono conosciuti anche come Agenda 2030, dal nome del documento che porta per titolo "Trasformare il nostro mondo. L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", che riconosce lo stretto legame tra il benessere umano, la salute dei sistemi naturali e la presenza di sfide comuni per tutti i paesi. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile mirano ad affrontare un'ampia gamma di questioni relative allo sviluppo economico e sociale, che includono la povertà, la fame, il diritto alla salute e all'istruzione, l'accesso all'acqua e all'energia, il lavoro, la crescita economica inclusiva e sostenibile, il cambiamento climatico e la tutela dell'ambiente, l'urbanizzazione, i modelli di produzione e consumo, l'uguaglianza sociale e di genere, la giustizia e la pace.Gli obiettivi, enumerati nella Risoluzione delle Nazioni Unite A/RES/70/1 approvata dall'Assemblea generale dell'ONU il 25 settembre 2015, sono complessivamente 169, da raggiungere entro il 2030. Sono stati concordati, a partire dai principi inclusi nella Risoluzione A/RES/66/288, intitolata "Il futuro che vogliamo", un documento non vincolante elaborato dopo la Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 2012, per sostituire gli Obiettivi di sviluppo del Millennio, che avevano come orizzonte temporale il 2015. Mentre questi ultimi si rivolgevano in modo diversificato ai paesi sviluppati e in via di sviluppo, gli obiettivi di sviluppo sostenibile hanno carattere universale e sono fondati sull'integrazione tra le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile (ambientale, sociale ed economica), quale presupposto per eradicare la povertà in tutte le sue forme. Tutti i 193 Stati membri delle Nazioni Unite hanno ratificato l'agenda 2030 e si sono così impegnati a declinare nella loro politica gli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti. Ogni anno gli Stati possono presentare lo stato di attuazione dei diciassette OSS nel proprio paese, attraverso l'elaborazione di Rapporti Nazionali Volontari (Voluntary National Reviews). L'Agenda 2030 individua nel Foro politico di Alto Livello (High Level Political Forum) il consesso globale per monitorare, valutare e orientare l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Per supportare tale attività e garantire la comparabilità delle valutazioni, la Commissione Statistica delle Nazioni Unite ha costituito l’Inter Agency Expert Group on SDGs (IAEG-SDGs), con il compito di definire un insieme di indicatori per il monitoraggio dell’attuazione dell’Agenda 2030 a livello globale.

Gli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM) (Millennium Development Goals o MDG, o più semplicemente "Obiettivi del Millennio") delle Nazioni Unite sono otto obiettivi che tutti i 193 stati membri dell'ONU si sono impegnati a raggiungere per l'anno 2015. La Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite, firmata nel settembre del 2000, impegna gli stati a: sradicare la povertà estrema e la fame nel mondo rendere universale l'istruzione primaria promuovere la parità dei sessi e l'autonomia delle donne ridurre la mortalità infantile ridurre la mortalità materna combattere l'HIV/AIDS, la malaria e altre malattie garantire la sostenibilità ambientale sviluppare un partenariato mondiale per lo sviluppoCiascuno degli obiettivi ha specifici target dichiarati e date precise per il raggiungimento degli stessi. Per accelerare i progressi, i ministri delle Finanze dei paesi del G8 hanno deciso nel giugno 2005 di fornire fondi sufficienti alla Banca Mondiale, al Fondo monetario internazionale (FMI) e alla Banca africana di sviluppo (ADB) per annullare di un ulteriore 40-55.000.000.000 $ il debito da parte dei Paesi poveri fortemente indebitati (HIPC) per consentir loro di destinare nuove risorse ai programmi sociali per migliorare la salute e l'istruzione e per alleviare la povertà. Il dibattito riguardo l'adozione degli MDG, è stato incentrato sulla mancanza di analisi e giustificazione dietro gli obiettivi scelti, la difficoltà o la mancanza di misure per alcuni degli obiettivi e l'avanzamento irregolare verso il raggiungimento degli stessi. Sebbene gli aiuti dei paesi sviluppati per raggiungere gli OSM sono in crescita negli ultimi anni, più della metà degli aiuti è rivolta verso la cancellazione del debito dovuto da parte dei paesi poveri, il denaro rimanente viene versato in caso di catastrofi naturali e aiuti militari, che non creano ulteriore sviluppo. I progressi verso il raggiungimento degli obiettivi non sono stati uniformi. Alcuni paesi hanno raggiunto molti degli obiettivi, mentre altri non sono sulla buona strada per realizzare neanche uno qualsiasi. La conferenza delle Nazioni Unite del settembre 2010 ha esaminato i progressi compiuti fino ad oggi e ha terminato i lavori con l'adozione di un piano d'azione globale per raggiungere gli otto obiettivi di lotta alla povertà fissando il 2015 come data ultima stabilita. Ci sono stati anche nuovi impegni che prefiggono il miglioramento della salute di donne e bambini, e nuove iniziative nella lotta mondiale contro la povertà, la fame e le malattie. Tra le Organizzazioni volte a conseguimento di tali obiettivi, vi sono la Campagna del Millennio delle Nazioni Unite, Millennium Promise Alliance, il Progetto Povertà Globale, The Micah Challenge, 8 Visions of Hope, il video channel "8 gol x 8 Millennium Development Goals" poi 21 Videos about 21 MDGs Targets using Arcade C64 videogames e il progetto Gioventù in Azione "Cartoons in Action".
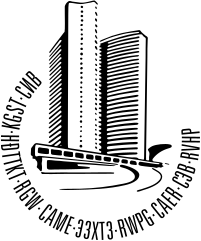
Il Consiglio di mutua assistenza economica (abbreviato Comecon) è stata un'organizzazione economica e, soprattutto, commerciale degli Stati socialisti istituita nel 1949 e sciolta nel 1991 a seguito della caduta del Blocco orientale. Rappresentò uno dei blocchi commerciali nati nella seconda metà del XX secolo insieme alla Comunità economica europea, al Movimento dei paesi non allineati e all'Associazione europea di libero scambio, e comprendeva una popolazione molto maggiore degli altri gruppi sopracitati. Il termine descrittivo Comecon si applicava a tutte le attività multilaterali che coinvolgevano i membri dell'organizzazione e non era ristretto alle dirette funzioni del Comecon ed ai suoi organi. Questo uso poteva essere esteso a tutte le relazioni bilaterali tra i membri, poiché nel sistema delle relazioni internazionali socialiste, gli accordi multilaterali - tipicamente di natura generale - tendevano ad essere implementati attraverso una serie di accordi dettagliati bilaterali.

Magdeburgo (in tedesco Magdeburg; in basso tedesco Meideborg; nota in italiano storico come Madeburgo), è una città extracircondariale (targa MD), capitale del Land Sassonia-Anhalt. Con i suoi 236.235 abitanti, è la seconda città del proprio stato federato per popolazione - dopo Halle - e uno dei tre Oberzentren del Land designati dal piano nazionale di sviluppo 2002. La città è famosa per il proprio consistente patrimonio storico-artistico, tra cui spicca il Palazzo Imperiale di Ottone I, imperatore del Sacro Romano Impero. Ospita sia la sede vescovile evangelica, sia quella cattolica. Sul territorio sono presenti due università: la Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg e la Hochschule Magdeburg-Stendal. La città ha festeggiato, nel 2005, i suoi primi 1.200 anni dalla fondazione, e dal 2010 ha adottato il soprannome di Ottostadt, la città di Ottone.

Le Iene (chiamato anche Le Iene Show) è un programma televisivo italiano di intrattenimento che va in onda su Italia 1 dal 22 settembre 1997. Versione italiana del programma televisivo argentino Caiga quien caiga.

Herbert Lange (Menzlin, 29 settembre 1909 – Bernau bei Berlin, 20 aprile 1945) è stato un militare tedesco, ufficiale delle SS e primo comandante del campo di sterminio di Chełmno. Lange, come Christian Wirth, fu coinvolto nei programmi di eutanasia introdotti dai nazisti, Al pari di Christian Wirth, sfuggì al processo del dopoguerra per i suoi crimini.
Adolf Hitler (pronuncia tedesca [ˈadɔlf ˈhɪtlɐ] ; Braunau am Inn, 20 aprile 1889 – Berlino, 30 aprile 1945) è stato un politico tedesco di origine austriaca, cancelliere del Reich dal 1933 e dittatore, col titolo di Führer, della Germania dal 1934 al 1945. Capo del Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori, nonché principale ideatore del nazionalsocialismo, Hitler conquistò il potere cavalcando l'orgoglio ferito del popolo tedesco, dopo la sconfitta nella prima guerra mondiale e la grave crisi economica che affliggeva la Repubblica di Weimar. Sfruttando la sua abilità oratoria e l'insoddisfazione delle classi medie, presentò un manifesto politico intriso di nazionalismo, anticomunismo e antisemitismo e dopo alterne vicende (fallito Putsch nel 1923 e conseguenti otto mesi di carcerazione, durante i quali iniziò la stesura del Mein Kampf), arrivò alla Cancelleria nel gennaio del 1933. Nel 1934, dopo la morte del presidente Paul von Hindenburg, si attribuì per legge il titolo di Führer e Cancelliere del Reich, accentrando nelle sue mani i poteri dello Stato e instaurando un regime dittatoriale. Grazie a un possente ed efficace programma di ristrutturazione economica e riarmo militare, Hitler perseguì una politica estera estremamente aggressiva, volta principalmente a espandere il Lebensraum (spazio vitale) tedesco a spese delle popolazioni dell'Europa orientale. In un susseguirsi di atti di sfida alla comunità internazionale, giunse a invadere la Polonia il 1º settembre del 1939, provocando lo scoppio della seconda guerra mondiale. Da quel momento Hitler diresse personalmente le operazioni di guerra, esercitando un'influenza determinante nelle scelte strategiche e nella conduzione operativa. Grazie anche alle sue decisioni e alla sua determinazione i primi anni del conflitto furono caratterizzati da impressionanti vittorie, che permisero al Terzo Reich di dominare gran parte dell'Europa e sembrarono dimostrare l'invincibilità della Wehrmacht. Tuttavia a partire dal 1942, col formarsi della potente coalizione degli Alleati anglo-americano-sovietici, la Germania dovette passare sulla difensiva e subire gli attacchi sempre più efficaci dei suoi nemici. Abbandonato dagli alleati, logorato dalle continue sconfitte e in condizioni fisiche e psichiche sempre più precarie, Hitler rifiutò di cedere le armi e continuò a resistere ostinatamente. Rimasto bloccato con le truppe a lui fedeli in una Berlino ormai accerchiata dall'Armata Rossa, si suicidò nel suo bunker il 30 aprile 1945 insieme alla compagna Eva Braun, che aveva sposato il giorno prima. Responsabile della morte di milioni di persone, Hitler fu propugnatore di un'ideologia nazionalista e razzista, e di una politica di discriminazione e sterminio che colpì vari gruppi etnici, politici e socialiː popolazioni slave, etnie romanì, testimoni di Geova, omosessuali, oppositori politici, membri della Massoneria, prigionieri di guerra, disabili fisici e mentali, e in particolar modo gli ebrei. Segregati sin dal 1933 dalla vita sociale ed economica del Paese, gli ebrei e le altre minoranze furono oggetto dal 1941 di un piano d'internamento e sterminio noto con il nome di soluzione finale, al quale ci si è riferiti sin dall'immediato dopoguerra con il termine di Shoah od Olocausto. La parola genocidio fu coniata dall'ebreo polacco Raphael Lemkin in un'opera del 1944 sulle politiche di sterminio naziste.