- Libri preferiti
Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti
Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Come le foglie è una poesia del poeta greco Mimnermo, in distici elegiaci, giuntaci, probabilmente integra, tramite l'Antologia di Stobeo. In questo testo il poeta si sofferma nuovamente sul discorso di antitesi tra i divertimenti della giovinezza e l'incombenza triste della vecchiaia. La poesia è scritta in distici elegiaci. Il testo inizia con il paragone senza tempo tra uomini e foglie, ricorrente nella letteratura ed è di stampo omerico. Omero, infatti, nel VI libro dell'Iliade, durante l'incontro tra Diomede e Glauco, paragona le generazioni degli uomini alle foglie: Tuttavia sono evidenti anche le differenze: nel discorso di Glauco la precarietà dell'uomo si applicava alle stirpi e al significato della loro presenza sulla terra, in Mimnermo, invece, al ciclo breve della vita individuale. Inoltre, se nell'Iliade le generazioni sono paragonate al cadere delle foglie con una immagine dinamica in cui nuove foglie nascono e che si conclude con la visione della primavera, nel frammento 2 West il dato pittoresco viene appena ricordato, dopo il poeta si abbandona in una triste riflessione che termina con le figure delle nere Parche, quindi un'immagine di morte. A partire da reminiscenze omeriche il poeta affronta le tematiche che più gli stanno a cuore: la fugacità della giovinezza e l'incombere della vecchiaia. Dal punto di vista formale si nota che le parole-chiave sono poste in rilievo grazie alla loro collocazione nel testo, alla fine (come ὢρη, ἠελίου, ἣβης, rispettivamente alla fine dei vv. 1-3) o all'inizio, come il pronome ἡμείς al v. 1, che afferma l'universalità delle tematiche trattate, da cui nessun uomo può sentirsi escluso: noi tutti siamo come foglie, e tanto caduca è la nostra esistenza. I termini scelti, attinti dal mondo naturale, suggeriscono un'identificazione tra la vita umana e il ciclo della natura. Nel componimento è evidente l'angoscia del poeta: a differenza di Pohlez altri studiosi, quali Jaeger, sostengono che non possa intendersi come l'analogo invito oraziano al carpe diem: per l'uomo "morte, vecchiaia, malattia, sfortuna, e quant'altro lo insidia, si fanno minacce gigantesche, e chi cerca di sottrarsi loro col godimento momentaneo, ne porta tuttavia la spina sempre confitta nel cuore". Nel v. 10 ricorre un tema molto diffuso nel pessimismo greco, che si ritrova in Bacchilide:"per l'uomo/ molto meglio non esser nato,/ non avere mai visto la luce/ del sole; in Erodoto:" meglio è per l'uomo morire piuttosto che vivere; in Sofocle:"Non essere nati è condizione/ che tutto supera; ma poi, una volta apparsi,/ tornare al più presto colà donde si venne,/ è certo il secondo bene". Tuttavia in Mimnermo esso assume una connotazione differente: egli ritiene preferibile la morte, ma solo quando la giovinezza è ormai trascorsa.
Mario Traina (17 aprile 1930 – 9 ottobre 2010) è stato un numismatico italiano. È stato uno dei maggiori studiosi e divulgatori di numismatica della seconda metà del XX secolo. Divenuto giornalista di professione dopo aver conseguito una laurea in giurisprudenza, già nel 1967 riuscì a pubblicare la sua prima importante opera, Le monete italiane del XVIII secolo: I Savoia, da lì prese il sopravvento il grande amore che lo legherà allo studio e alla ricerca numismatica sino alla sua morte avvenuta nel 2010 all'età di 80 anni. Altre sue opere importanti sono le monete ossidionali Italiane, Investire in monete, la storia della lira nella repubblica Italiana, e la più recente Il linguaggio delle monete, che andò a sostituire l'ormai affatto aggiornato Vocabolario di Donati; oltre a queste opere, Traina si impiegò più che altro nell'ambito delle varie riviste, scrisse su Soldi Numismatica, Italia Numismatica, La Numismatica, Numismatica ed antichità Classiche, nella RIN e infine per Cronaca numismatica, cui dette genesi e che diresse anche per diversi anni. Oltre ad aver fatto parte di varie giurie e commissioni, Mario Traina ha fatto parte del Consiglio all'Accademia di studi Filatelici e Numismatici di Reggio Emilia, si è fatto promotore dell'allora nascente Accademia Italiana di Studi Numismatici, di cui è stato eletto Presidente, ed in seguito presidente onorario; è stato socio della Società Numismatica Italiana. Nel 2008 ha ricevuto un prestigioso riconoscimento alla carriera, il premio "Maestri di Numismatica".

Giusto Traina (Palermo, 19 settembre 1959) è uno storico italiano. Temi della sua ricerca storica sono stati i paesaggi e le tecniche nell'antichità e il Regno d'Armenia (188 a.C.-428).

Giuseppe Traina (Santa Margherita di Belice, 11 dicembre 1889 – 9 febbraio 1958) è stato un politico italiano.

Giovanni Pascoli (San Mauro di Romagna, 31 dicembre 1855 – Bologna, 6 aprile 1912) è stato un poeta, accademico e critico letterario italiano, figura emblematica della letteratura italiana di fine Ottocento, considerato insieme a Gabriele D'Annunzio, il maggior poeta decadente italiano, nonostante la sua formazione principalmente positivistica. Dal Fanciullino, articolo programmatico pubblicato per la prima volta nel 1897, emerge una concezione intima e interiore del sentimento poetico, orientato alla valorizzazione del particolare e del quotidiano, e al recupero di una dimensione infantile e quasi primitiva. D'altra parte, solo il poeta può esprimere la voce del "fanciullino" presente in ognuno: quest'idea consente a Pascoli di rivendicare per sé il ruolo, per certi versi ormai anacronistico, di "poeta vate", e di ribadire allo stesso tempo l'utilità morale (specialmente consolatoria) e civile della poesia. Egli, pur non partecipando attivamente ad alcun movimento letterario dell'epoca, né mostrando particolare propensione verso la poesia europea contemporanea (al contrario di D'Annunzio), manifesta nella propria produzione tendenze prevalentemente spiritualistiche e idealistiche, tipiche della cultura di fine secolo segnata dal progressivo esaurirsi del positivismo. Complessivamente la sua opera appare percorsa da una tensione costante tra la vecchia tradizione classicista ereditata dal maestro Giosuè Carducci, e le nuove tematiche decadenti. Risulta infatti difficile comprendere il vero significato delle sue opere più importanti, se si ignorano i dolorosi e tormentosi presupposti biografici e psicologici che egli stesso riorganizzò per tutta la vita, in modo ossessivo, come sistema semantico di base del proprio mondo poetico e artistico.
Giovanni Battista Pighi, latinizzato: Ioannes Baptista Pighius (Verona, 1º maggio 1898 – Verona, 7 maggio 1978), è stato un latinista, accademico e poeta italiano, autore di componimenti poetici in lingua latina.
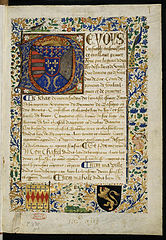
La filologia (in greco antico: φιλoλογία, philologhía («interesse per la parola»), composto da φίλος, phìlos, "amante, amico" e λόγος, lògos, "parola, discorso"), secondo l’accezione comune attuale, è un insieme di discipline che studia i testi di varia natura (letterari, storici, politologici, economici, giuridici, ecc.), da quelli antichi a quelli contemporanei, al fine di ricostruire la loro forma originaria attraverso l’analisi critica e comparativa delle fonti che li testimoniano e pervenire, mediante varie metodologie di indagine, ad un’interpretazione che sia la più corretta possibile. Il filologo italiano Alberto Varvaro evidenzia come qualsiasi testo, sia scritto sia orale, inerente a qualsiasi sapere, può e deve essere trattato con i metodi e gli strumenti della filologia. Dunque, la filologia non identifica un ambito d'indagine, ma un metodo.