- Libri preferiti
Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti
Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

La Rivoluzione culturale (文革S) detta anche Grande rivoluzione culturale (文化大革命S, wénhuà dà gémìngP), aveva il nome ufficiale di Grande rivoluzione culturale proletaria (无产阶级文化大革命S, wúchǎn jiējí wénhuà dà gémìngP). Fu lanciata nella Repubblica Popolare Cinese nel 1966 da Mao Zedong, la cui direzione era posta in discussione a causa del fallimento della politica economica da lui ideata e pianificata nel cosiddetto grande balzo in avanti.
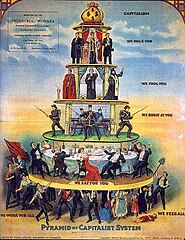
Il proletariato e i proletari (dal latino proletarii, capite censi o adcensi) sono termini variamente definiti a seconda degli approcci socio-economici e a seconda delle epoche storiche di riferimento: in senso lato designano il gruppo o la classe di reddito che si colloca in basso nella scala sociale.
Mobbing o mobbismo (dall'inglese [to] mob «assalire, molestare»; quindi «molestia, angheria») è un termine che in psicologia e nell'accezione comune indica una forma di abuso ovvero un insieme di comportamenti aggressivi di natura fisica e/o verbale, esercitati da una persona o da un gruppo di persone nei confronti di uno o più soggetti. Sebbene il termine venga utilizzato soprattutto per riferirsi a situazioni nel mondo del lavoro, più in generale, il termine indica i comportamenti violenti che un gruppo (sociale, familiare, animale) rivolge a un suo membro; in riferimento al mondo del lavoro simili attività possono anche essere messe in atto da persone che abbiano una certa autorità sulle altre, in tal caso si parla di bossing; in etologia, il termine identifica i comportamenti aggressivi assunti da talune prede nei confronti di un predatore per intimorirlo e dissuaderlo dall'attacco.

Giulio Einaudi editore, nota anche pi semplicemente come Einaudi, una casa editrice italiana.
L'esperimento della prigione di Stanford fu un esperimento psicologico volto a indagare il comportamento umano in una società in cui gli individui sono definiti soltanto dal gruppo di appartenenza. L'esperimento prevedeva l'assegnazione, ai volontari che accettarono di parteciparvi, dei ruoli di guardie e prigionieri all'interno di un carcere simulato. Fu condotto nel 1971 da un team di ricercatori diretto dal professor Philip Zimbardo della Università di Stanford. I risultati ebbero dei risvolti così drammatici da indurre gli autori dello studio a sospendere la sperimentazione. In tempi più recenti i risultati sono stati messi in dubbio e l'esperimento è stato criticato per aver utilizzato una metodologia non scientifica. I critici fanno notare che Zimbardo ha istruito le guardie ad esercitare un controllo psicologico sui prigionieri e che i partecipanti si son comportati in modo tale da aiutare lo studio cosicché, come affermò una "guardia" nel 2011, i ricercatori avessero qualcosa su cui lavorare. Un'altra critica mossa all'esperimento concerne il campione usato, fortemente suscettibile ad un effetto di selezione e troppo piccolo e omogeneo: i 24 partecipanti erano studenti maschi statunitensi, principalmente bianchi e appartenenti al ceto medio, selezionati dai ricercatori in base alle risposte ad un questionario.

La violenza scolastica (conosciuta anche come bullismo scolastico, o in inglese bullying) è qualsiasi forma di abuso psicologico, verbale o fisico che si verifica ripetutamente tra gli studenti per un certo periodo di tempo, in classe e attraverso i social network; quest'ultimo prende il nome di cyberbullismo. Statisticamente, il tipo di violenza dominante è di tipo emotivo e si verifica per lo più in classe e nei cortili delle scuole. I protagonisti dei casi di bullismo scolastico sono di solito bambini in età adolescenziale, con una percentuale leggermente più alta di ragazze nel profilo delle vittime.Il bullismo scolastico è una forma caratteristica ed estrema di violenza scolastica. Questo tipo di violenza scolastica è quindi caratterizzato da una ripetizione della stessa, volta a intimidire la vittima, che implica un abuso di potere, esercitato da un aggressore più forte (sia che questa forza sia reale o percepita soggettivamente) del primo. Il soggetto maltrattato viene così esposto fisicamente ed emotivamente al maltrattatore, generando di conseguenza una serie di effetti psicologici (anche se questi non fanno parte della diagnosi); è comune che il maltrattato viva nel terrore all'idea di frequentare la scuola e si mostri molto nervoso, triste e solitario nella sua vita quotidiana. In alcuni casi, la durezza della situazione può portare a pensieri di suicidio e persino alla sua materializzazione, queste sono conseguenze delle molestie subite da persone di tutte le età. Possono essere più inclini a essere vittime del bullismo i bambini affetti da sindrome di Down, autismo, sindrome di Asperger, sindrome di Tourette, ecc.

Con il termine bullismo si indica una forma di comportamento sociale di tipo violento e intenzionale, tanto di natura fisica che psicologica, ripetuto nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone percepite come più deboli dal soggetto che perpetra l’atto in questione. In breve, perché possa correttamente parlarsi di bullismo, devono sussistere tre precisi requisiti: – il comportamento deve essere intenzionale; – il comportamento deve persistere nel tempo; – deve esserci un’asimmetria nella relazione. Nel fenomeno del bullismo, particolarmente rilevante è il ruolo degli spettatori (indicati nella letteratura anglofona con il termine di bystanders) che, idealmente, possiamo immaginare composto da: – gregari, che appoggiano il bullo o pongono in essere, su suo mandato, gli atti di bullismo; – spettatori, che, a seconda dei casi, possono assistere in silenzio oppure ridere e incitare i bulli. Il bullismo, dunque, non riguarda soltanto l’interazione tra due soggetti, ma deve essere piuttosto considerato come un fenomeno di gruppo, e potrà essere contrastato soltanto dopo aver compreso, e soprattutto accettato, che si tratta di una manifestazione culturale, espressione di una società in cui, di fatto, sono dominanti i valori della sopraffazione e dell’arbitrio del più forte sul più debole, in cui i modelli vincenti, spesso veicolati anche attraverso i mass media, sono quelli dell’arroganza e del non rispetto per l’altro. Il termine bullismo viene spesso utilizzato per riferirsi a fenomeni di violenza tipici degli ambienti scolastici, ma può verificarsi anche in altri contesti sociali riservati ai più giovani. Lo stesso comportamento, o comportamenti simili, in altri contesti, sono identificati con altri termini, come mobbing in ambito lavorativo o nonnismo nell'ambito delle forze armate. A partire dagli anni 2000, con l'avvento di Internet, si è andato delineando un altro fenomeno legato al bullismo, anche in questo caso diffuso soprattutto fra i giovani, il cyberbullismo. Il bullismo come fenomeno sociale e deviante è oggetto di studio tra gli esperti delle scienze sociali, della psicologia giuridica, clinica, dell'età evolutiva e di altre discipline affini. Non esiste una definizione univoca del bullismo per gli studiosi, sebbene ne siano state proposte diverse. È possibile tuttavia individuare le caratteristiche generali del fenomeno in questione:
Andrea Devoto (Firenze, 1927 – Firenze, 1994) è stato uno psichiatra italiano.