- Libri preferiti
Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti
Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti
Il concetto di capitale sociale può essere definito in generale come un corpus di regole che facilitano la collaborazione all'interno dei gruppi o tra essi.
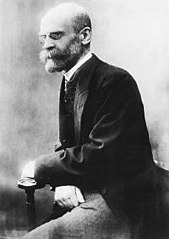
La sociologia è la scienza sociale che studia i fenomeni della società umana, indagando i loro effetti e le loro cause, in rapporto con l'individuo e il gruppo sociale; un'altra definizione, più restrittiva, definisce la sociologia come lo studio scientifico della società. Altre definizioni storiche includono quella di Auguste Comte che la definisce uno strumento di azione sociale, quella di Émile Durkheim, cioè la scienza dei fatti e dei rapporti sociali, infine quella di Max Weber, scienza che punta alla comprensione interpretativa dell'azione sociale (interpretativismo).
Le scienze della comunicazione sono le scienze sociali che studiano la comunicazione umana. Le scienze coinvolte in questi studi sono numerose e si differenziano non solo per gli approcci, ma anche per le tipologie di fenomeni comunicativi che osservano. In ambito accademico quando si parla di comunicazione si allude quasi sempre alle comunicazioni di massa (giornalismo, radio, televisione, cinema, nuovi media) e ai processi comunicativi di tipo istituzionale o professionale, cioè la comunicazione pubblica (intesa come comunicazione della pubblica amministrazione), la comunicazione sociale e la comunicazione d'impresa, comprendente la pubblicità, le pubbliche relazioni e alcuni segmenti del marketing. Di solito, invece, per riferirsi ai processi di comunicazione interpersonale si parla di "scienze del linguaggio".

Georg Simmel (Berlino, 1º marzo 1858 – Strasburgo, 26 settembre 1918) è stato un sociologo e filosofo tedesco. Oggi è considerato uno dei "fondatori" della sociologia con Émile Durkheim e Max Weber nonostante non abbia fondato una "scuola", né molti si siano dichiarati simmeliani. Il suo pensiero è stato utilizzato da molti e in modi diversi anche per la vastità della sua opera. Attraverso la mediazione di Robert Park divenne un autore di riferimento per la Scuola di Chicago; la sua sociologia venne accostata alla psicologia sociale di George Herbert Mead.

La sociologia della religione è un ramo specializzato della sociologia. È essenzialmente lo studio della pratica, delle strutture sociali, del contesto storico, dello sviluppo, dei temi di fondo comuni a tutte le religioni. Si sottolinea in modo particolare il ruolo che la religione ha in quasi tutte le società del mondo, nel corso della storia. I sociologi della religione cercano di spiegare gli effetti della società sulla religione e gli effetti della religione sulla società, vale a dire il loro rapporto dialettico.
La sociologia della conoscenza studia le modalità di accesso alla conoscenza degli oggetti o del sapere cosiddetto scolastico, ovvero le modalità di produzione di tale sapere. Essa assume dunque posizione biunivoca, concentrandosi sia sugli aspetti di possibilità del conoscere (la cui riflessione metodologica non si distanzia molto dalla riflessione gnoseologica della filosofia della conoscenza), sia su quelli legati all'introduzione di un particolare sapere nella realtà sociale. Propriamente l'origine non è "gnoseologica" ma si rifà al concetto di Wissen: è la "sociologia del sapere" fondata e sviluppata da Max Scheler, poi ripresa nel senso di "sociologia della conoscenza" da Karl Mannheim. La sociologia del sapere in Scheler fa riferimento alle forme della Bildung, cioè alla sedimentazione delle tecniche con cui l'uomo dà forma alla propria esistenza. Karl Mannheim propone di considerare i rapporti tra l'essere situato nel mondo e il pensiero, che sarebbe relato appunto alla struttura sociale nella quale l'essere è gettato. Egli propone per la sociologia della conoscenza una "sfera libera" e indipendente dalla quale poter analizzare e ricostruire le diverse contingenze storiche delle produzioni del sapere e per favorire una ricerca gnoseologica sul problema della validità delle teorie. In questo modo però si esponeva alle abbondanti e inevitabili critiche dovute all'assenza di riflessività: questa rimane la spina nel fianco di qualsiasi teoria "sociologica" (ma già Baruch Spinoza ne abbozzò la legittimità) sulla conoscenza, in quanto basantesi sul principio opposto alla teoria filosofica della conoscenza, che attribuisce all'uomo facoltà conoscitive immutabili e universali (vedi Kant), e cioè sul radicamento delle possibilità del sapere nell'esserci. Grande influenza nella diffusione Sociologia della Conoscenza ebbe il sociologo Kurt Heinrich Wolff, per aver tradotto dal tedesco all'inglese, pubblicato e fatto conoscere negli Stati Uniti molti degli scritti di Karl Mannheim e di Georg Simmel. Nella contemporaneità il tema della conoscenza è ampiamente dibattuto in ottica transdisciplinare da autori quali Elinor Ostrom e Charlotte Hess. In riferimento alla definizione della sociologia della conoscenza essa va rapportata senz'altro alla ricerca di nessi che intercorrono tra le condizioni sociali, la situazione storica, i soggetti e gli elementi culturali a contenuto cognitivo che vengono elaborati dai soggetti stessi, laddove è evidente la ricerca della genesi sociale del sapere (Cfr. Guglielmo Rinzivillo, Natura e origine della sociologia della conoscenza in AAVV, Rassegna Storiografica Decennale, Limina Mentis, Villasanta (MB), 2018, p. 53 e sg, ISBN 978-88-99433-96-3).
La sociologia della comunicazione è quella branca della sociologia che studia nel dettaglio le implicazioni socio-culturali che nascono dalla mediazione simbolica, con particolare riguardo all'uso dei mezzi di comunicazione di massa. Essa studia dunque la radio, il cinema, la televisione, la stampa e, più recentemente, i nuovi media. Studiare i mezzi di comunicazione significa esaminare come lo stesso messaggio mediatico abbia, a seconda del contesto culturale, economico e sociale in cui viene ricevuto, conseguenze differenti sui gruppi sociali, come sui singoli individui che ne fanno parte (l'attenzione specifica sui singoli è rivolta maggiormente dalla psicologia sociale). In altre parole si analizzano i modi in cui il messaggio è trasmesso, le conseguenze della loro fruizione, le tecniche per una corretta comunicazione, nonché le modalità per riconoscere quando la comunicazione non è corretta.

Il suicidio. Studio di sociologia (titolo originale Le Suicide) è un saggio del sociologo francese Émile Durkheim. In esso l'autore implementa i principi metodologici che aveva precedentemente definito nel saggio Le regole del metodo sociologico. In questo libro difende l'idea che il suicidio sia un fatto sociale a sé stante - esercita sugli individui potere coercitivo ed esterno - e, in quanto tale, può essere analizzato dalla sociologia. Questo fenomeno, che si potrebbe pensare a prima vista causato da ragioni intime e psicologiche, è anche determinato da cause sociali. Le statistiche mostrano che il suicidio è un fenomeno sociale normale: è un fenomeno regolare presente in molte società e, all'interno di ciascuna società, i tassi di suicidio si evolvono relativamente poco: "Ciò che questi dati statistici esprimono è la tendenza al suicidio della quale ogni società è afflitta collettivamente". Durkheim prima tentò di identificare le cause del suicidio e quindi di proporre una serie di tipologie di suicidi, in base alle loro cause.