- Libri preferiti
Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti
Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti
Autore principale: Bernari, Carlo
Serie: C'era non c'era / collana diretta da Renato Minore
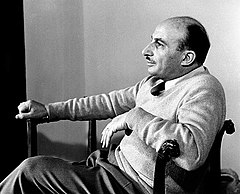
Carlo Bernari, pseudonimo di Carlo Bernard (Napoli, 13 ottobre 1909 – Roma, 22 ottobre 1992), è stato uno scrittore, antifascista e partigiano italiano.

Jacopo Robusti, secondo alcuni Jacopo Comin, detto Tintoretto (Venezia, settembre o ottobre 1518 – Venezia, 31 maggio 1594), è stato un pittore italiano, cittadino della Repubblica di Venezia e uno dei massimi esponenti della pittura veneta e dell'arte manierista in generale. Il soprannome "Tintoretto" gli derivò dal mestiere paterno, tintore di tessuti di seta. Per la sua energia fenomenale nella pittura è stato soprannominato Il furioso o il terribile come lo definì il Vasari per il suo carattere forte, e il suo uso drammatico della prospettiva e della luce lo ha fatto considerare il precursore dell'arte barocca.
Il Neorealismo è una corrente letteraria, i cui antecedenti possono rintracciarsi intorno al 1930 (Gli indifferenti, 1929, di Alberto Moravia e Tre operai, 1934, di Carlo Bernari), che esprime, valendosi di una drammatica rappresentazione analitica dell'esistenza umana, l'insofferenza per la vacuità delle convenzioni borghesi e la noia per una vita priva di senso.

Il neorealismo è stato un movimento culturale, nato e sviluppatosi in Italia durante il secondo conflitto mondiale e nell'immediato dopoguerra, che ha avuto dei riflessi molto importanti sul cinema contemporaneo (soprattutto negli anni compresi tra il 1943 e il 1955 circa). In ambito cinematografico i maggiori esponenti del movimento, sorto spontaneamente e non codificato, furono, negli anni quaranta, i registi Roberto Rossellini, Luchino Visconti, Vittorio De Sica, Giuseppe De Santis, Pietro Germi, Alberto Lattuada, Renato Castellani, Luigi Zampa, Alessandro Blasetti e gli sceneggiatori Cesare Zavattini e Sergio Amidei, cui si affiancheranno, nel decennio successivo, Luciano Emmer, Luigi Comencini, Gianni Puccini, Antonio Pietrangeli, Francesco Maselli, Carlo Lizzani e Francesco Rosi. In una posizione a sé stante si collocano Federico Fellini (per la cui cinematografia si conierà il termine di realismo magico e, successivamente, fantarealismo) e Michelangelo Antonioni, che inizialmente aderì al neorealismo con alcuni celebri documentari (fra cui Gente del Po del 1943/1947 e N. U. - Nettezza urbana, del 1948) e, in qualche misura, con il film Cronaca di un amore (1950), per poi prenderne le distanze nel corso degli anni cinquanta (il suo neorealismo venne inizialmente definito esistenzialismo dell'anima o anche esistenzialismo interiore). Il cinema neorealista è caratterizzato da trame ambientate in massima parte fra le classi disagiate e lavoratrici, con lunghe riprese all'aperto, e utilizza spesso attori non professionisti per le parti secondarie e a volte anche per quelle primarie. I film trattano soprattutto la situazione economica e morale del dopoguerra italiano, e riflettono i cambiamenti nei sentimenti e le condizioni di vita: speranza, riscatto, desiderio di lasciarsi il passato alle spalle e di cominciare una nuova vita, frustrazione, povertà, disperazione. Per una maggiore fedeltà alla realtà quotidiana, nei primi anni di sviluppo e di diffusione del neorealismo i film vennero spesso girati in esterno, sullo sfondo delle devastazioni belliche; d'altra parte, il complesso di studi cinematografici che era stato, dall'aprile del 1937, il centro della produzione cinematografica italiana, ossia Cinecittà, fu occupato nell'immediato dopoguerra dagli sfollati, risultando quindi temporaneamente indisponibile ai registi.

Antonio Gramsci, nome completo, così come registrato nell'atto di battesimo, Antonio Sebastiano Francesco Gramsci (Ales, 22 gennaio 1891 – Roma, 27 aprile 1937), è stato un politico, filosofo, politologo, giornalista, linguista e critico letterario italiano. Nel 1921 fu tra i fondatori del Partito Comunista d'Italia, divenendone esponente di primo piano e segretario dal 1924 al 1927, ma nel 1926 venne ristretto dal regime fascista nel carcere di Turi. Nel 1934, in seguito al grave deterioramento delle sue condizioni di salute, ottenne la libertà condizionata e fu ricoverato in clinica, dove trascorse gli ultimi anni di vita. Considerato uno dei più importanti pensatori del XX secolo e tra i massimi esponenti del marxismo occidentale, nei suoi scritti, tra i più originali della tradizione filosofica marxista, Gramsci analizzò la struttura culturale e politica della società. Elaborò in particolare il concetto di egemonia, secondo il quale le classi dominanti impongono i propri valori politici, intellettuali e morali a tutta la società, con l'obiettivo di saldare e gestire il potere intorno a un senso comune condiviso da tutte le classi sociali, comprese quelle subalterne.
Per guerra si intende un fenomeno sociale che ha il suo tratto distintivo nella violenza armata posta in essere fra gruppi organizzati. Nel suo significato tradizionale la guerra è un conflitto fra stati sovrani o coalizioni per la risoluzione, di regola in ultima istanza, di una controversia internazionale più o meno direttamente motivata da veri o presunti (ma in ogni caso parziali) conflitti di interessi ideologici ed economici. Il termine deriverebbe dalla parola werran dell'alto tedesco antico che significa mischia. Nel diritto internazionale, il termine è stato sostituito, subito dopo la seconda guerra mondiale, dall'espressione "conflitto armato", applicabile a scontri di qualsiasi dimensione e tipo. La guerra in quanto fenomeno sociale ha enormi riflessi sulla cultura, sulla religione, sull'arte, sul costume, sull'economia, sui miti, sull'immaginario collettivo, che spesso la cambiano nella sua essenza, esaltandola o condannandola. Le testimonianze archeologiche indicano che la guerra fa parte della vita umana da tempo immemorabile: secondo le teorie passate, si presumeva che i primi popoli nomadi (cacciatori-raccoglitori) fossero più pacifici rispetto ai loro omologhi sedentari (coltivatori) degli anni successivi, ma i ritrovamenti dei luoghi di sepoltura di massa in tutto il mondo hanno portato gli studiosi a rivedere questa teoria. Una sepoltura di massa a Jebel Sahaba (nota come Cimitero 117), nel Sudan settentrionale, per esempio, contiene i resti di 61 tra adulti e bambini; circa il 40% dei quali sono deceduti per morte violenta e mostrano gravi ferite o delle punte di freccia incastrate tra le ossa. Questo sito risale all' 11.740 a.C. circa.

Roma (AFI: /ˈroma/, ) è un comune italiano di 2 790 712 abitanti, capitale della Repubblica Italiana, nonché capoluogo dell'omonima città metropolitana e della regione Lazio. Si tratta del comune più popoloso d'Italia e il terzo dell'Unione europea dopo Berlino e Madrid, mentre con 1287,36 km² è il comune più esteso d'Italia e la quinta città più estesa d'Europa dopo Mosca, Istanbul, Londra e San Pietroburgo, nonché la prima dell'Unione europea. Dotata di un ordinamento amministrativo speciale, denominato Roma Capitale, disciplinato da una legge dello Stato, è inoltre il comune europeo con la maggiore superficie di aree verdi. Fondata secondo la tradizione il 21 aprile del 753 a.C. (sebbene scavi recenti nel Lapis niger farebbero risalire la fondazione a 2 secoli prima), nel corso dei suoi tre millenni di storia è stata la prima metropoli dell'umanità, cuore pulsante di una delle più importanti civiltà antiche, che influenzò la società, la cultura, la lingua, la letteratura, l'arte, l'architettura, l'urbanistica, l'ingegneria civile, la filosofia, la religione, il diritto e i costumi dei secoli successivi. Luogo di origine della lingua latina, fu capitale dell'Impero romano che estendeva il suo dominio su tutto il bacino del Mediterraneo e gran parte dell'Europa, dello Stato Pontificio, sottoposto al potere temporale dei papi e del Regno d'Italia (dal 1871 al 1946). Per antonomasia, è definita l'Urbe, Caput Mundi e Città eterna. Cuore della cristianità cattolica, è l'unica città al mondo ad ospitare al proprio interno un intero Stato, l'enclave della Città del Vaticano: per tale motivo è spesso definita capitale di due Stati. Il suo centro storico, delimitato dal perimetro delle mura aureliane, sovrapposizione di testimonianze di quasi tre millenni, è espressione del patrimonio storico, artistico e culturale del mondo occidentale europeo e, nel 1980, insieme alle proprietà extraterritoriali della Santa Sede nella città, è stato inserito nella lista dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO, provvedimento esteso nel 1990 ai territori compresi all'interno delle mura gianicolensi. Luogo di fondazione della Comunità economica europea e dell'Euratom, ospita anche le sedi di tre organizzazioni delle Nazioni Unite: l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) e il Programma alimentare mondiale (PAM).

Alessandro III di Macedonia (in greco antico: Ἀλέξανδρος Γ' ὁ Μακεδών, Aléxandros trίtos ho Makedόn), universalmente conosciuto come Alessandro Magno (Μέγας Ἀλέξανδρος, Mégas Aléxandros; Pella, ecatombeone - 20 o 21 luglio 356 a.C. – Babilonia, targelione - 10 o 11 giugno 323 a.C.), è stato un militare macedone antico, re di Macedonia della dinastia degli Argeadi a partire dal 336 a.C., succedendo al padre Filippo II. È noto anche come Alessandro il Grande, Alessandro il Conquistatore o Alessandro il Macedone. Il termine "magno" deriva dal latino magnus "grande", che traduce il termine greco antico μέγας (mégas). È considerato uno dei più celebri conquistatori e strateghi della storia. In soli dodici anni conquistò l'Impero persiano, un territorio immenso che si estendeva dall'Asia Minore all'Egitto fino agli attuali Pakistan, Afghanistan e India settentrionale. Tale straordinario successo fu dovuto sia a una congiuntura storica eccezionalmente favorevole (le crisi dell'Impero persiano e della Grecia delle poleis, unite all'opera espansionistica già incominciata dal padre) sia a una sua innegabile intelligenza militare e diplomatica. Dotato di grande coraggio e carisma, Alessandro aveva un forte ascendente sui suoi soldati, che spronava anche partecipando personalmente ai combattimenti. Inoltre, egli fu uno dei primi condottieri dell'antichità ad aver capito l'importanza fondamentale della propaganda, sia per guadagnare prestigio nelle proprie file, sia per incutere timore ai nemici. Per assicurarsi ciò, Alessandro costituì un'imponente macchina mediatica (si fece accompagnare per tutta la durata della sua campagna da una quantità di storici e redattori di diari giornalieri, tra cui il greco Callistene) e diede estrema importanza nel corso di tutta la spedizione a gesti di forte valenza simbolica e alla divulgazione di leggende sulla propria discendenza da eroi mitici (Eracle e Achille) o persino da vere e proprie divinità. Infine si sforzò in ogni modo di fondere e amalgamare le culture delle diverse etnie che abitavano le terre che si trovò a unificare sotto il suo impero, dimostrando una disposizione al sincretismo estremamente inusuale per un greco del suo tempo. Le sue innumerevoli conquiste diedero alla cultura greca una diffusione universale, dando così avvio al cosiddetto periodo ellenistico. Alessandro morì a Babilonia nel mese di daisios (targelione) del 323 a.C., forse avvelenato, forse per una recidiva della malaria che aveva contratto in precedenza o, secondo teorie più recenti, a causa di una cirrosi epatica provocata dall'abuso di vino o di pancreatite acuta. Dopo la morte del Conquistatore, l'Impero macedone fu suddiviso, non senza molti scontri e guerre, tra i generali che lo avevano accompagnato nelle sue spedizioni. Si costituirono così i cosiddetti regni ellenistici, tra cui quello Tolemaico in Egitto, quello degli Antigonidi in Macedonia e quello dei Seleucidi in Siria e in Asia Minore. L'eccezionalità del personaggio e delle sue imprese ispirò, già durante la vita ma ancor più dopo la sua morte, un gran numero di leggende (una famosa è quella della costruzione delle mitiche Porte di Alessandro) e una sterminata tradizione letteraria e figurativa, in cui il condottiero venne ritratto in sembianza di eroe (ad esempio è spesso scolpito nudo, un trattamento riservato, nella Grecia classica, esclusivamente agli dei o ai semidei). Nella ritrattistica è spesso assimilato ad Achille, di cui Alessandro stesso si considerava diretto discendente per parte di madre. I racconti storici sul suo conto hanno ben presto assunto colorazioni mitiche, ed è pertanto difficile discernere i fatti storici dalle rielaborazioni fantastiche. Le storie a lui riferite non si ritrovano solo nelle letterature occidentali: nella Bibbia (Primo libro dei Maccabei), ad esempio, si fa esplicito riferimento ad Alessandro, mentre nel Corano il misterioso Dhu al-Qarnayn (il Bicorne o letteralmente "quello dalle due corna") viene talvolta identificato, da alcuni, con il mitico conquistatore macedone senza però evidenze.

Luni (Ortonovo fino al 20 aprile 2017, Ortoneuvo in ligure, Ortnò nella variante locale) è un comune italiano sparso di 8 318 abitanti della provincia della Spezia in Liguria. La sede comunale è situata nella frazione di Casano. Confinante con la provincia di Massa-Carrara (comune di Carrara), in Toscana, è il comune ligure più orientale.
I Macedoni erano l'antico popolo che abitava nella regione storica della Macedonia, situata a nord dell'antica Tessaglia e confinante con l'Epiro ad ovest e la Tracia ad est. La loro origine etnica, sia essa ellenica o traco-illirica, è alquanto discussa (anche se gli antichi greci finirono per accettare la grecità dei macedoni, accettando la loro partecipazione alle olimpiadi, giochi panellenici, aperti dunque solo ai Greci), così come lo è l'appartenenza della lingua che, almeno inizialmente, parlavano. In ogni caso, furono poi assorbiti nella koinè greca in periodo ellenistico. La famiglia reale macedone, gli Argeadi, proclamava di essere di discendenza greca.

I Normanni (da Nordmanni o Nordmaenner, ossia "Uomini del Nord") erano un popolo nordeuropeo di origine danese e norvegese che diede il proprio nome alla Normandia, regione nel nord-ovest della Francia. Discendenti dai pirati, guerrieri e conti norreni che dopo varie scorrerie su suolo francese decisero di giurare fedeltà al re Carlo III dei Franchi occidentali in cambio di una vasta superficie territoriale nel nord della Francia (allora territorio dei Franchi occidentali), ultimamente il termine viene utilizzato per descrivere tutte le popolazioni scandinave del periodo che va dal IX al XII secolo. Il termine "Vichinghi", che è divenuto equivalente e sovrapponibile a Normanni, in realtà si riferisce a quella parte della popolazione che viveva nei fiordi, o che più genericamente si insediava in baie marittime naturali: vik dal norreno significa appunto "baia", dunque vik+ing = "genìa/stirpe delle baie". Ne deriva anche il significato di vik come toponimico: "accampamento", "cittadella", "colonia" (cf. p.es. Reykjavík, letteralmente "baia fumosa"; Aldwych; Lundenwic; Eoforwic; etc.). Nonostante fossero in prevalenza contadini, si dimostrarono grandi navigatori; senza bussola e carte di navigazione, raggiunsero infatti i territori delle Fær Øer, l'Islanda, la Groenlandia, il Labrador (normanni norvegesi), la Gran Bretagna (tranne il Galles; normanni dani) e, risalendo il corso di fiumi che avevano la foce nel Mar Baltico, la futura Russia e l'Ucraina (Rus' di Kiev; normanni svedesi o variaghi).

I Persiani (in persiano: فارسی زبانان, Fārsī zabānān) sono i membri di un gruppo etnico indoiranico (quindi della famiglia indoeuropea) che vive principalmente in Iran. Secondo il CIA World Factbook 2004, il 51% dell'attuale popolazione iraniana è di etnia persiana mentre la Biblioteca del Congresso porta la cifra al 65%. Diversi altri gruppi etnici sono rappresentati in Iran, tra cui il gruppo ariano non-persiano dei gilaki (che vivono nella provincia iraniana di Gilan); gli azeri e i turkmeni di discendenza turca, arabi, armeni, baluchi e altre minoranze.
Record aggiornato il: 2025-09-15T01:11:47.713Z