- Libri preferiti
Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti
Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

L'estrema destra è l'espressione che indica la posizione di un gruppo, movimento, partito politico o soggetto che si caratterizza per un'interpretazione massimalista e radicale dell'ideologia tipica della destra. Date le modifiche a cui è andato incontro il concetto di destra nel mondo e nella storia, anche il concetto di estrema destra è cambiato più volte. Per quanto riguarda l'Europa, all'origine, tra Settecento e Ottocento, s'identificavano come tali i fautori dell'assolutismo monarchico. Tuttavia, con lo svanire degli ideali assolutistici regi, il concetto finì per identificare posizioni reazionarie e ultraconservatrici in materia di diritti civili, politici e religiosi fino ad abbracciare tra Ottocento e Novecento gli ideali del militarismo, del razzismo e dell'ultranazionalismo. Con l'avvento del fascismo e del nazismo negli anni trenta del XX secolo, che pure dovevano molto alla destra radicale dei decenni precedenti, il concetto europeo di estrema destra si identificò quasi completamente con essi anche dopo la seconda guerra mondiale col fenomeno del neofascismo e del neonazismo. Negli Stati Uniti, invece, mancando completamente l'esperienza storica del fascismo e della monarchia, l'estrema destra identifica solitamente una visione radicale degli ideali del Partito Repubblicano, quali il conservatorismo e l'anti-socialismo.

La destra, nel parlamento, indica il settore dell’emiciclo che siede, per l'appunto, alla destra del Presidente. Per estensione, denota l'insieme dei parlamentari che occupano quel settore ed i gruppi politici (o i partiti) da esso rappresentati. Il significato politico di destra, nato insieme a quello di sinistra durante la Rivoluzione francese, ha subito molte variazioni a seconda dei tempi e dei Paesi, ma indica, in genere, un orientamento moderato, conservatore o, nelle sue punte più estreme, reazionario. Nel XX secolo, si sono detti di destra anche partiti praticanti metodi di eversione violenta, anti-liberali e, soprattutto, assertori dell'ultranazionalismo (fascismo, nazionalsocialismo ecc.).La destra rappresenta l'opinione che certe gerarchie e certi ordini sociali siano desiderabili, inevitabili, naturali o normali, tipicamente sostenendo questa posizione sulla base dell'economia, della legge naturale o della tradizione. La disuguaglianza sociale e la gerarchia possono essere viste come risultati naturali della concorrenza nelle economie di mercato o delle tradizionali differenze sociali. I termini politici destra e sinistra furono usati, per la prima volta, durante la Rivoluzione francese del XVIII secolo per indicare la disposizione dei posti a sedere nel Parlamento: coloro che sedevano a destra della sedia del presidente (le président) erano ampiamente favorevoli alle istituzioni dell'Antico Regime monarchico. La destra originale, in Francia, si formò come reazione contro la "sinistra" e comprendeva coloro che sostenevano il clericalismo, la gerarchia e la tradizione. L'espressione la droite ("la destra") aumentò in uso dopo la restaurazione della monarchia del 1815 quando fu applicata agli ultrarealisti. Dal 1830 al 1880, l'economia e la struttura della classe sociale del mondo occidentale si spostarono dall'aristocrazia e dalla nobiltà al capitalismo. Questo generale spostamento economico verso esso ha influenzato i movimenti di centro-destra, come il Partito conservatore britannico che ha risposto sostenendolo. Le persone dei Paesi di lingua inglese non hanno applicato i termini destra e sinistra alla propria politica fino al XX secolo. Il termine destra era, originariamente, applicato a conservatori tradizionali, monarchici e reazionari; un'estensione, l'estrema destra, denota fascismo, nazismo e supremazia razziale. In Europa, i conservatori economici sono solitamente considerati liberali e la destra include conservatori religiosi, nazionalisti, oppositori nativisti all'immigrazione e, storicamente, un numero significativo di movimenti con sentimenti anticapitalisti, inclusi conservatori e fascisti, che si opposero al capitalismo contemporaneo perché credevano che l'eccessivo materialismo e l'egoismo fossero intrinseci in esso. Negli Stati Uniti, la destra include conservatori sia economici che sociali.
Carmelo Briguglio (Furci Siculo, 23 giugno 1956) è un politico italiano.

Augustus Tolton (Brush Creek, 1º aprile 1854 – Chicago, 9 luglio 1897) è stato un presbitero statunitense, celebre per l'essere stato il primo prete cattolico nero degli Stati Uniti d'America. James Augustine Healy, ordinato nel 1854, e Patrick Francis Healy, ordinato nel 1864, erano infatti di razza mista. Ex schiavo battezzato e cresciuto nella fede cattolica, compì gli studi per il sacerdozio a Roma. Fu ordinato la domenica di Pasqua del 1886 nella basilica di San Giovanni in Laterano a Roma. Si incardinò nella diocesi di Alton - oggi diocesi di Springfield in Illinois - e prestò servizio nella sua parrocchia di origine a Quincy, nell'Illinois. In seguito operò a Chicago, dove guidò lo sviluppo e la costruzione della chiesa cattolica di Santa Monica come una "chiesa parrocchiale nazionale nera", completata nel 1893 all'incrocio della 36ª con Dearborn Streets nel South Side di Chicago.

L'attentato di via Rasella fu un'azione della Resistenza romana condotta il 23 marzo 1944 dai Gruppi di Azione Patriottica (GAP), unità partigiane del Partito Comunista Italiano, contro un reparto delle forze d'occupazione tedesche, l'11ª Compagnia del III Battaglione del Polizeiregiment "Bozen", appartenente alla Ordnungspolizei (polizia d'ordine) e composto da reclute altoatesine. Fu il più sanguinoso e clamoroso attentato urbano antitedesco in tutta l'Europa occidentale. L'azione, del cui ordine dopo la guerra si assunse la responsabilità Giorgio Amendola, fu compiuta da una dozzina di gappisti (tra cui Carlo Salinari, Franco Calamandrei, Rosario Bentivegna e Carla Capponi) e consistette nella detonazione di un ordigno esplosivo improvvisato al passaggio di una colonna di soldati in marcia e nel successivo lancio di quattro bombe a mano artigianali sui superstiti. Causò la morte di trentatré soldati tedeschi (non si hanno informazioni certe circa eventuali decessi tra i feriti nei giorni seguenti) e di due civili italiani (tra cui il dodicenne Piero Zuccheretti), mentre altre quattro persone caddero sotto il fuoco di reazione tedesco. Il 24 marzo, senza nessun preavviso, seguì la rappresaglia tedesca consumata con l'eccidio delle Fosse Ardeatine, in cui furono uccisi 335 prigionieri completamente estranei all'azione gappista, tra cui dieci civili rastrellati nelle vicinanze di via Rasella immediatamente dopo i fatti. Fin dalle prime reazioni, l'attentato è stato al centro di una lunga serie di controversie (anche in sede storiografica) sulla sua opportunità militare e legittimità morale, che lo hanno reso un caso paradigmatico della «memoria divisa» degli italiani. Nella lunga storia processuale dei fatti del marzo 1944, anche la legittimità giuridica dell'attentato è stata oggetto di valutazioni diverse: sul piano del diritto internazionale bellico è stato giudicato, da tutte le corti militari britanniche e italiane che hanno processato e condannato gli ufficiali tedeschi responsabili delle Fosse Ardeatine, un atto illegittimo in quanto compiuto da combattenti privi dei requisiti di legittimità previsti dalla IV Convenzione dell'Aia del 1907; sul piano del diritto interno italiano è stato invece considerato, in tutte le sentenze emesse sul caso da giudici civili e penali, un atto di guerra legittimo in quanto riferibile allo Stato italiano allora in guerra con la Germania. Tale riconoscimento di legittimità ebbe luogo, secondo l'interpretazione di alcune sentenze al riguardo proposta da alcuni autori, in forza di una legislazione successiva al compimento dell'attentato; secondo l'interpretazione delle medesime sentenze presentata da altri autori, l'attentato era da considerarsi legittimo anche al momento della sua attuazione. Le motivazioni dell'attentato sono diverse: secondo un'intervista resa nel 1946 dal gappista Rosario Bentivegna, «scuotere la popolazione, eccitarla in modo che si sollevasse contro i tedeschi»; secondo la deposizione di Giorgio Amendola al processo Kappler (1948), indurre i tedeschi al rispetto dello status di Roma città aperta smilitarizzando il centro urbano; secondo la Commissione storica italo-tedesca (2012), contrastare l'occupante e «scuotere la maggioranza della popolazione civile dallo stato di attesa passiva in cui versava». Tutte assai discusse, le motivazioni hanno costituito tra l'altro l'oggetto di una teoria del complotto che non ha trovato alcun riscontro né in sede storiografica né in sede giudiziale.

L'anarco-comunismo, chiamato anche comunismo anarchico, anarchismo comunista o comunismo libertario, è una corrente dell'anarchismo che, contestualmente all'instaurazione d'una società egualitaria e priva d'ordinamento statale alcuno (cioè l'anarchia), promuove l'abolizione totale del mercato quale sistema economico per l'allocazione di beni e servizi tramite la socializzazione dei mezzi di produzione e distribuzione e la pianificazione orizzontale ed autogestionaria dell'economia.
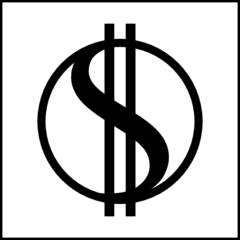
L'anarco-capitalismo, chiamato anche anarco-liberismo, anarchia di mercato, anarchia del libero mercato, capitalismo libertario o anarchismo della proprietà privata, è uno degli orientamenti della filosofia politica liberale e anarco-individualista (di area libertariana), e della filosofia giuridica giusnaturalista contemporanea, ed è presente principalmente nel mondo anglosassone, sebbene non manchino oggi importanti esponenti anarco-capitalisti tedeschi, francesi, italiani e di altre nazionalità. Si tratta di un'ideologia politica che propone l'abolizione dello Stato a favore della sovranità individuale sotto il libero mercato. Il principale riferimento intellettuale per l'anarco-capitalismo è l'opera dell'economista e filosofo della politica Murray Rothbard (1926 - 1995). Apparsa sulla scena statunitense nel corso degli anni sessanta, questa teoria politica propone l'instaurazione di una società priva di tassazione, dove ogni servizio venga offerto dai privati tramite spesa volontaria e nella quale sia eliminato ogni ricorso alla coercizione attraverso il superamento dello Stato, ritenuto intrinsecamente autoritario. L'anarco-capitalismo affonda le radici nella tradizione liberale e liberista, definendosi l'unica possibilità di dare un contenuto realistico e coerente alla proposta di abolire lo Stato e la violenza che è insita in esso.

L'anarchismo è definito come la filosofia politica applicata o il metodo di lotta alla base dei movimenti libertari volti fattualmente già dal XIX secolo al raggiungimento dell'anarchia come organizzazione societaria, teorizzante che lo Stato sia indesiderabile, non necessario e dannoso o in alternativa come la filosofia politica che si oppone all'autorità o all'organizzazione gerarchica nello svolgimento delle relazioni umane.I fautori dell'anarchismo, noti come anarchici, propongono società senza Stato basate sulle associazioni volontarie e non gerarchiche. Il termine inteso in senso politico venne inizialmente utilizzato dal girondino Jacques Pierre Brissot nel 1793, definendo negativamente la corrente politica degli enragés o arrabbiati, gruppo rivoluzionario radicale critico di ogni forma d'autorità. Nel 1840 con Pierre-Joseph Proudhon e il suo saggio Che cos'è la proprietà? (Qu'est-ce que la propriété ?) i termini anarchia e anarchismo assumeranno una connotazione positiva. Ci sono alcune tradizioni di anarchismo e sulla base della storia del movimento transitata attraverso il dibattito fine-ottocentesco dell'anarchismo senza aggettivi, alla fine del quale Errico Malatesta sintetizzò il concetto con la frase «Per conto mio non vi è differenza sostanziale, differenza di principi», non tutte si escludono vicendevolmente. Le scuole di pensiero anarchico possono differire tra loro anche in modo sostanziale, spaziando dall'individualismo estremo al totale collettivismo. Le tipologie di anarchismo sono state suddivise in due categorie, ovvero anarco-socialismo e anarco-individualismo, tuttavia compaiono anche altre suddivisioni basate comunque su classificazioni dualiste simili.L'anarchismo in quanto movimento sociale ha registrato regolarmente fluttuazioni di popolarità. La tendenza centrale dell'anarchismo a coniugarsi come movimento sociale di massa si è avuta con l'anarco-comunismo e con l'anarco-sindacalismo mentre l'anarco-individualismo è principalmente un fenomeno letterario, che tuttavia ha avuto un impatto sulle correnti più grandi. La maggior parte degli anarchici sostiene l'autodifesa o la nonviolenza (anarco-pacifismo) mentre alcuni anarchici hanno approvato l'uso di alcune misure coercitive, tra le quali la rivoluzione violenta e il terrorismo, per ottenere la società anarchica.

Altero Matteoli (Cecina, 8 settembre 1940 – Capalbio, 18 dicembre 2017) è stato un politico italiano, ministro dell'ambiente nei governi Berlusconi I, II e III e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nel Governo Berlusconi IV.