- Libri preferiti
Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti
Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti
Pubblicazione: [Cardiff : University college], 1974
Tipo di risorsa: testo, Livello bibliografico: seriale, Lingua: ita, eng, Paese: GB
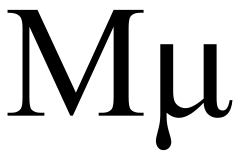
Il mi (Μ; μ) è la dodicesima lettera dell'alfabeto greco. È una consonante nasale bilabiale, diffusa come mu in ambito scientifico e tecnico. Nel sistema numerico dei greci d'età ellenistica, era il simbolo usato per il numero 40 (con un trattino in alto a destra; con un trattino in basso a sinistra, rappresentava invece il numero 40.000). Il nome della lettera, in greco antico, era μῦ, pronunciato classicamente /myː/. La trascrizione latina my corrispondeva, in età classica, alla pronuncia greca; col tempo, però, l'Y latina fu pronunciata /i/, sicché la lettera è stata trascritta in italiano come mi (questa trascrizione è usata nei licei classici e negli studi classici in genere). Il mi deriva dalla lettera fenicia mēm (presente anche nelle lingue semitiche moderne, per esempio la mīm araba, م), ed è stata a sua volta ripresa dall'alfabeto etrusco e successivamente da quello latino, così come dall'alfabeto cirillico.
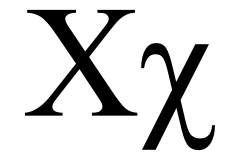
Chi (maiuscolo Χ; minuscolo χ) è la ventiduesima lettera dell'alfabeto greco. Ha un valore numerale di 600. Nell'alfabeto fonetico internazionale trascrive la consonante fricativa uvulare sorda /χ/. Se scritta in carattere minuscolo, il grafema della lettera chi (χ) si distingue dalla X dell'alfabeto latino, perché la lettera è scritta con gli estremi del tratto destro arrotondati, come si vede in figura a lato. La X latina equivale alla lettera Xi (csi; maiuscolo Ξ, minuscolo ξ) dell'alfabeto greco. Nel greco antico la "chi" era una consonante occlusiva velare aspirata /kh/. Nel greco moderno, davanti a vocali palatali e, i, y (pron. /i/) e i dittonghi ei, oi (pron. /i/) e ai (pron. /ɛ/) viene pronunciata come fricativa palatale sorda cioè il ch nel pronome tedesco ich o come alcuni varianti di 'h' nelle parole inglese 'hew' o 'human', ma davanti a vocali velari (a, o, ou) e consonanti, viene pronunciata come fricativa velare sorda cioè il ch nella parola tedesco ach o come nello scozzese loch. Questa lettera, e il suono che rappresenta, fanno anche parte dell'alfabeto calabrese meridionale: è presente in parole come χumara, fiumara; χaccari/χaccare, piegarsi e poche altre, di solito per rappresentare l'evoluzione del nesso latino "fl-". La sua presenza è dovuta sicuramente all'influsso greco bizantino del suo passato. Questo suono non è presente nella fonetica italiana Il Χ maiuscolo viene usato come simbolo: del nome di Gesù Cristo nella cristianità, come nel X-mas inglese.Il χ minuscolo viene usato come simbolo: della variabile casuale chi quadro o test chi quadrato in statistica. della suscettività elettrica (a volte con una e all'apice) e magnetica in fisica. del numero cromatico e dell'indice cromatico di un grafo nella teoria dei grafi. della caratteristica di Eulero nella topologia algebrica. della consonante fricativa uvulare sorda nell'alfabeto fonetico internazionale. Nel sistema numerico duodecimale, il numero 10 si chiama Dek ed il suo simbolo riprende una Chi minuscola ( χ {\displaystyle {\boldsymbol {\chi }}} ). χ {\displaystyle {\boldsymbol {\chi }}} è all'origine del nome della posizione chiastica, della figura retorica del chiasmo, del chiasma cromosomico e del chiasma ottico, struttura anatomica dell'encefalo a forma di X maiuscolo.
Le lettere di Paolo sono tredici testi del Nuovo Testamento attribuiti dalla tradizione all'apostolo Paolo di Tarso. In esse Paolo scrive a varie comunità da lui fondate o visitate nei suoi viaggi apostolici; alcune lettere sono inoltre dedicate a persone a lui care. In passato la Chiesa cattolica attribuì a Paolo di Tarso la Lettera agli Ebrei, nella quale non è indicato il nome dell'autore; tale lettera è oggi ritenuta, pressoché unanimemente, essere di un altro autore. Si sono inoltre conservate alcune lettere che affermano di essere state scritte da Paolo ma che sono ritenute apocrife dalla maggioranza degli esegeti.

Gamma (maiuscolo Γ, minuscolo γ; in greco: γάμμα; in latino: gamma) è la terza lettera dell'alfabeto greco.
Alla domanda da dove inizi veramente la poesia italiana del Novecento, molti critici letterari hanno dato differenti e contrastanti risposte in virtù, o a causa, della difficoltà nel tracciare una linea netta di demarcazione. Tuttavia la predominanza dei temi dell'Io, nell'intimismo di Giovanni Pascoli e nell'estetismo di Gabriele D'Annunzio segnarono un irreversibile cambiamento rispetto alla poesia "pubblica" e dichiarativa di Giosuè Carducci. La nuova poesia viene situata, perciò, da una parte della critica letteraria, nell'area che accoglie il linguaggio e i temi del decadentismo influenzato da entrambe le grandi figure del passaggio di secolo italiano. Più tardi le esperienze crepuscolari di Guido Gozzano, da un lato, e le opposte dei futuristi proseguono, accentuandole nella sperimentalità le due vie personaliste di Pascoli e D'Annunzio, identificando così una linea separatrice di frattura con la passata tradizione letteraria sia dal punto di vista delle tematiche, sia del linguaggio. La maggior parte della critica (secondo il criterio seguito fino alla fine degli agli anni cinquanta) stabilirà gli elementi innovativi della poesia del Novecento a partire da Giuseppe Ungaretti, seguendo una linea che condurrebbe dai "vociani" all'apertura della grande stagione degli "ermetici". E certamente è centrale nel cuore del '900 la vicenda dell'ermetismo segnata da figure di livello mondiale come Giuseppe Ungaretti ed Eugenio Montale. Altri ermetici importanti: Alfonso Gatto e Mario Luzi. Più appartata la scrittura di Corrado Govoni come, più tardi, le maggiori figure di Umberto Saba e Sandro Penna e con il suo musicale rimario Giorgio Caproni. Tra i temi più significativi della poesia del secondo Novecento, pur nell'estrema varietà che la caratterizza, è opportuno menzionare invece l'impegno sia etico sia civile, che nasce anche dalla meditazione dei mali e degli orrori della prima e soprattutto della seconda guerra mondiale; è prioritario riferirsi a Pier Paolo Pasolini, ad Edoardo Sanguineti a Roberto Roversi. Andrea Zanzotto autore di straordinaria cultura e intensa compartecipazione alla vicenda umana e al segno del decadere dell'ambiente, è stato un punto di contatto fra le maggiori figure del secolo. Salvatore Quasimodo, assurto a fama internazionale per l'assegnazione del Nobel, che più tardi andrà anche a Montale, attraversò diverse tonalità, dal lirismo classicheggiante ad un neorealismo di chiara testimonianza politica. Meno note ma certamente significative le figure di Elio Fiore e alla fine del Novecento di Gregorio Scalise e Davide Ferrari partiti da un riferimento alle avanguardie degli anni '60 e '70, poi capaci di svolgere una vena di più intensa riflessione sulle grandi prove della storia. Vicini a Pasolini, Dario Bellezza e Paolo Volponi; a Sanguineti, Elio Pagliarani, Nanni Balestrini e Giuseppe Guglielmi; ed a Saba, sia pure con un maggiore inserimento nel linguaggio poetico novecentesco, Giovanni Giudici. Autrice di continua produzione poetica, sempre legata all'immediata narrazione di un animo profondamente segnato dalle esperienze di vita, Alda Merini, poetessa particolarmente amata anche dal pubblico più vasto. Oggi la poesia italiana cade in una profonda crisi editoriale e di attenzione da parte del pubblico e, pur l'Italia il paese con il maggior numero di edizioni di genere, è il paese europeo dove si acquistano meno volumi di poesia in Europa. Segnaliamo la poesia di strada, come movimento di rinnovamento, contemporaneo e di rilancio per il grande pubblico della poesia italiana.
Alcune catalogazioni sono state accorpate perché sembrano descrivere la stessa edizione. Per visualizzare i dettagli di ciascuna, clicca sul numero di record
Record aggiornato il: 2026-01-25T03:21:30.099Z